Confondere scienza e verità assoluta crea l'illusione di essere al sicuro
Se dovesse in modo diretto e sintetico indicare l'aspetto più rilevante dell'epidemia che ci ha colpito quale termine utilizzerebbe?
«Non riesco a pensare a nulla di più appropriato del termine "imprevedibile". L'epidemia che ci ha colpito si è manifestata con la violenza dell'imprevedibile, è stata una vera e propria "irruzione dell'imprevedibile". Certo, non avevamo bisogno di questa tragica lezione per sapere che la nostra vita è continuamente attraversata dall'imprevedibile: l'infarto ci colpisce spesso all'improvviso, così come la foratura dello pneumatico dell'autovettura che ci porta al posto di lavoro avviene senza alcun preavviso; ci sono poi i terremoti, le alluvioni e gli infiniti incidenti, più o meno gravi, che affollano la quotidianità di ogni essere umano. Ma tutti questi eventi, proprio perché più o meno frequenti, sono degli imprevisti in qualche modo previsti, sono degli "imprevisti previsti" che in una certa misura fanno parte della contabilità che governa le nostre esistenze; in altre parole, come non a caso si usa dire, essi "sono messi in conto". Ma, a eccezione forse di alcuni virologi, perla stragrande maggioranza delle persone l'epidemia ha colpito come un evento del tutto e da tutti inatteso;inoltre e questo neppure i virologi sono riusciti a prevederlo essa si è sviluppata e poi diffusa non nel terzo e quarto mondo, o nelle periferie degradate delle megalopoli dell'America latina, e neppure in alcune città del nostro stesso Paese in cui le condizioni igieniche e la raccolta dei rifiuti sono ancora lontano dalla normalità, ma nel "primo mondo", in grandi nazioni tecnologicamente avanzate ed economicamente solide, in Cina e poi in Italia, più precisamente nel Nord ricco e industrioso, e infine in tutta Europa e poi nel mondo intero».
Lo scandalo dell’imprevedibile
Pensare l’epidemia
di Silvano Petrosino
editore: Interlinea
pagine: 80
«L’epidemia che ci ha colpito si è manifestata con la violenza dell’imprevedibile» eppure prevedere e decidere il proprio benessere è oggi tra le condizioni principali della nostra società. Uno dei filosofi attuali più lucidi riflette sul dramma del coronavirus a partire dalle parole che usiamo per spiegare questo evento e le sue conseguenze: perché il “futuro” è diverso dall’“avvenire”, il “mondo” dal “reale”, la “scienza” dagli “scienziati”, l’“ottimismo” dalla “speranza”, ma anche perché la modalità del “morire” ci ha atterrito più della “morte” in sé, fino a comprendere che l’autentica “libertà” non consiste nel fare ciò che si vuole. Come ci ha cambiato l’epidemia? Che cosa possiamo fare per non farci sopraffare? «dovremmo essere più seri nel vivere il tempo, che non è mai solo il “nostro tempo”, il tempo delle nostre “urgenze private”», afferma l’autore indicando un atteggiamento per il “dopo” e citando La peste di Camus: «bisogna restare, accettare lo scandalo, cominciare a camminare nelle tenebre e tentare di fare il bene».



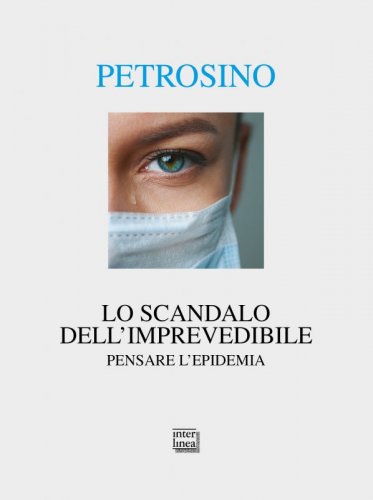


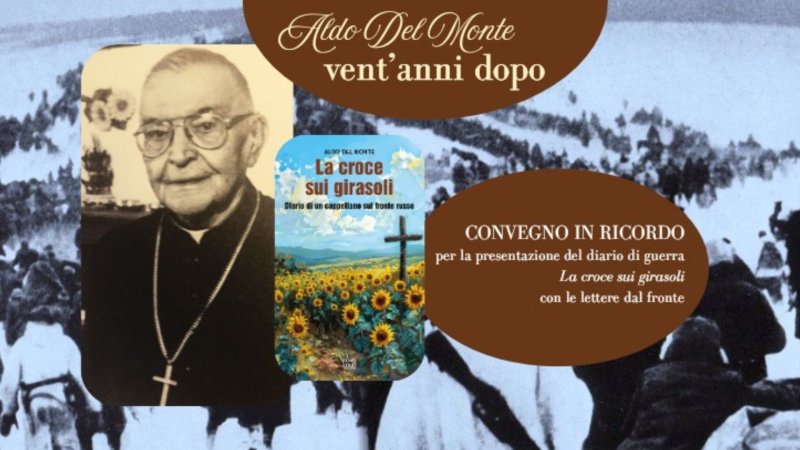
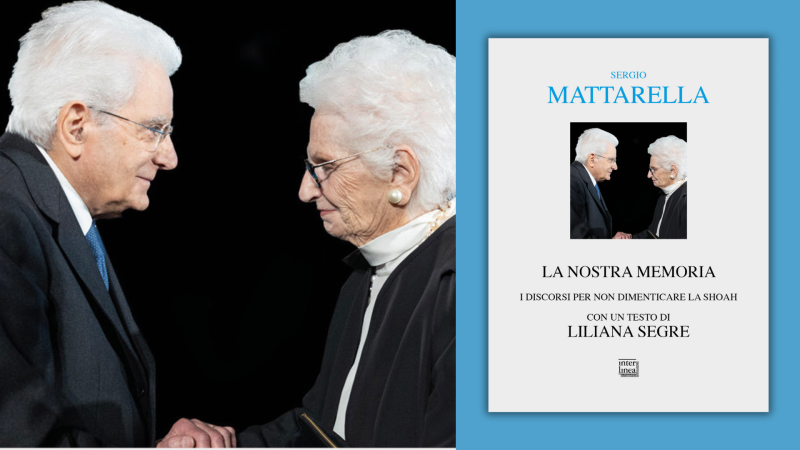
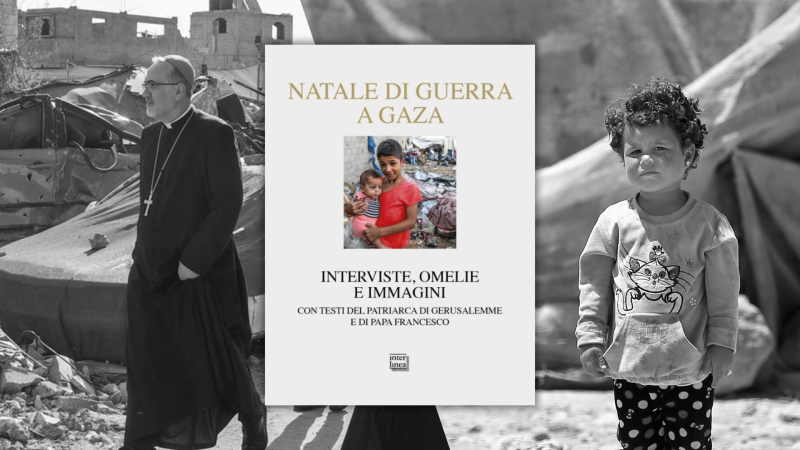



Inserisci un commento