Un commento di Giovanni Tesio, curatore dell’antologia 25 poesie per il 25 aprile.
La poesia che accompagna una data così significativa come il 25 aprile potrebbe esporsi all’enfasi, alla retorica, alla veemenza dichiarativa. E questo di fatto può accadere e accade. In altre parole in poesia non sempre l’occasione è esplicita ed è anzi più consueto che passi attraverso la via dell’allusività, ossia di un commento discreto, di di forte – e tanto più efficace – controllo emotivo.
Sono a volte compianti di momenti spietati, a volte sottolineature di passaggi cruciali, altre volte memoria di fatti vissuti, altre ancora lamenti legati a un’occasione, come ad esempio Giorgio Caproni che accompagna il suo testo con questa glossa: “L’occasione del Lamento V (Gli anni tedeschi), mi fu offerta da una veglia presso le salme di alcuni partigiani, mentre mi trovavo in una sconquassata casa di montagna accanto a quei morti sul nudo ammattonato e ad alcune donne che, con ostinazione maggiore dello sgomento, continuavano mute a cucire le bandierine dei distaccamenti”.
Ecco la poesia:
Quali lacrime calde nelle stanze?
Sui pavimenti di pietra una piaga
solenne è la memoria. E quale vaga
tromba – quale dolcezza erra di tante
stragi segrete, e nel petto propaga
l’armonioso sfacelo?… No, speranze
più certe son troncate sulle stanche
bocche dei morti. E non cada, non cada
con la polvere e gli aghi nelle bocche
dei morti una parola. La ferita
inferta, non risalderà la notte
sulle stanze squassate: è dura vita
che non vive nell’urlo in cui altra notte
geme – in cui vive intatta un’altra vita.
La lettura dà buon conto di questo avviso. Due domande iniziali in cui è ben individuabile la natura obliqua di una “retorica” indiretta. La “piaga solenne” della memoria, l’“armonioso sfacelo” che si propaga nel petto, a significare l’imperscrutabile ossimoro di ciò che vive nel drammatico e ad un tempo elegiaco commento. La “ferita” è inferta, ma lì dove pare che non ci sia se non “gemito”, un’“altra vita” vive “intatta”. Non nell’“urlo” in cui si raggruma il gemito di un’“altra notte” – quella della vita sacrificata – ma nell’integrità di quella vita “altra” che da quell’“altra notte” scaturisce.
Qui – se non fossimo aiutati dalla glossa necessaria di Caproni, l’interpretazione potrebbe indurre ad altre interpretazioni, cui il testo si presterebbe, e che nemmeno sarebbero di per sé fuorvianti. La natura polisemica della poesia – e di questa poesia di Caproni in particolare – attraverso la sua glossa ci consente di accostarci ad un testo in cui la morte partigiana – nel suo annuncio di vita nuova – non sarebbe di per sé remota dalla possibilità di essere interpretata anche come necessità di un sempre necessario rinnovamento interiore.
Resta che un testo come questo di Caproni è la più evidente conferma del fatto che il pathos della poesia cosiddetta civile possa passare per strade di più misterioso ma tanto più affascinante servizio.



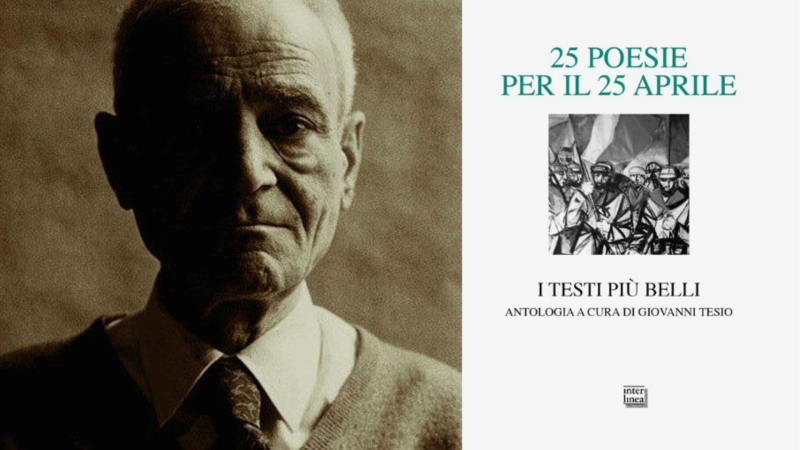
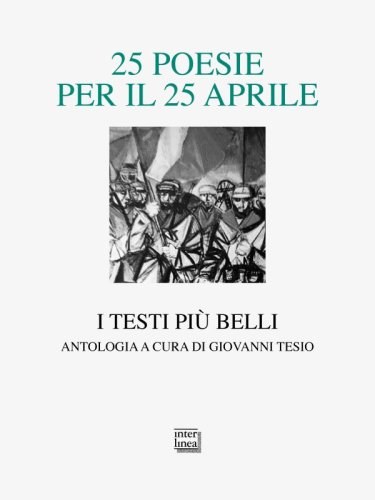


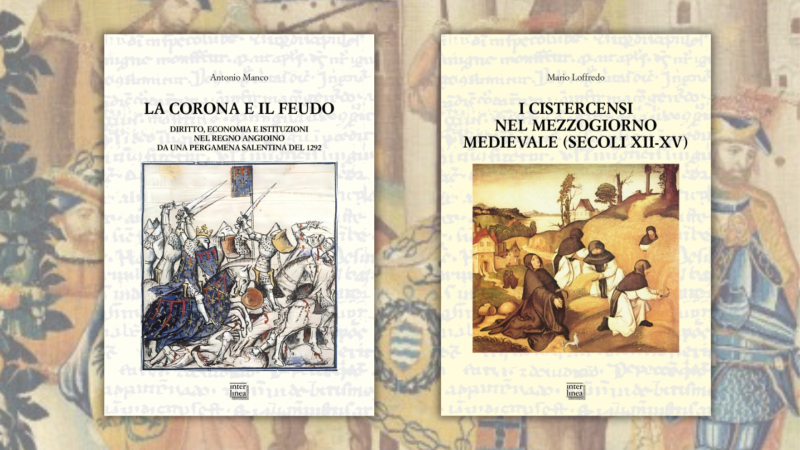
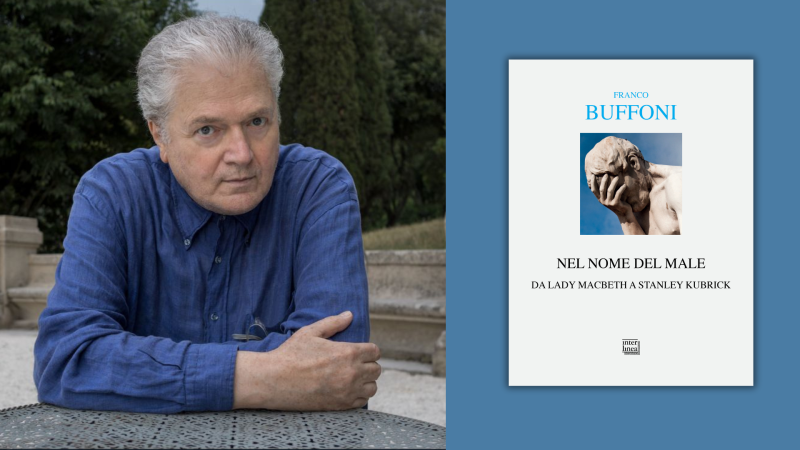
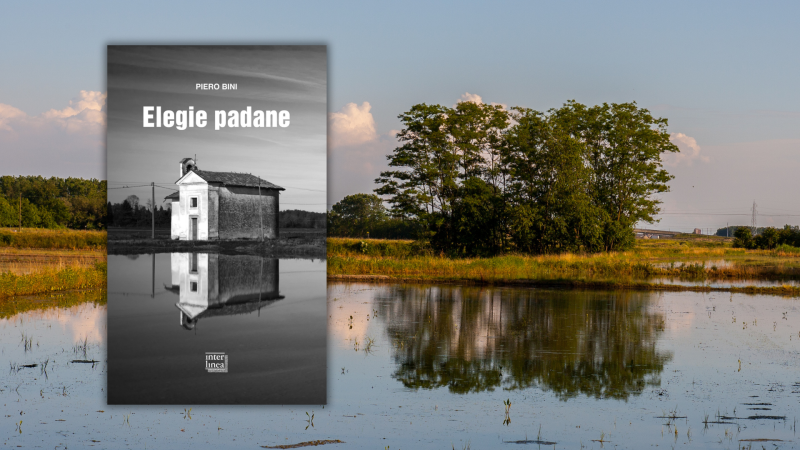
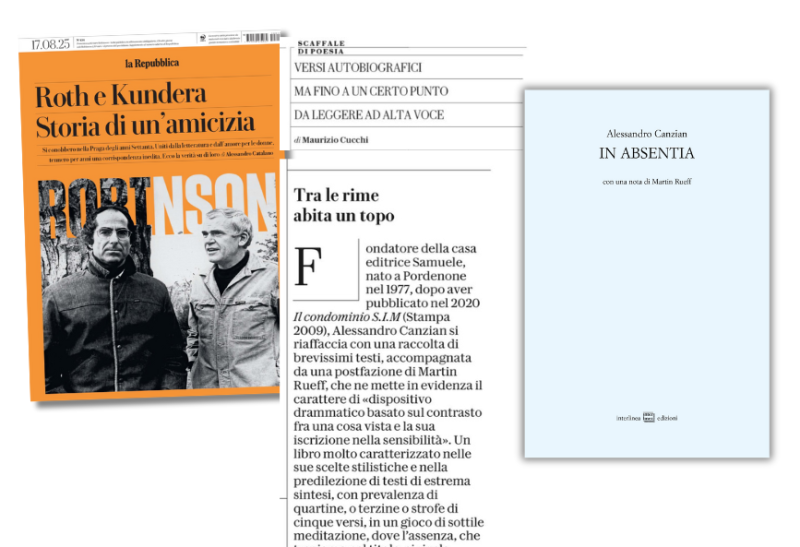


Inserisci un commento