«Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere» scrive Pennac, da cui partiamo per capire a che cosa servono i libri in un Paese dove le statistiche dicono che quasi sei persone su dieci non leggono. Che cosa si può fare? Un critico e studioso, Giovanni Tesio, autore di I più amati. Perché leggerli? Come leggerli?, ci accompagna nei motivi che rendono la lettura un’esperienza irrinunciabile, nell’interlinea della vita. Podcast di Roberto Cicala.



 Giovanni Tesio (1946), già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, ha pubblicato alcuni volumi di saggi (per Interlinea, nel 2014, La poesia ai margini e nel 2020 La luce delle parole), una biografia di Augusto Monti, una monografia su Piero Chiara, molte antologie. Ha curato per Einaudi la scelta dall’epistolario editoriale di Italo Calvino, I libri degli altri (1991); più recentemente la conversazione con Primo Levi, Io che vi parlo (2016), e più recentemente ancora, presso Interlinea, un altro volume di considerazioni su vita e opera di Levi, Primo Levi. Ancora qualcosa da dire (2018). Sempre presso Interlinea un pamphlet in difesa della lettura, della letteratura e della poesia, I più amati. Perché leggerli? Come leggerli? (2012), un “sillabario” intitolato Parole essenziali (2014), la raccolta di poesie Piture parolà (2018) e ha curato l’antologia Nell’abisso del lager (2019). La sua attività poetica, dopo esordi lontani, è sfociata nella pubblicazione di un canzoniere in piemontese di 369 sonetti, intitolato Vita dacant e da canté (Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, Torino 2017). È stato per trentacinque anni collaboratore della “Stampa”, al cui inserto, “Torinosette”, collabora tuttora. Del 2019, uscito presso Lindau, il suo primo libro narrativo, Gli zoccoli nell’erba pesante. Fa parte del comitato scientifico del Centro Novarese di Studi Letterari ed è tra i fondatori e direttori della collana di poesia “Lyra”.
Giovanni Tesio (1946), già ordinario di letteratura italiana presso l’Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, ha pubblicato alcuni volumi di saggi (per Interlinea, nel 2014, La poesia ai margini e nel 2020 La luce delle parole), una biografia di Augusto Monti, una monografia su Piero Chiara, molte antologie. Ha curato per Einaudi la scelta dall’epistolario editoriale di Italo Calvino, I libri degli altri (1991); più recentemente la conversazione con Primo Levi, Io che vi parlo (2016), e più recentemente ancora, presso Interlinea, un altro volume di considerazioni su vita e opera di Levi, Primo Levi. Ancora qualcosa da dire (2018). Sempre presso Interlinea un pamphlet in difesa della lettura, della letteratura e della poesia, I più amati. Perché leggerli? Come leggerli? (2012), un “sillabario” intitolato Parole essenziali (2014), la raccolta di poesie Piture parolà (2018) e ha curato l’antologia Nell’abisso del lager (2019). La sua attività poetica, dopo esordi lontani, è sfociata nella pubblicazione di un canzoniere in piemontese di 369 sonetti, intitolato Vita dacant e da canté (Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis, Torino 2017). È stato per trentacinque anni collaboratore della “Stampa”, al cui inserto, “Torinosette”, collabora tuttora. Del 2019, uscito presso Lindau, il suo primo libro narrativo, Gli zoccoli nell’erba pesante. Fa parte del comitato scientifico del Centro Novarese di Studi Letterari ed è tra i fondatori e direttori della collana di poesia “Lyra”.
I più amati Perché leggerli? Come leggerli? di Giovanni Tesio
Un'opera in difesa dei libri, della lettura, della letteratura, della poesia. Con una ricca proposta di citazioni sul tema. "Senza voler istituire ridicole affinità, ho provato quel piacere della lettura di cui parla Proust in un testo, "Journées delecture", che sta alle origini della recherche. Certo non posso paragonare il buon décor proustiano al mio, che era tanto più rustico e tanto meno agiato, ma capisco bene quando parla delle "incantevoli letture dell'infanzia, il cui ricordo deve restare per ciascuno di noi una benedizione". E che all'infanzia abbia per conto mio accostato anche un po' di adolescenza non cambia di fatto la memoria che conservo della mia lontana esperienza di lettore."
LEGGI L'ESTRATTO:
Premessa. perchè l'ho fatto?
Ho passato buona parte della mia vita a occuparmi di una materia strana che si chiama letteratura italiana. Perché l’ho fatto? Le risposte potrebbero essere tante, ma la prima (la più importante) è questa: perché non avrei saputo fare altro. Non che non avrei potuto fare altro, ma che non avrei saputo fare altro. Mi è sempre sembrato che niente come la letteratura avrebbe potuto interessarmi così a fondo.
Quando è cominciato tutto? Anche questo è difficile da dire. Ma è cominciato in un piccolo paese della pianura piemontese tra Pellice e Po, tra prati, campi e rii. È cominciato
con la scuola, con i primi abbecedari e libri di lettura, le prime figure di un mondo che mi si coloriva sotto gli occhi e che mi lasciava incantato.
Mi piacevano le storie ma mi piacevano di più le illustrazioni: gli inverni figurati mi commuovevano come dei mondi a parte, e tutta quella neve che si posava sulle pagine disegnava un luogo che nessun vero inverno vissuto era in grado di darmi.
Ho cominciato da lì – inconsapevolmente – a capire che avrei poi sempre aspirato a qualcos’altro che stava oltre la realtà che vivevo: il mondo di un altrove che non avrei saputo dire dove stesse né oggi saprei dire dove stia. Ho cominciato e capire – inconsapevolmente – che quelle figure mi trasportavano, mi trasferivano, mi facevano andare, mi costringevano a spostarmi perché mi conquistavano, mi rapivano, mi tiravano via.
Lo diceva anche Cesare Pavese, che in un suo testo intitolato Del mito, del simbolo e d’altro (raccolto nel libro Feria d’agosto) osserva:
I più amati Perché leggerli? Come leggerli? di Giovanni Tesio
Un'opera in difesa dei libri, della lettura, della letteratura, della poesia. Con una ricca proposta di citazioni sul tema. "Senza voler istituire ridicole affinità, ho provato quel piacere della lettura di cui parla Proust in un testo, "Journées delecture", che sta alle origini della recherche. Certo non posso paragonare il buon décor proustiano al mio, che era tanto più rustico e tanto meno agiato, ma capisco bene quando parla delle "incantevoli letture dell'infanzia, il cui ricordo deve restare per ciascuno di noi una benedizione". E che all'infanzia abbia per conto mio accostato anche un po' di adolescenza non cambia di fatto la memoria che conservo della mia lontana esperienza di lettore."
LEGGI L'ESTRATTO:
Premessa. perchè l'ho fatto?
Ho passato buona parte della mia vita a occuparmi di una materia strana che si chiama letteratura italiana. Perché l’ho fatto? Le risposte potrebbero essere tante, ma la prima (la più importante) è questa: perché non avrei saputo fare altro. Non che non avrei potuto fare altro, ma che non avrei saputo fare altro. Mi è sempre sembrato che niente come la letteratura avrebbe potuto interessarmi così a fondo.
Quando è cominciato tutto? Anche questo è difficile da dire. Ma è cominciato in un piccolo paese della pianura piemontese tra Pellice e Po, tra prati, campi e rii. È cominciato
con la scuola, con i primi abbecedari e libri di lettura, le prime figure di un mondo che mi si coloriva sotto gli occhi e che mi lasciava incantato.
Mi piacevano le storie ma mi piacevano di più le illustrazioni: gli inverni figurati mi commuovevano come dei mondi a parte, e tutta quella neve che si posava sulle pagine disegnava un luogo che nessun vero inverno vissuto era in grado di darmi.
Ho cominciato da lì – inconsapevolmente – a capire che avrei poi sempre aspirato a qualcos’altro che stava oltre la realtà che vivevo: il mondo di un altrove che non avrei saputo dire dove stesse né oggi saprei dire dove stia. Ho cominciato e capire – inconsapevolmente – che quelle figure mi trasportavano, mi trasferivano, mi facevano andare, mi costringevano a spostarmi perché mi conquistavano, mi rapivano, mi tiravano via.
Lo diceva anche Cesare Pavese, che in un suo testo intitolato Del mito, del simbolo e d’altro (raccolto nel libro Feria d’agosto) osserva:
Da bambini il mondo si impara a conoscerlo non – come parrebbe – con immediato e originario contatto alle cose, ma attraverso i segni di queste: parole, vignette, racconti. Proprio questo accadeva in me. Accadeva attraverso le figure, i racconti, i nomi evocativi di mondi lontani.
Lalla Romano ha raccontato la forza evocativa di quei nomi. Per lei era «Baltico», ad esempio. Per me era «brughiera». A lei «Baltico» evocava «lontananze indefinite, mari deserti e freddi, lunghi crepuscoli, e storie di gente aristocratica, segreta». A me «brughiera» evocava una vita selvaggia e misteriosa, una distesa di erbe e di sterpi, un fiorire improvviso di ranuncoli ed eriche, una commozione d’infinito.
«Poi», racconta ancora Lalla Romano, «mi incantò il titolo di una novella di Andersen […] che alludeva a una solitudine rischiosa e fatale, quasi disumana: nei mari estremi» (Nei mari estremi è il titolo di uno dei suoi libri più belli). È un’altra immagine che fa pensare a un incantesimo di nevi e di ghiacci, a qualcosa di simbolico che ci trasporta in un di là. Che è il “di là” dei mondi interiori: i più intimi, i più necessari.
E dunque quando sono diventato capace di leggere ho inseguito quei mondi che gli occhi – per primi – mi avevano indicato. Tanto le parole inseguono le figure e sono figure esse stesse. Cerchi, serpi, pance, alberi, farfalle, mucche, api, botti, cani e così via in un’infinita metamorfosi di segni e di colori.
C’era dentro alle parole una specie di calamita che mi tirava, mi attraeva e io mi ci appiccicavo con il gusto di una sanguisuga. Era ancora l’infanzia, il tempo magico di quel primo sguardo a cui tutti gli altri sguardi non potranno che essere secondi e, come tali, rivelatori. Qualcosa di analogo accade (o accade più che in altri libri suoi) anche in un libro di Umberto Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana. Qui c’è un adulto – il suo nome è Yambo, nome di per sé già abbastanza curioso – il quale ha perso la memoria, trovandosi improvvisamente nella
condizione regressiva di un bambino che incomincia a intravedere qualcosa del mondo perduto proprio grazie alle vignette di un fumetto di Disney, Il tesoro di Clarabella.
Poi sono venute altre stagioni e io diventavo più grande. Ma il gusto è rimasto, solo espandendosi in proporzione. In quel posto di acque e di fatiche dove ho fatto le scuole piccole, ho cominciato a leggere per conto mio, grazie a un cugino che stava in un paese vicino già avviato a diventare città e che abitava in una casa più prospera della mia. Un’intera biblioteca di classici adattati per ragazzi (dal Don Chisciotte al Davide Copperfield) o di scrittori tout court d’avventura: I pirati della Malesia, I figli del capitano Grant, L’isola del tesoro, Capitani coraggiosi, Zanna bianca. Per non dirne che alcuni.
I miei genitori erano contadini e non possedevano libri: solo dei calendari, un poco di radio, ma anche un grammofono e qualche disco di musica. Non si può dire che fossero ignoranti (si erano anche messi a prova di una loro ambizione cittadina), ma non erano certo “lettori”. Eppure diventai “lettore” lo stesso. Grazie a quel mio cugino che mi prestava dei “libri per ragazzi”: romanzi adulti che diventavano bambini, romanzi d’avventura che venivano ridotti, classici che venivano adattati. Un ben di Dio a cui mi sono dedicato quanto più ho potuto.
Ed è curioso, ma anche mio fratello, maggiore di me, che nella vita avrebbe fatto mestieri – parrebbe – incompatibili con la lettura (come coltivare la terra, guidare camion, fare l’autista) era diventato un lettore anche lui. E siamo persino riusciti a passarci qualche titolo (come dimenticare La selva del Tonto Rim o La valle delle sorprese di Zane Grey?) preso in prestito dalla biblioteca circolante che approdava anche al nostro paese a scadenze periodiche.
Niente di eccezionale (anche se lui al pascolo era riuscito ad affrontare un romanzo come Le vergini delle rocce di Gabriele D’Annunzio). Episodietti che testimoniano qualcosa di essenziale: che lo spuntare di una “vocazione” è un fenomeno misterioso, perché sembra sfuggire a ogni tentativo di cattura.
Forse trascuro un dato meno misterioso, che era l’idea di riscattarsi da una condizione sentita come chiusa: vivere dentro un mondo di gesti sempre uguali, di fatiche grosse, di stagionalità asfittiche, quali che siano poi le raffigurazioni nobilitanti che di quel mondo – e di quei cicli– siano state date in tempi di recupero. L’idea di un ego che non riusciva a concepirsi tutto quanto confinato in quel luogo, quantunque quel luogo sia stato – fin dal respiro primo – il mio luogo, il “luogo dei luoghi”.
Posso solo dire che – nonostante la povertà dei miei genitori – ho sempre e solo lavorato su libri nuovi, intonsi, non di “seconda mano”, ho sempre goduto del piacere di possedere il libro (anche se il primo libro in dono l’ho avuto solo ai miei diciott’anni: uno Shakespeare della Sansoni che fu proprio mio fratello a regalarmi).
Per mio conto avevo già impiantato una bibliotechina, ma era tutta fatta di libruzzi piccoli, dalla copertina grigiastra, che chiamavamo (così si chiamavano) “bur”, perché erano l’abbreviazione di una più lunga sigla editoriale (biblioteca universale rizzoli): una benedizione. Libri con cui si poteva scorrazzare come puledri inesperti ma ghiotti di tutto, un’esperienza che mai avrei più provato così forte e così randagia. E allora – mi sono detto oggi, che ho un’età ormai quasi veneranda – vediamo in che cosa può consistere questo prodigio della lettura.
Nasce da qui il desiderio di parlarne in modo un poco più ordinato e composto.
Non senza ricordarmi di dichiarare qui – sia pure tardivamente – ancora una gratitudine (quante sono nella vita le persone che hanno inciso sul nostro modo di vedere e vivere la vita? Persone a cui molto dobbiamo e a cui non siamo riusciti mai a dire il nostro grazie più profondo?).
Una persona di importanza per me decisiva è stato un medico-umanista, il medico condotto di un paese vicino al mio, che mi ebbe in cura per una lunga degenza dovuta a una pleurite ostinata. Nei sei mesi in cui fui costretto a letto, fu lui ad alimentare la mia voracità di lettore, a riempire i miei vuoti con libri fondamentali. Lui a portarmi un titolo dopo l’altro, con sapiente strategia.
Fu in quei mesi che lessi Dostoevskij (da Umiliati e offesi ai Karamazov, da Delitto e castigo e L’idiota alle Memorie del sottosuolo), Tolstoj (Guerra e pace, Anna Karenina, Resurrezione), Goncˇarov (Oblomov), Gogol’ (Le anime morte), Stendhal (Il rosso e il nero e La Certosa di Parma), Flaubert (Madame Bovary e L’educazione sentimentale, ma anche i Tre racconti), molti romanzi di Balzac, di cui ricordo – non saprei dire perché – soprattutto la commozione che provai alla lettura del Giglio della valle.
D’altra parte non ero un lettore avveduto, ma un sedicennemosso da emozione. Probabilmente è questa la ragione per cui di Dostoevskij mi colpì di più Umiliati e offesi che L’idiota (ma sarà per sempre Alioscia, così traslitterato nella traduzione che lessi io dei Karamazov, il mio personaggio prediletto; in combutta, se mai, con Pierre Besukov di Guerra e pace). Una popolosa cittadella in cui forgiavo il mio gusto di lettore e in cui forse toccavo vertici di ingenuità emotiva, che la “maturità” – caricandomi di tanta maggiore consapevolezza critica – mi ha a poco a poco attenuato o addirittura sottratto.
Senza voler istituire ridicole affinità, ho provato in quel periodo – più che in ogni altro mi sia poi capitato di riprovare – quel piacere della lettura di cui parla Proust in un testo, Journées de lecture, che sta alle origini della Recherche. Certo non posso paragonare il buon décor proustiano al mio, che era tanto più rustico e tanto meno agiato, ma capisco bene quando parla delle «incantevoli letture dell’infanzia, il cui ricordo deve restare per ciascuno di noi una benedizione». E che poi all’infanzia abbia per conto mio accostato anche un po’ di adolescenza
non cambia di fatto la memoria che conservo della mia lontana esperienza di lettore.
Lalla Romano ha raccontato la forza evocativa di quei nomi. Per lei era «Baltico», ad esempio. Per me era «brughiera». A lei «Baltico» evocava «lontananze indefinite, mari deserti e freddi, lunghi crepuscoli, e storie di gente aristocratica, segreta». A me «brughiera» evocava una vita selvaggia e misteriosa, una distesa di erbe e di sterpi, un fiorire improvviso di ranuncoli ed eriche, una commozione d’infinito.
«Poi», racconta ancora Lalla Romano, «mi incantò il titolo di una novella di Andersen […] che alludeva a una solitudine rischiosa e fatale, quasi disumana: nei mari estremi» (Nei mari estremi è il titolo di uno dei suoi libri più belli). È un’altra immagine che fa pensare a un incantesimo di nevi e di ghiacci, a qualcosa di simbolico che ci trasporta in un di là. Che è il “di là” dei mondi interiori: i più intimi, i più necessari.
E dunque quando sono diventato capace di leggere ho inseguito quei mondi che gli occhi – per primi – mi avevano indicato. Tanto le parole inseguono le figure e sono figure esse stesse. Cerchi, serpi, pance, alberi, farfalle, mucche, api, botti, cani e così via in un’infinita metamorfosi di segni e di colori.
C’era dentro alle parole una specie di calamita che mi tirava, mi attraeva e io mi ci appiccicavo con il gusto di una sanguisuga. Era ancora l’infanzia, il tempo magico di quel primo sguardo a cui tutti gli altri sguardi non potranno che essere secondi e, come tali, rivelatori. Qualcosa di analogo accade (o accade più che in altri libri suoi) anche in un libro di Umberto Eco, La misteriosa fiamma della regina Loana. Qui c’è un adulto – il suo nome è Yambo, nome di per sé già abbastanza curioso – il quale ha perso la memoria, trovandosi improvvisamente nella
condizione regressiva di un bambino che incomincia a intravedere qualcosa del mondo perduto proprio grazie alle vignette di un fumetto di Disney, Il tesoro di Clarabella.
Poi sono venute altre stagioni e io diventavo più grande. Ma il gusto è rimasto, solo espandendosi in proporzione. In quel posto di acque e di fatiche dove ho fatto le scuole piccole, ho cominciato a leggere per conto mio, grazie a un cugino che stava in un paese vicino già avviato a diventare città e che abitava in una casa più prospera della mia. Un’intera biblioteca di classici adattati per ragazzi (dal Don Chisciotte al Davide Copperfield) o di scrittori tout court d’avventura: I pirati della Malesia, I figli del capitano Grant, L’isola del tesoro, Capitani coraggiosi, Zanna bianca. Per non dirne che alcuni.
I miei genitori erano contadini e non possedevano libri: solo dei calendari, un poco di radio, ma anche un grammofono e qualche disco di musica. Non si può dire che fossero ignoranti (si erano anche messi a prova di una loro ambizione cittadina), ma non erano certo “lettori”. Eppure diventai “lettore” lo stesso. Grazie a quel mio cugino che mi prestava dei “libri per ragazzi”: romanzi adulti che diventavano bambini, romanzi d’avventura che venivano ridotti, classici che venivano adattati. Un ben di Dio a cui mi sono dedicato quanto più ho potuto.
Ed è curioso, ma anche mio fratello, maggiore di me, che nella vita avrebbe fatto mestieri – parrebbe – incompatibili con la lettura (come coltivare la terra, guidare camion, fare l’autista) era diventato un lettore anche lui. E siamo persino riusciti a passarci qualche titolo (come dimenticare La selva del Tonto Rim o La valle delle sorprese di Zane Grey?) preso in prestito dalla biblioteca circolante che approdava anche al nostro paese a scadenze periodiche.
Niente di eccezionale (anche se lui al pascolo era riuscito ad affrontare un romanzo come Le vergini delle rocce di Gabriele D’Annunzio). Episodietti che testimoniano qualcosa di essenziale: che lo spuntare di una “vocazione” è un fenomeno misterioso, perché sembra sfuggire a ogni tentativo di cattura.
Forse trascuro un dato meno misterioso, che era l’idea di riscattarsi da una condizione sentita come chiusa: vivere dentro un mondo di gesti sempre uguali, di fatiche grosse, di stagionalità asfittiche, quali che siano poi le raffigurazioni nobilitanti che di quel mondo – e di quei cicli– siano state date in tempi di recupero. L’idea di un ego che non riusciva a concepirsi tutto quanto confinato in quel luogo, quantunque quel luogo sia stato – fin dal respiro primo – il mio luogo, il “luogo dei luoghi”.
Posso solo dire che – nonostante la povertà dei miei genitori – ho sempre e solo lavorato su libri nuovi, intonsi, non di “seconda mano”, ho sempre goduto del piacere di possedere il libro (anche se il primo libro in dono l’ho avuto solo ai miei diciott’anni: uno Shakespeare della Sansoni che fu proprio mio fratello a regalarmi).
Per mio conto avevo già impiantato una bibliotechina, ma era tutta fatta di libruzzi piccoli, dalla copertina grigiastra, che chiamavamo (così si chiamavano) “bur”, perché erano l’abbreviazione di una più lunga sigla editoriale (biblioteca universale rizzoli): una benedizione. Libri con cui si poteva scorrazzare come puledri inesperti ma ghiotti di tutto, un’esperienza che mai avrei più provato così forte e così randagia. E allora – mi sono detto oggi, che ho un’età ormai quasi veneranda – vediamo in che cosa può consistere questo prodigio della lettura.
Nasce da qui il desiderio di parlarne in modo un poco più ordinato e composto.
Non senza ricordarmi di dichiarare qui – sia pure tardivamente – ancora una gratitudine (quante sono nella vita le persone che hanno inciso sul nostro modo di vedere e vivere la vita? Persone a cui molto dobbiamo e a cui non siamo riusciti mai a dire il nostro grazie più profondo?).
Una persona di importanza per me decisiva è stato un medico-umanista, il medico condotto di un paese vicino al mio, che mi ebbe in cura per una lunga degenza dovuta a una pleurite ostinata. Nei sei mesi in cui fui costretto a letto, fu lui ad alimentare la mia voracità di lettore, a riempire i miei vuoti con libri fondamentali. Lui a portarmi un titolo dopo l’altro, con sapiente strategia.
Fu in quei mesi che lessi Dostoevskij (da Umiliati e offesi ai Karamazov, da Delitto e castigo e L’idiota alle Memorie del sottosuolo), Tolstoj (Guerra e pace, Anna Karenina, Resurrezione), Goncˇarov (Oblomov), Gogol’ (Le anime morte), Stendhal (Il rosso e il nero e La Certosa di Parma), Flaubert (Madame Bovary e L’educazione sentimentale, ma anche i Tre racconti), molti romanzi di Balzac, di cui ricordo – non saprei dire perché – soprattutto la commozione che provai alla lettura del Giglio della valle.
D’altra parte non ero un lettore avveduto, ma un sedicennemosso da emozione. Probabilmente è questa la ragione per cui di Dostoevskij mi colpì di più Umiliati e offesi che L’idiota (ma sarà per sempre Alioscia, così traslitterato nella traduzione che lessi io dei Karamazov, il mio personaggio prediletto; in combutta, se mai, con Pierre Besukov di Guerra e pace). Una popolosa cittadella in cui forgiavo il mio gusto di lettore e in cui forse toccavo vertici di ingenuità emotiva, che la “maturità” – caricandomi di tanta maggiore consapevolezza critica – mi ha a poco a poco attenuato o addirittura sottratto.
Senza voler istituire ridicole affinità, ho provato in quel periodo – più che in ogni altro mi sia poi capitato di riprovare – quel piacere della lettura di cui parla Proust in un testo, Journées de lecture, che sta alle origini della Recherche. Certo non posso paragonare il buon décor proustiano al mio, che era tanto più rustico e tanto meno agiato, ma capisco bene quando parla delle «incantevoli letture dell’infanzia, il cui ricordo deve restare per ciascuno di noi una benedizione». E che poi all’infanzia abbia per conto mio accostato anche un po’ di adolescenza
non cambia di fatto la memoria che conservo della mia lontana esperienza di lettore.



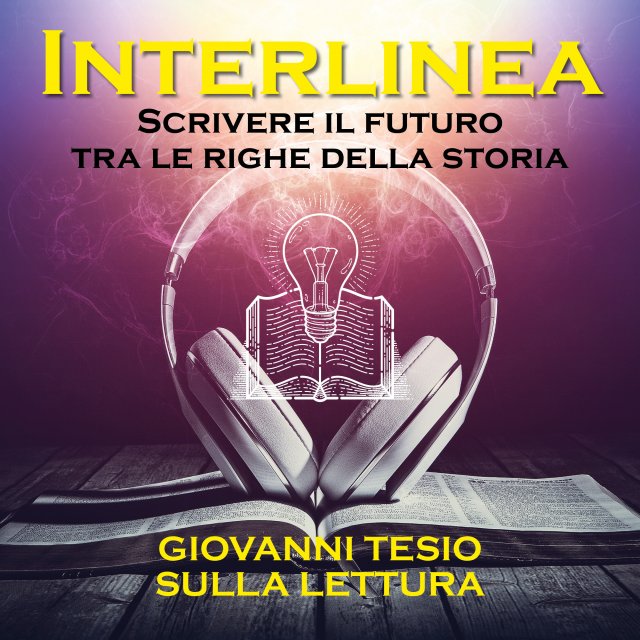



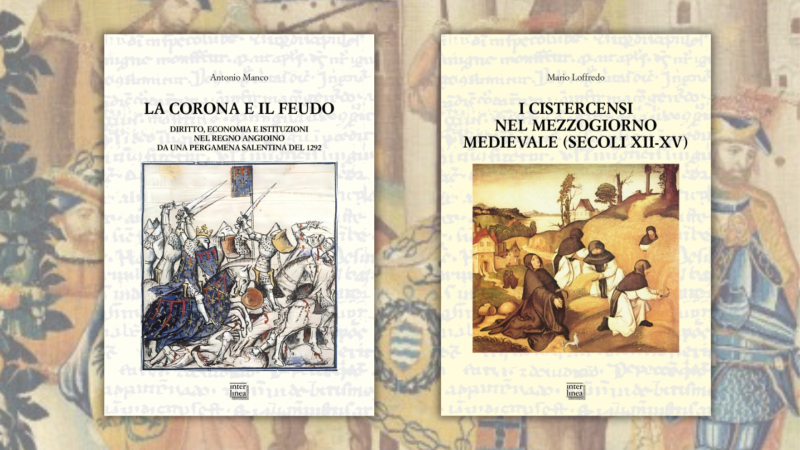
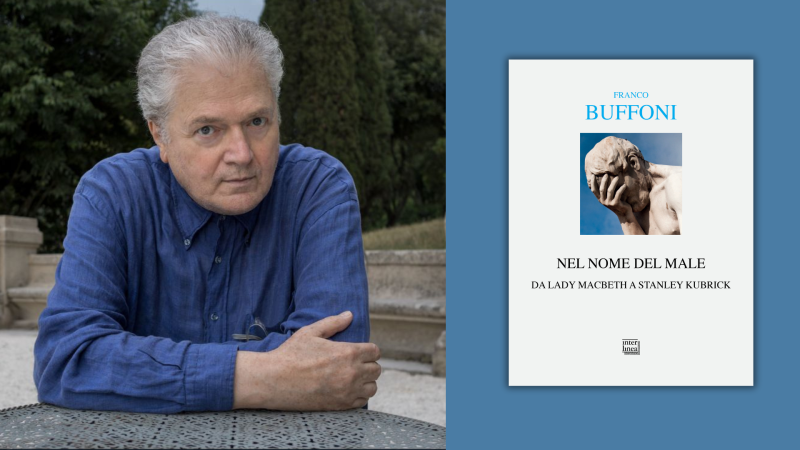
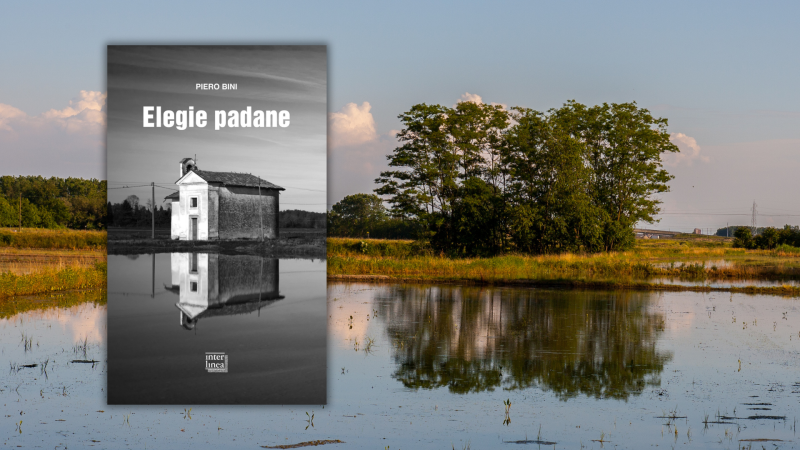



Inserisci un commento