Di seguito un estratto dal volume:
ARBASINO: LA COERENZA DELLA COMPLESSITÀ
di Clelia Martignoni
Senz’altro Fratelli d’Italia ha nel lavoro di Alberto Arbasino non solo un deciso rilievo ma anche e soprattutto una forte centralità, confermata dalla trentennale revisione (alla prima edizione del 1963 succede quella rielaboratissima del 1976, con ulteriore riscrittura nel 1993). Su Fratelli d’Italia, sui suoi segreti compositivi, sulla sua complessa evoluzione negli anni, si concentrano i saggi che seguono, di due giovanissime pavesi, Cinzia Lucchelli ed Elisabetta Cammarata, che si sono applicate all’analisi delle varie stampe, anche alla luce dei materiali preparatori donati da Arbasino al Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia.
Ma prima di affrontare la questione di che cosa il romanzo rappresenti nella storia di Arbasino, è bene sottolineare che la sua complessiva carriera, anche se fortunatamente ricca e multiforme, si segnala per la singolare coerenza non sempre, credo, sottolineata a dovere. Una serie di invarianti tematico-formali ne connette organicamente il sistema conferendogli spiccata unità, sia sul piano sincronico sia su quello diacronico. Si va infatti dagli eleganti ma ancora incerti racconti del libro d’esordio, Le piccole vacanze (’57, ’59, ’71), e, attraverso il passaggio chiarificatore dell’Anonimo lombardo (del 1959, con progressive revisioni sino al ’96), si arriva al massimo raggiungimento narrativo di Fratelli d’Italia, cui si affiancano non solo altri interessanti esperimenti di racconto e romanzo, ma anche parecchia eccellente produzione che per comodità di definizione si chiamerà sinteticamente “saggistica” ma di più complessa fattura e svariante in numerosi settori, tuttavia sempre intimamente omogenea. Ecco il punto: con grande lucidità e autoconsapevolezza, da certi anni in avanti (e proprio più radicalmente a partire dall’esperienza chiave di Fratelli d’Italia), Arbasino ha lavorato a congiungere e fare interagire nella sua opera attitudini e registri diversi, cercando in particolare una produttiva combinazione tra invenzione narrativa e talento “saggistico”, e realizzandola in sofisticate forme da lui abitualmente
dette, con richiamo ad Adorno, di «critica della cultura». Dal nodo risolutivo (si dirà perché) del primo Fratelli d’Italia, Arbasino si è attrezzato per fornire via via una analisi-testimonianza spregiudicata e documentatissima, tra cultura società costume, del nostro secondo Novecento, dagli anni del boom a oggi. Nella rara (e mobile) integrazione tra estro narrativo e criticità Arbasino ha trovato la sua personalissima identità di scrittore: dove il narratore che racconta, divaga, rappresenta, reinventa, sta di fianco al critico della cultura, di memoria adorniana (ovviamente i riferimenti ad Adorno, come a Kraus, come al non meno amato Praz, sono preziosi ma parziali e non spiegano l’insieme), o persino all’antropologo. Dall’intreccio di queste componenti scatta l’interpretazione, smagliante e feroce, di un’epoca e di una società. E non conta che di volta in volta l’elemento narrativo-creativo sia esteso o frammentato, svolto in forme romanzesche o in serie di aneddoti, o anche scheggiato in aforismi, caso quest’ultimo che connota in particolare il più recente prodotto arbasiniano, Paesaggi italiani con zombi, ’98. Ma s’intende, e resta fondamentale: la rappresentazione è artistica, quantunque provvista di amara e ilare verità. Arbasino vi devolve un’esperienza ricchissima di lettore/viaggiatore/osservatore ossessivamente curioso di tutto, e una memoria non meno straordinaria e puntigliosa.
Di testo in testo le strutture vengono rinnovate e modificate anche notevolmente, grazie alle proporzioni dissimili degli ingredienti in gioco: a seconda del genere-base selezionato. Così si vede in alcuni libri la prevalenza dell’intreccio romanzesco o la sperimentazione di alcune tecniche di racconto. Infatti il catalogo stesso dei prodotti “narrativi” presenta al suo interno formule variate. Semplificando: dopo l’articolato congegno di Fratelli d’Italia, si pensi agli azzardi linguistici specializzatissimi del dittico La narcisata – La controra, ai colti e grotteschi meccanismi di Super-Eliogabalo e Il principe costante (due riscritture di area differentissima), e di Specchio delle mie brame; alla favola “realistica” e fittiziamente tradizionale della Bella di Lodi, maliziosa «operazione pop» (Guglielmi). Ma altrove predomina il tipo della recensione teatrale (l’esempio più ricco: Grazie per le magnifiche rose), o più in generale artistica (Il meraviglioso, anzi); o del resoconto di viaggio (Trans-Pacific Express, Mekong, Passeggiando tra i draghi addormentati); oppure anche l’epigramma e lo scherzo poetico (Matinée). In altri casi, le categorie si confondono più facilmente, tanto da non rendere agevole l’indicazione di quella dominante: penso soprattutto alla densità delle ricognizioni civili-culturali-politiche (al vertice: Un paese senza, con l’addizione, ora, dello zibaldone fine millennio Paesaggi italiani con zombi), e alle pluriprospettiche indagini letterarie-artistiche, bilanciate tra testimonianza personale e ricostruzione critica (Parigi o cara, Certi romanzi, Sessanta posizioni, Fantasmi italiani). È, appunto, questione di dosaggio e di asse testuale privilegiato. La strategia di base in ogni caso resta in piedi, e alla sua sagace e tenace individuazione si deve la suddetta coerenza del sistema. Con l’avvertenza, che mi pare essenziale, che Arbasino appartiene alla famiglia saturnina dei manieristi e degli irregolari (indagata nella sua tradizione europea nel celebre saggio di Hocke del ’59). L’irregolarità di fondo (che vuol dire enciclopedismo, catalogo, accumulo, ossessione del dettaglio, paradosso, passione vebale) è gestita da Arbasino con sorvegliatissimo rigore: da cui anche il fascino della sua scrittura.
In estrema sintesi, i fattori fissi delle molteplici operazioni di Arbasino si possono così indicare: infinita curiosità, scintillante e amara capacità di osservazione e diagnosi senza tenerezze; genio umoristico espresso in gamme molto estese (ironia, parodia, satira, scherno, grottesco); un imponente apparato di riferimenti, citazioni, allusioni culturali, dove tutte le arti, alte, povere, minime, d’élites e popolari, di ogni epoca e dei più vari paesi, sono convocate a prestare materiali disparati per grandi accumuli e accostamenti; predilezione netta verso forme ibride, di contaminazione fantasiosa (che vedremo); e verso strutture tendenzialmente divaganti, aperte, frammentarie.
Con queste premesse, si capisce perché durante la sua lunga carriera, dotata anche di precisione auto-esegetica, Arbasino, avendo già alle spalle la prova cruciale di Fratelli d’Italia e a essa connettendosi, abbia definito «romanzo critico», apparentemente a sorpresa, la raccolta di recensioni teatrali Grazie per le magnifiche rose (1965), certo nell’intento di sottolinearne la commistione di registri e in particolare la presenza di estri narrativi in ambito tradizionalmente saggistico. Analogamente a proposito di Un paese senza (del 1980 la prima edizione, rielaborata ampiamente nel ’90), Arbasino ha usato la stessa etichetta di «romanzo-conversazione» con cui aveva qualificato Fratelli d’Italia (felicemente imperniato sulla struttura conversativa), additando anche in questo caso un incrocio particolare di registri. Anche la rassegna di mostre d’arte internazionali riunita nel Meraviglioso, anzi (1985) porta in quarta di copertina l’avvertenza d’autore a questo punto limpidissima: «Una conversazione lunga quindici anni», dove si dicono connessi «alla pratica critica i congegni del racconto». Della sua coerenza di lavoro, nonostante gli aspetti cangianti, Arbasino sembra perfettamente consapevole.
Nelle Piccole vacanze le tipiche modalità arbasiniane compaiono ancora acerbamente, in tentativi discontinui. Si fissano invece con ben altra precisione e tenuta nell’Anonimo lombardo, fresco e sofisticato esperimento già in equilibrio tra più generi: il romanzo saggio (con massicce digressioni metaletterarie), ma anche altre forme molto care all’autore: il romanzo di formazione, il romanzo intellettuale di note e quello tutto di citazioni, mentre il desueto romanzo epistolare presta solo transitoriamente il suo meccanismo. Nel contempo vi si organizzano altre caratteristiche fondamentali (balenanti solo in parte nei racconti giovanili): la rete di riferimenti e citazioni culturali, con l’avvertenza che l’Alta Cultura si è già tempestivamente annessa le culture minori e di massa, e lo farà sempre più; le acute e insolenti analisi di cultura e vita quotidiana; lo sciolto linguaggio della comunicazione intellettuale e alto-mondana; l’eros omosessuale.
Dopo poco, Arbasino allestisce il microcosmo di Fratelli d’Italia del 1963: su cui dice molte cose il diario di riflessioni critiche che è Certi romanzi. Nuovamente Fratelli d’Italia unisce generi diversi: oltre al romanzo saggio intellettuale e metaletterario, anche il romanzo di formazione e il romanzo del Grand Tour, entrambi erotico-culturali. Ma si aggiunga: la ricerca del linguaggio parlato dalla società colta ed elegante degli anni sessanta, protagonista collettiva del testo, introduce di prepotenza nel circuito testuale un altro genere, il dominante che orienta gli altri, e cioè il già citato «romanzo-conversazione»: trovata, questa, che non resta di qui in avanti prerogativa del solo Fratelli d’Italia ma si allarga, con le debite modifiche, a molta parte delle opere di Arbasino (perciò la centralità di questo testo nel sistema).
Del tutto innovativo nel ’63, il tipo del «romanzo-conversazione» sostiene l’intero Fratelli d’Italia: il linguaggio parlato da intellettuali mondani diventa lo strumento guida scelto per la rappresentazione (non naturalistica, bensì mirabolante e intenzionalmente smisurata) di quell’epoca. Sul piano della composizione tecnica, Fratelli d’Italia è costruito secondo il punto di vista, la voce, e la lingua, di un io narrante («l’elefante»), personaggio testimone della vicenda (secondo Genette si tratterebbe di una narrazione “omodiegetica”), del tutto affine all’ambiente socio culturale messo in scena. L’io narrante riporta dentro il proprio resoconto sia frequenti frammenti di dialogo altrui della più varia tipologia e estensione, sia zone connettivali intermedie di discorso indiretto libero (si tornerà su questi aspetti per un’analisi più minuta). Ne deriva lo scorrimento per tutto il testo di un cicaleccio tendenzialmente uniforme, che coinvolge senza distinzioni parti diegetiche e parti mimetiche.
di Clelia Martignoni
Senz’altro Fratelli d’Italia ha nel lavoro di Alberto Arbasino non solo un deciso rilievo ma anche e soprattutto una forte centralità, confermata dalla trentennale revisione (alla prima edizione del 1963 succede quella rielaboratissima del 1976, con ulteriore riscrittura nel 1993). Su Fratelli d’Italia, sui suoi segreti compositivi, sulla sua complessa evoluzione negli anni, si concentrano i saggi che seguono, di due giovanissime pavesi, Cinzia Lucchelli ed Elisabetta Cammarata, che si sono applicate all’analisi delle varie stampe, anche alla luce dei materiali preparatori donati da Arbasino al Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia.
Ma prima di affrontare la questione di che cosa il romanzo rappresenti nella storia di Arbasino, è bene sottolineare che la sua complessiva carriera, anche se fortunatamente ricca e multiforme, si segnala per la singolare coerenza non sempre, credo, sottolineata a dovere. Una serie di invarianti tematico-formali ne connette organicamente il sistema conferendogli spiccata unità, sia sul piano sincronico sia su quello diacronico. Si va infatti dagli eleganti ma ancora incerti racconti del libro d’esordio, Le piccole vacanze (’57, ’59, ’71), e, attraverso il passaggio chiarificatore dell’Anonimo lombardo (del 1959, con progressive revisioni sino al ’96), si arriva al massimo raggiungimento narrativo di Fratelli d’Italia, cui si affiancano non solo altri interessanti esperimenti di racconto e romanzo, ma anche parecchia eccellente produzione che per comodità di definizione si chiamerà sinteticamente “saggistica” ma di più complessa fattura e svariante in numerosi settori, tuttavia sempre intimamente omogenea. Ecco il punto: con grande lucidità e autoconsapevolezza, da certi anni in avanti (e proprio più radicalmente a partire dall’esperienza chiave di Fratelli d’Italia), Arbasino ha lavorato a congiungere e fare interagire nella sua opera attitudini e registri diversi, cercando in particolare una produttiva combinazione tra invenzione narrativa e talento “saggistico”, e realizzandola in sofisticate forme da lui abitualmente
dette, con richiamo ad Adorno, di «critica della cultura». Dal nodo risolutivo (si dirà perché) del primo Fratelli d’Italia, Arbasino si è attrezzato per fornire via via una analisi-testimonianza spregiudicata e documentatissima, tra cultura società costume, del nostro secondo Novecento, dagli anni del boom a oggi. Nella rara (e mobile) integrazione tra estro narrativo e criticità Arbasino ha trovato la sua personalissima identità di scrittore: dove il narratore che racconta, divaga, rappresenta, reinventa, sta di fianco al critico della cultura, di memoria adorniana (ovviamente i riferimenti ad Adorno, come a Kraus, come al non meno amato Praz, sono preziosi ma parziali e non spiegano l’insieme), o persino all’antropologo. Dall’intreccio di queste componenti scatta l’interpretazione, smagliante e feroce, di un’epoca e di una società. E non conta che di volta in volta l’elemento narrativo-creativo sia esteso o frammentato, svolto in forme romanzesche o in serie di aneddoti, o anche scheggiato in aforismi, caso quest’ultimo che connota in particolare il più recente prodotto arbasiniano, Paesaggi italiani con zombi, ’98. Ma s’intende, e resta fondamentale: la rappresentazione è artistica, quantunque provvista di amara e ilare verità. Arbasino vi devolve un’esperienza ricchissima di lettore/viaggiatore/osservatore ossessivamente curioso di tutto, e una memoria non meno straordinaria e puntigliosa.
Di testo in testo le strutture vengono rinnovate e modificate anche notevolmente, grazie alle proporzioni dissimili degli ingredienti in gioco: a seconda del genere-base selezionato. Così si vede in alcuni libri la prevalenza dell’intreccio romanzesco o la sperimentazione di alcune tecniche di racconto. Infatti il catalogo stesso dei prodotti “narrativi” presenta al suo interno formule variate. Semplificando: dopo l’articolato congegno di Fratelli d’Italia, si pensi agli azzardi linguistici specializzatissimi del dittico La narcisata – La controra, ai colti e grotteschi meccanismi di Super-Eliogabalo e Il principe costante (due riscritture di area differentissima), e di Specchio delle mie brame; alla favola “realistica” e fittiziamente tradizionale della Bella di Lodi, maliziosa «operazione pop» (Guglielmi). Ma altrove predomina il tipo della recensione teatrale (l’esempio più ricco: Grazie per le magnifiche rose), o più in generale artistica (Il meraviglioso, anzi); o del resoconto di viaggio (Trans-Pacific Express, Mekong, Passeggiando tra i draghi addormentati); oppure anche l’epigramma e lo scherzo poetico (Matinée). In altri casi, le categorie si confondono più facilmente, tanto da non rendere agevole l’indicazione di quella dominante: penso soprattutto alla densità delle ricognizioni civili-culturali-politiche (al vertice: Un paese senza, con l’addizione, ora, dello zibaldone fine millennio Paesaggi italiani con zombi), e alle pluriprospettiche indagini letterarie-artistiche, bilanciate tra testimonianza personale e ricostruzione critica (Parigi o cara, Certi romanzi, Sessanta posizioni, Fantasmi italiani). È, appunto, questione di dosaggio e di asse testuale privilegiato. La strategia di base in ogni caso resta in piedi, e alla sua sagace e tenace individuazione si deve la suddetta coerenza del sistema. Con l’avvertenza, che mi pare essenziale, che Arbasino appartiene alla famiglia saturnina dei manieristi e degli irregolari (indagata nella sua tradizione europea nel celebre saggio di Hocke del ’59). L’irregolarità di fondo (che vuol dire enciclopedismo, catalogo, accumulo, ossessione del dettaglio, paradosso, passione vebale) è gestita da Arbasino con sorvegliatissimo rigore: da cui anche il fascino della sua scrittura.
In estrema sintesi, i fattori fissi delle molteplici operazioni di Arbasino si possono così indicare: infinita curiosità, scintillante e amara capacità di osservazione e diagnosi senza tenerezze; genio umoristico espresso in gamme molto estese (ironia, parodia, satira, scherno, grottesco); un imponente apparato di riferimenti, citazioni, allusioni culturali, dove tutte le arti, alte, povere, minime, d’élites e popolari, di ogni epoca e dei più vari paesi, sono convocate a prestare materiali disparati per grandi accumuli e accostamenti; predilezione netta verso forme ibride, di contaminazione fantasiosa (che vedremo); e verso strutture tendenzialmente divaganti, aperte, frammentarie.
Con queste premesse, si capisce perché durante la sua lunga carriera, dotata anche di precisione auto-esegetica, Arbasino, avendo già alle spalle la prova cruciale di Fratelli d’Italia e a essa connettendosi, abbia definito «romanzo critico», apparentemente a sorpresa, la raccolta di recensioni teatrali Grazie per le magnifiche rose (1965), certo nell’intento di sottolinearne la commistione di registri e in particolare la presenza di estri narrativi in ambito tradizionalmente saggistico. Analogamente a proposito di Un paese senza (del 1980 la prima edizione, rielaborata ampiamente nel ’90), Arbasino ha usato la stessa etichetta di «romanzo-conversazione» con cui aveva qualificato Fratelli d’Italia (felicemente imperniato sulla struttura conversativa), additando anche in questo caso un incrocio particolare di registri. Anche la rassegna di mostre d’arte internazionali riunita nel Meraviglioso, anzi (1985) porta in quarta di copertina l’avvertenza d’autore a questo punto limpidissima: «Una conversazione lunga quindici anni», dove si dicono connessi «alla pratica critica i congegni del racconto». Della sua coerenza di lavoro, nonostante gli aspetti cangianti, Arbasino sembra perfettamente consapevole.
Nelle Piccole vacanze le tipiche modalità arbasiniane compaiono ancora acerbamente, in tentativi discontinui. Si fissano invece con ben altra precisione e tenuta nell’Anonimo lombardo, fresco e sofisticato esperimento già in equilibrio tra più generi: il romanzo saggio (con massicce digressioni metaletterarie), ma anche altre forme molto care all’autore: il romanzo di formazione, il romanzo intellettuale di note e quello tutto di citazioni, mentre il desueto romanzo epistolare presta solo transitoriamente il suo meccanismo. Nel contempo vi si organizzano altre caratteristiche fondamentali (balenanti solo in parte nei racconti giovanili): la rete di riferimenti e citazioni culturali, con l’avvertenza che l’Alta Cultura si è già tempestivamente annessa le culture minori e di massa, e lo farà sempre più; le acute e insolenti analisi di cultura e vita quotidiana; lo sciolto linguaggio della comunicazione intellettuale e alto-mondana; l’eros omosessuale.
Dopo poco, Arbasino allestisce il microcosmo di Fratelli d’Italia del 1963: su cui dice molte cose il diario di riflessioni critiche che è Certi romanzi. Nuovamente Fratelli d’Italia unisce generi diversi: oltre al romanzo saggio intellettuale e metaletterario, anche il romanzo di formazione e il romanzo del Grand Tour, entrambi erotico-culturali. Ma si aggiunga: la ricerca del linguaggio parlato dalla società colta ed elegante degli anni sessanta, protagonista collettiva del testo, introduce di prepotenza nel circuito testuale un altro genere, il dominante che orienta gli altri, e cioè il già citato «romanzo-conversazione»: trovata, questa, che non resta di qui in avanti prerogativa del solo Fratelli d’Italia ma si allarga, con le debite modifiche, a molta parte delle opere di Arbasino (perciò la centralità di questo testo nel sistema).
Del tutto innovativo nel ’63, il tipo del «romanzo-conversazione» sostiene l’intero Fratelli d’Italia: il linguaggio parlato da intellettuali mondani diventa lo strumento guida scelto per la rappresentazione (non naturalistica, bensì mirabolante e intenzionalmente smisurata) di quell’epoca. Sul piano della composizione tecnica, Fratelli d’Italia è costruito secondo il punto di vista, la voce, e la lingua, di un io narrante («l’elefante»), personaggio testimone della vicenda (secondo Genette si tratterebbe di una narrazione “omodiegetica”), del tutto affine all’ambiente socio culturale messo in scena. L’io narrante riporta dentro il proprio resoconto sia frequenti frammenti di dialogo altrui della più varia tipologia e estensione, sia zone connettivali intermedie di discorso indiretto libero (si tornerà su questi aspetti per un’analisi più minuta). Ne deriva lo scorrimento per tutto il testo di un cicaleccio tendenzialmente uniforme, che coinvolge senza distinzioni parti diegetiche e parti mimetiche.
[...] Del coerente sistema arbasiniano, Fratelli d’Italia è tra i testi più rappresentativi, e senz’altro per primo ne ha stabilito i requisiti base, scegliendo di investirli in un intrigante congegno narrativo. Cinzia Lucchelli ed Elisabetta Cammarata ne hanno studiato analiticamente l’elaborazione: la Lucchelli si è occupata dell’impianto strutturale-tematico-formale definito dalla prima edizione, cercando di precisarlo meglio attraverso l’utile confronto con il dattiloscritto preparatorio; la Cammarata ha esaminato le importanti novità strutturali introdotte nel testo ’93 e la concomitante revisione stilistica. A questi lavori, corredati di campionature e analisi, rimando per la documentazione. In che direzione generalissima sia andata l’annosa riscrittura è noto e intuibile. Arbasino non poteva che percorrere la strada dell’«ingordo “aggiungere”» (cfr. n. 14), l’unica congeniale alla poetica dell’eccesso fin qui delineata, e alla volontà enciclopedica. Le tre edizioni conoscono una progressiva dilatazione, e la sola smentita, perciò tanto più interessante, precede le stampe: Cinzia Lucchelli infatti, confrontando l’ed. ’63 con il dattiloscritto d’autore, ha individuato non a caso solo nella fase iniziale del lavoro, prima che il congegno arrivasse al suo assestamento, alcune inattese cadute (perlopiù però recuperate nelle stampe successive). Ma, enunciate le generalità del fenomeno, non s’è detto tutto, poiché le aggiunte possono incidere variamente sul testo. Nella fattispecie, l’ampliamento sistematico introduce numerose tessere di dimensione e qualità diversissime (ma è eccezionale l’immissione di capitoli ed episodi compatti), con una tecnica per così dire a intarsio, di lavorazione minuta, diffusa, quasi ininterrotta, che rinnovando fortemente il testo riesce però a salvarne l’impianto preesistente, e non altera né l’intreccio né i personaggi né gli eventi, tutti elementi assolutamente invariati. La revisione produce stabilmente, edizione dopo edizione, una straordinaria crescita di dettagli di ogni tipo; perciò ovviamente, sul piano della struttura, provoca ulteriori frammentazioni, divagazioni, e nuovi accumuli. Cioè conferma le leggi già individuate del sistema. L’insistenza sul dettaglio vale a tutti i livelli, da quello contenutistico (l’oggetto da recuperare nella memoria, come l’aneddoto, come l’autore e quel testo che si leggeva allora, o quel museo, o quella tela, o quella canzone, e così infinitamente), a quello linguistico (l’acquisto del flaubertiano «mot juste», l’imprecisione da emendare, la genericità da determinare, il tessuto stilistico da frantumare e movimentare ecc.). Una ricerca di questo tipo, a tutto campo, estrosa e rigorosa insieme, conferma che l’interesse tenace di Arbasino va verso il ritratto collettivo di un’epoca. Evidentemente, perché il ritratto soddisfi l’autore, la pretesa (o l’ossessione) è di renderlo sempre più folto, gremito, complesso. E con ciò si ritorna a quanto s’è detto: a ribadire in definitiva lo scrupolo maniacale dell’artista artigiano, lo zelo del memorialista e testimone, l’accanimento a oltranza del collezionista ed enciclopedista.






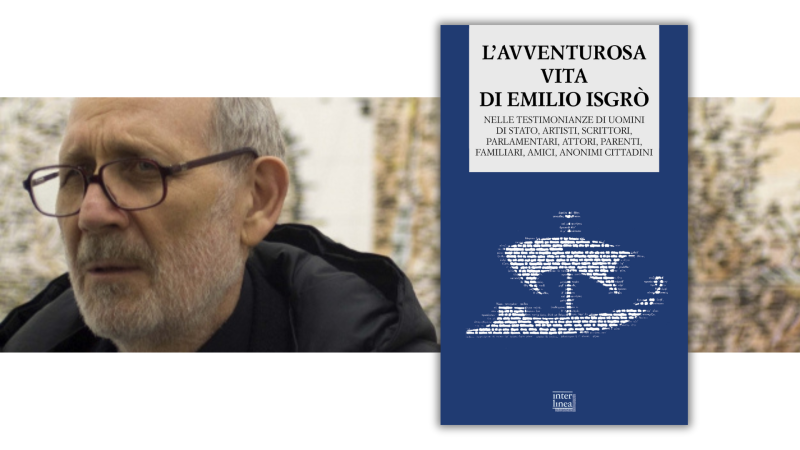

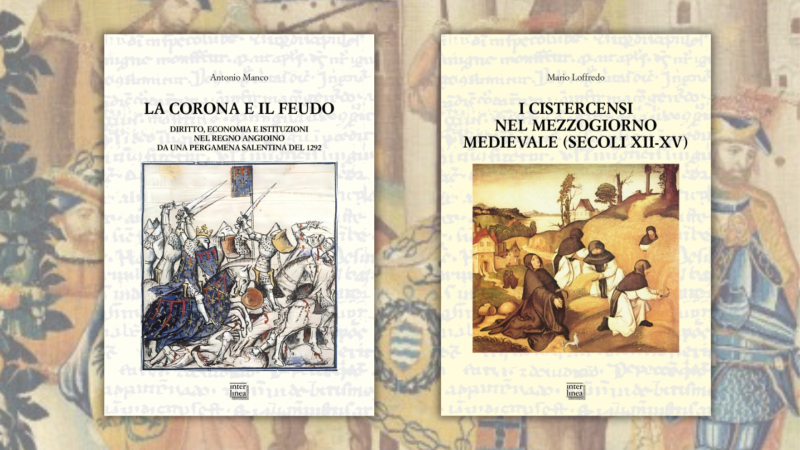
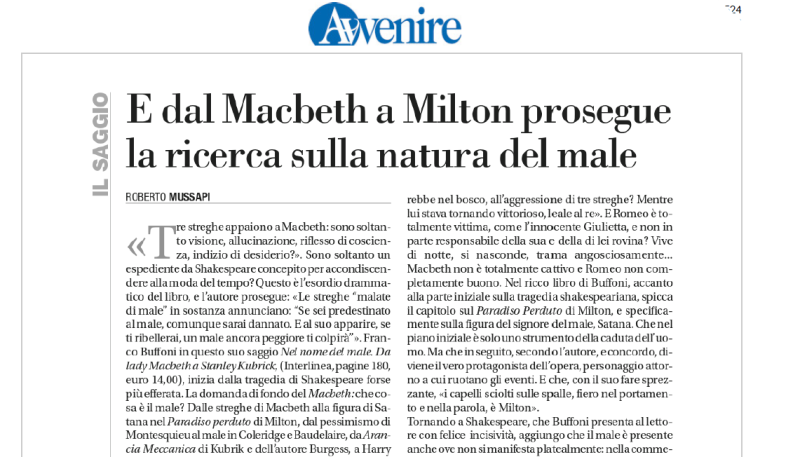


Inserisci un commento