Per la prima volta raccolte in un'edizione a tiratura limitata le traduzioni in dialetto milanese dell'Inferno dantesco ad opera di Carlo Porta, tra emulazione e parodia, con introduzione di Pietro Gibellini.
Un libro da collezione per celebrare il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri
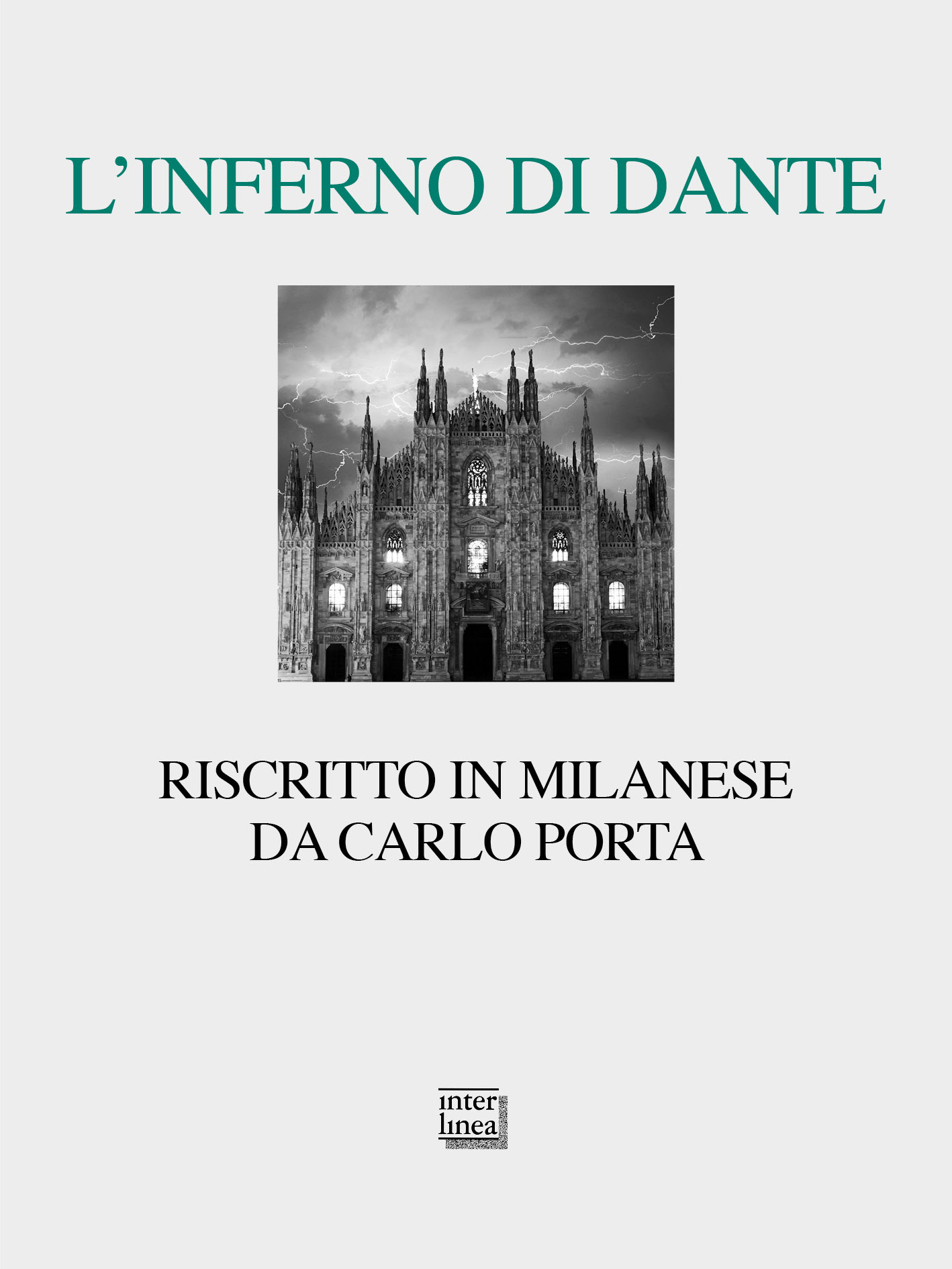 La prima traduzione del poema di Dante in un dialetto italiano si deve a Carlo Porta. L’Inferno in versi milanesi, seppur frammentario, rappresenta il vero inizio della poesia portiana. Sospesa com’è tra emulazione e parodia, tra slancio verso il sublime e controcanto comico-realistico, la ricreazione dialettale produce un testo originale e assai godibile. Dispersi qua e là nelle edizioni delle poesie portiane, i frammenti dell’Inferno milanese sono qui riuniti, ordinati e riprodotti a fronte dell’originale dantesco. Il libro è introdotto da un ampio saggio di Pietro Gibellini e reca le retroversioni in italiano approntate da Massimo Migliorati.
La prima traduzione del poema di Dante in un dialetto italiano si deve a Carlo Porta. L’Inferno in versi milanesi, seppur frammentario, rappresenta il vero inizio della poesia portiana. Sospesa com’è tra emulazione e parodia, tra slancio verso il sublime e controcanto comico-realistico, la ricreazione dialettale produce un testo originale e assai godibile. Dispersi qua e là nelle edizioni delle poesie portiane, i frammenti dell’Inferno milanese sono qui riuniti, ordinati e riprodotti a fronte dell’originale dantesco. Il libro è introdotto da un ampio saggio di Pietro Gibellini e reca le retroversioni in italiano approntate da Massimo Migliorati.
Dalla nota di Pietro Gibellini
"Se per un verso, sorridendo del poema sacro, Porta rende tributo al retaggio illuminista e neoclassico, per un altro già s’inoltra nel territorio romantico, cui appartiene, per scelta di temi e di forme, già prima di prenderne consapevolezza teorica schierandosi apertamente con la nuova scuola, stroncando con versi esilaranti i passatisti e perorando la causa di un romanticismo moderato, che contemperi «passion» e «reson». Questo accade nei testi legati alla polemica classico-romantica, scoppiata nella Milano tornata austriaca; ma all’altezza dell’Inferno meneghino già s’intravede la sua inclinazione nell’approccio al testo da voltare in dialetto, conciliando esprit voltairiano e stupore favoloso, distanziante ironia e coinvolgimento empatico. Sulla dialettica tra parodia ed emulazione, tra la pars destruens della letteratura aulica e quella construens della scrittura popolareggiante, ritorneremo nel paragrafo seguente. Ma è bene segnalare fin d’ora che la dominante comico-satirica non schiaccia il disegno ambizioso di nobilitare la scrittura dialettale. Nel 1815, quando Porta prepara per il figlio il quaderno dei suoi versi, gli scrive una lettera, utilizzata poi come prefazione alle poesie in varie edizioni postume. Gli spiega che il suo intento è stato quello di «provare se il dialetto nostro poteva esso pure far mostra di alcune di quelle veneri, che furono fin or credute intangibile patrimonio di linguaggi più generali ed accetti»."



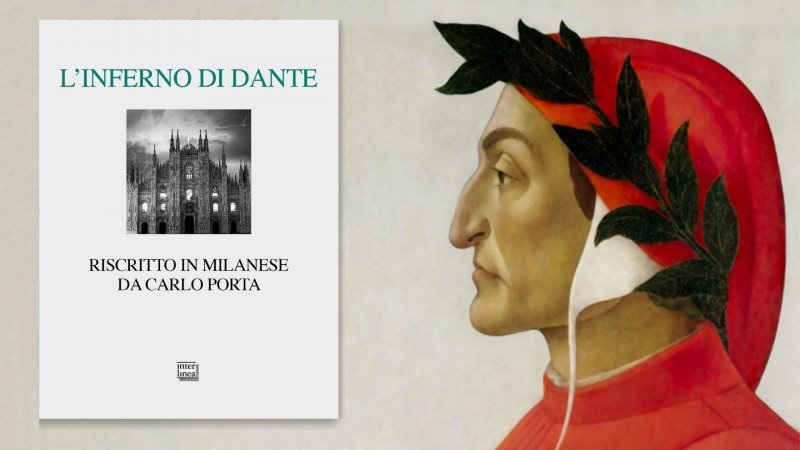
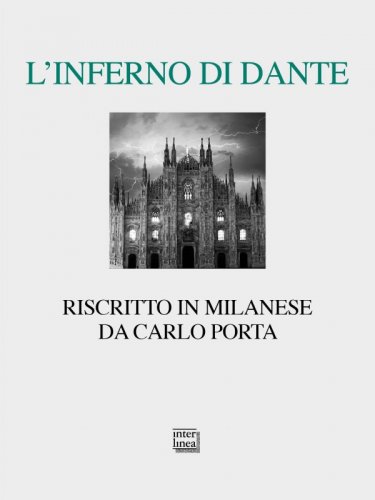


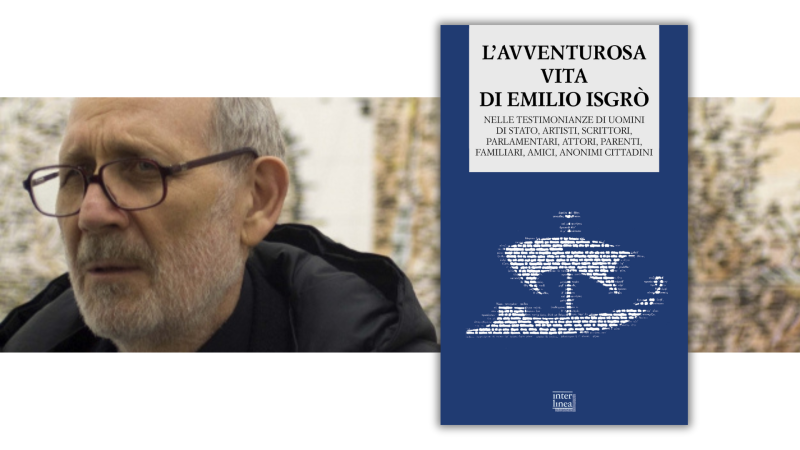

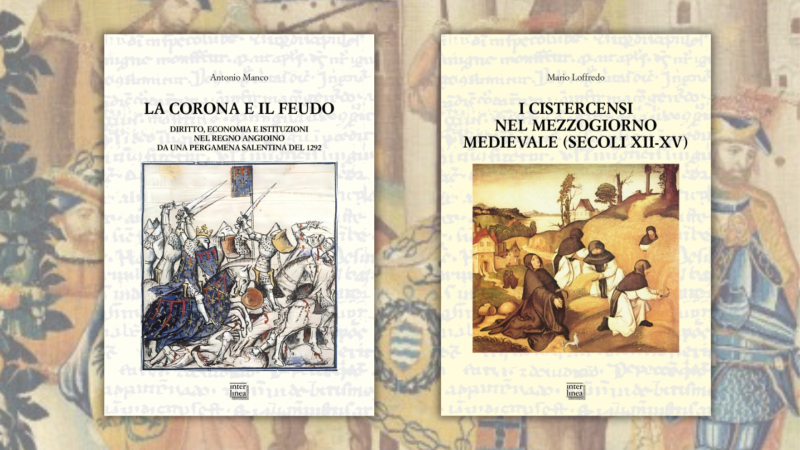
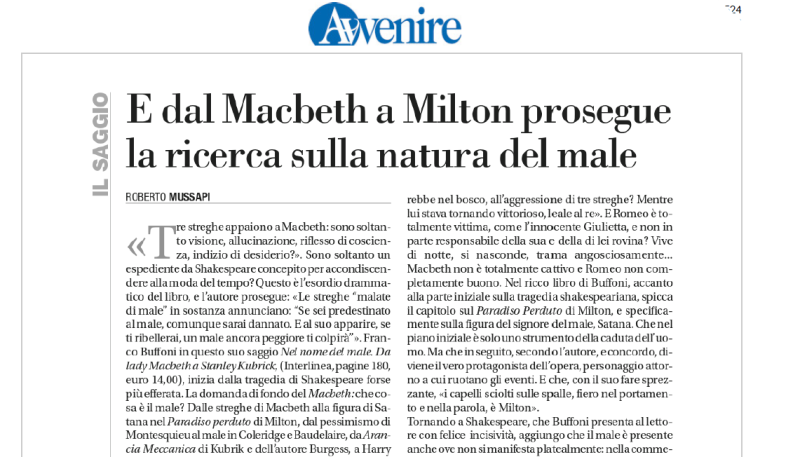


Inserisci un commento