Ricordo perfettamente la sua reazione, alla proposta che gli avevo avanzata 35 anni addietro di dar voce, per i Lirici Greci tradotti da poeti italiani contemporanei (usciti poi da Bompiani), a un passo dell’antico Semonide, esattamente dei versi dalla cosiddetta “satira contro le donne” (fr.29 Diehl). Mi aveva chiesto ex abrupto se io conoscessi le peculiarità del suo ductus espressivo e traduttorio: se io sapessi che ciò che gli premeva era, testualmente, la “cosalità” (la famosa “poetica in re” anceschiana), che in parole povere significava il suo interesse verso una dimensione minima e quotidiana filtrata da uno sguardo realistico e pratico, in senso umorale e morale, in quanto all’oggetto e alla sua resa. Ognuno per suo conto giudichi quel che n’era sortito confrontandolo con il testo antico: “La sorte degli umani? / Il saggio di Chio non aveva dubbi / noi siamo come foglie sopra i rami. / Il detto avrà fortuna. Scriverà / tra millenni un nilotico poeta / “si sta / come d’autunno sugli alberi le foglie / (Ungaretti, Girovago, Soldati). / È troppo vero e intenda chi abbia orecchi!”.
Un testo nuovo, diverso: un’”imitazione” in senso leopardiano, un “testo ibrido, straniante e senza tempo”, per dirla con Giulia Grata che la usa a proposito di Sponde, che traghetta l’originale in un altro sistema, quello ideologico del traduttore, aduso a lasciare alle ”cose”, intese anche come parole, il compito di parlare da sé ma senza rinunciare, per proprio vezzo intellettuale, a indirizzare l’attenzione, con soluzioni spiazzanti e una punta di arguzia e cordiale understatement, verso un proprio mondo di rifrangenze e risonanze culturali e sfumature, a riprova di un caratteristico metodo traduttorio, bollato autoironicamente come bricolage,in una cifra poetica amabilmente sentenziosa.
Luciano Erba era così, nei suoi versi non meno che nelle traduzioni: “un artigiano esperto e attento, un cultore della parola che cerca di esaltarne il valore profondo”, come aveva scritto di lui Bianca Garavelli proprio su queste pagine nel ’14. E questo per restare anche al solo ambito del linguaggio, che già da sé basta a farne un “maestro” autentico, benché “schivo”, di una generazione per la vena sapienziale delle sue riflessioni e il rigore formale e concettuale di certe immagini.
“Uno dei protagonisti più misurati e schivi del nostro Novecento letterario”: è proprio così che giustamente viene definito nella Premessa all’omaggio “Luciano Erba bricoleur e metafisico”, che la rivista Autografo 70 gli dedica nell’ultimo numero, a ridosso della giornata di studi celebrativa del centenario della nascita (ottobre 2022) e a conferma della lenta riemersione della sua lezione di discrezione dal limbo dell’accantonamento all’indomani della sua morte nel 2010.
Un omaggio, si diceva, a una “presenza” appartata ma non marginale, dalla fedeltà tematica e stilistica, a partire dalle prove poetiche giovanili e fino ai testi della maturità, per oltre mezzo secolo: è questo che il fascicolo dimostra già dai saggi di Stefano Prandi e di Maria Antonietta Grignani, prima di addentrarsi nell’analisi di testi e aspetti specifici (lo stile e il tema poesia/arti visive), con al centro la storia di un sodalizio, umano prima ancora che professionale, con un editore, Vanni Scheiwiller, raccontata con dovizia di documenti e testimonianze da Roberto Cicala.
“Bricoleur e metafisico”, come dire un abile mestierante, un artigiano provetto, che a parole e immagini altrui innesta un estro fosforico e trasgressivo per accenderle di effetti sorprendenti e significativi tali da indurre a impreviste domande il lettore, come dimostrano, assieme alla traduzione prima citata di Semonide, gli esempi delle versioni da Sponde, Frénaud e Racine, commentate rispettivamente da Giulia Grata, Anna Stella Poli e Pietro Benzoni nei saggi proposti nella rivista.
Un modus operandi che, come si applica a testi da tradurre, così entra in fertile dialogo con immagini di artisti, nello specifico dell’”ippopittore” Gian Luigi Giovanola, col quale, al di là del rapporto “ecfrastico”, cioè di commento di immagini, intrattiene un reciproco gioco di dare-avere di stimoli, destinato a protrarsi anche con altri artisti (Nenci, Azuma, Casaroli), trasformando lo spunto figurativo di partenza in un testo che va stratificandosi e crescendo per echi, aggiunte e correzioni, vera “natura naturante”, fino all’esito conclusivo più probabile (“una poesia non è quasi mai chiusa”, al dire stesso di Erba a mo’ quasi di dichiarazione di poetica), per “progressivamente emanciparsi dal corrispettivo visivo”, come dimostra con filologica acribia Federico Milone.



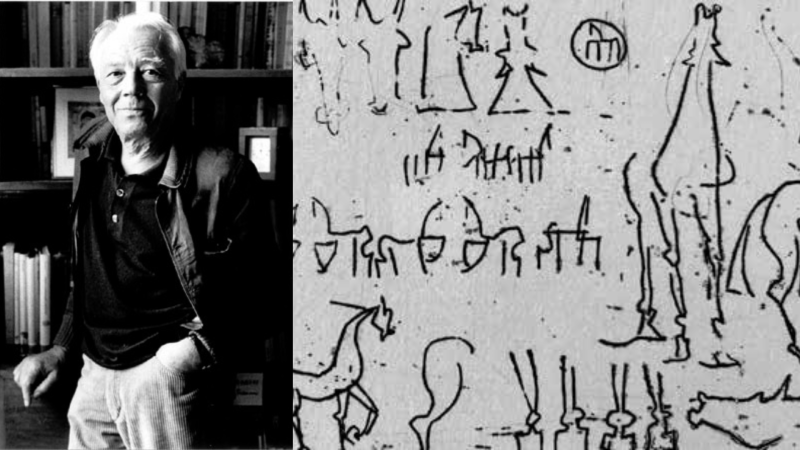



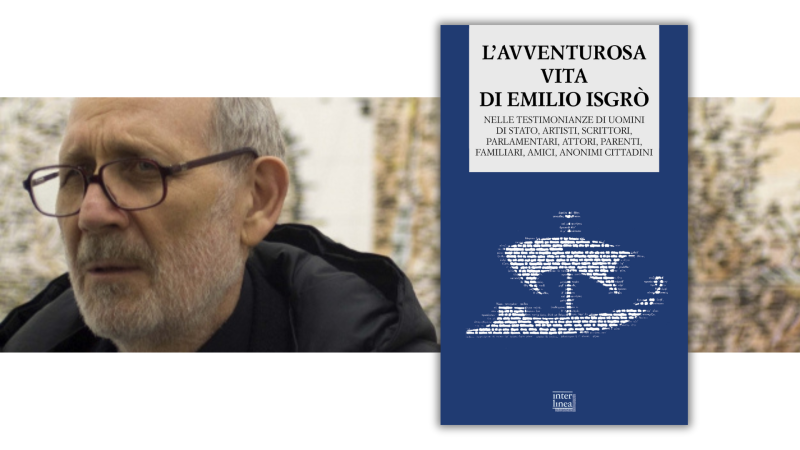

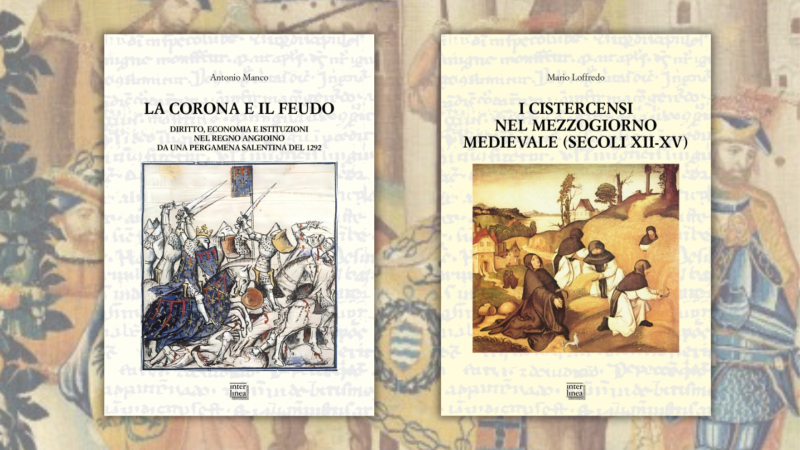
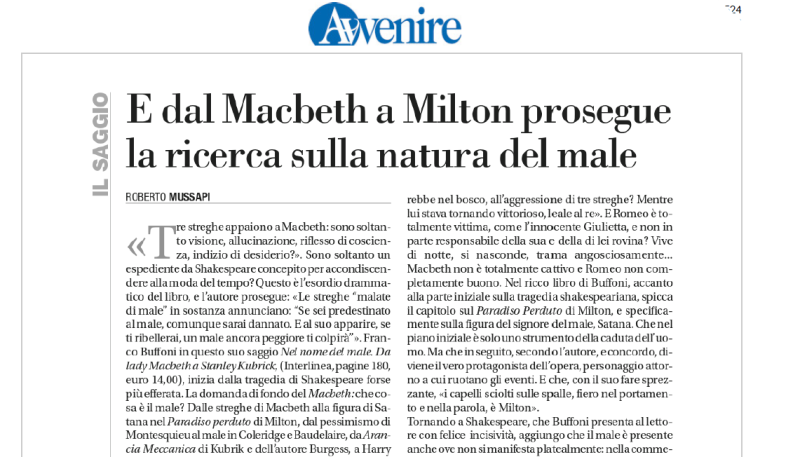


Inserisci un commento