Remigio Bertolino, Nìvole da prim / Nuvole di primavera
Sarà che anche io sto sempre di più qui “a tnì viv ël feu / dl’amor da leugn” // a tener vivo il fuoco / dell’amore da lontano”, comeBertolino, classe 1948, scriveva in Litre d’ënvern / Lettere d’inverno, il suo penultimo libro, uscito nel 2015 per Aragno. Sarà che quella sua ripresa da Jaufré Rudel con il suo amor de lonh, che ritorna anche in queste Nìvole da prim / Nuvole di primavera, curiosamente alle stesse pagine, è testimonianza di una percepita e condivisa continuità dello “spirito romanzo”, che pure a me sta molto a cuore. Certo è che se la lingua dei trovatori mi è sempre stata più vicina dell’italiano di padre Dante, a maggior ragione lo è il piemontese di Remigio Bertolino. La parlata di Montaldo di Mondovì, il suo paese natale, non è per me esattamente né lingua madre né lingua padre, noi veniamo dalla pianura un po’ più a nord, la campagna di mia madre parla(va) in modo differente, il paese di mio padre pure. Le donne sono “fumne” non “frome”, le pietre “pere” e non “pree”, la primavera “prima” e non “prim”, ma tutto sommato sono piccolezze e ci si capisce perfettamente tra noi pochi, e sempre meno, che ancora pensiamo in “dialetto” quanto è più vicino alla sfera degli affetti più antichi e più profondi. Ed è proprio in questa sfera magica che Bertolino ci fa guardare con i suoi versi. Ma voglio dire subito che sarebbe molto ingiusto, e certo errato, limitare all’apprezzamento di un parlante nativo l’importanza della sua poesia. Come scrive Giovanni Tesio nella sua introduzione alle Nìvole, Bertolino, più di ogni altro poeta, riesce “oggi ad allineare la poesia in piemontese ai risultati della più provveduta (e pur nei suoi limiti, più nota) poesia in lingua”.
E Tesio se ne intende. Le cinque sezioni che costituiscono questo libro raggruppano una trentina di composizioni, ammesso di contare come un testo solo i 16 di Quasi haiku e considerare come 8 poesie separate quello che in realtà è un poemetto, la sezione di apertura Sné e silensi / Cenere e silenzi. Il mondo di riferimento della poesia di Bertolino è un mondo che, come la sua lingua, quasi non c’è più. Se sopravvive, è spesso nel ricordo, proprio come il figlio morto, forse partigiano per amore di una donna, a cui si rivolge la voce che parla nel poemetto di apertura. La cenere è quella nel focolare di una casa di campagna immersa nel silenzio e abitata da un vecchio solo, il cui tempo sta per scadere, che altro non vuole che raggiungere il figlio: “Àora mia lun-a a cala. / Spòrzme la man / da la lòbia dël cel / land lusa – mèora – / la lujenga dël stèile. // Ora la mia luna cala. / Allungami la mano / dal ballatoio del cielo / dove splende – matura – / la luglienga delle stelle” .
Chi torna a ripopolare quelle campagne semi-abbandonate ai limiti dei boschi, o a portare animali al pascolo sugli stessi prati di montagna del pastore protagonista della seconda sezione, intitolata appunto Pastre, assai probabilmente non parla piemontese. La cultura contadina che si esprimeva in quella lingua fornirà pure materia prima importante e riciclabile al mondo di Slow food, ma già stiamo traducendo in un idioma globale. Il giovane “pastre” della seconda sezione parla ovviamente al presente, mentre sale in montagna con le pecore “ën procession longh ij sënté / ch’i j’han pilon ëd ròche vive // in processione lungo i sentieri / che hanno i piloni di roccia viva” dove “disa j’orassion / ël vent dla seira, / n’àmen ën ginojon, / prima dë scrolé la sapinéra // dice le orazioni / il vento della sera, / un attimo in ginocchio / prima di scuotere l’abetaia” (40/41), ma è una voce del passato che Bertolino, come un medium, rievoca da un altro mondo. Attenzione, però, non è mai la nostalgia, che sarebbe, io credo, un limite per chi scrive in “dialetto”, il sentimento che domina anche in questo libro. Uno dei grandi pregi della poesia di Bertolino sta proprio nel presentare luoghi, ambienti e personaggi conosciuti e frequentati in prima persona lasciando emergere la loro naturale malinconia, come quando descrive il padre “ëmbrassà a la cadrega, / soa sposa ëd bòsch, / ël cotin ëd paja // abbracciato alla sedia, / la sua sposa di legno, / la gonna di paglia” .
E ha sempre ragione Tesio a indicare la metafora in Bertolino “come anima del tutto” (8). Forse non può essere altrimenti, e non solo per chi scrive in piemontese. In effetti solo il traslato ha senso per chi ammette “son restà ënt j’agn / a graté sël cantin dla poesia / ringret e carvaveje, / a sërché ël pin / drinta greuje véde / ëd ricòrd // sono rimasto negli anni / a pizzicare sul cantino della poesia / rimpianti e illusioni, / a cercare il pieno / dentro gusci vuoti / di ricordi” .
Sarà che anche io sto sempre di più qui “a tnì viv ël feu / dl’amor da leugn” // a tener vivo il fuoco / dell’amore da lontano”, comeBertolino, classe 1948, scriveva in Litre d’ënvern / Lettere d’inverno, il suo penultimo libro, uscito nel 2015 per Aragno. Sarà che quella sua ripresa da Jaufré Rudel con il suo amor de lonh, che ritorna anche in queste Nìvole da prim / Nuvole di primavera, curiosamente alle stesse pagine, è testimonianza di una percepita e condivisa continuità dello “spirito romanzo”, che pure a me sta molto a cuore. Certo è che se la lingua dei trovatori mi è sempre stata più vicina dell’italiano di padre Dante, a maggior ragione lo è il piemontese di Remigio Bertolino. La parlata di Montaldo di Mondovì, il suo paese natale, non è per me esattamente né lingua madre né lingua padre, noi veniamo dalla pianura un po’ più a nord, la campagna di mia madre parla(va) in modo differente, il paese di mio padre pure. Le donne sono “fumne” non “frome”, le pietre “pere” e non “pree”, la primavera “prima” e non “prim”, ma tutto sommato sono piccolezze e ci si capisce perfettamente tra noi pochi, e sempre meno, che ancora pensiamo in “dialetto” quanto è più vicino alla sfera degli affetti più antichi e più profondi. Ed è proprio in questa sfera magica che Bertolino ci fa guardare con i suoi versi. Ma voglio dire subito che sarebbe molto ingiusto, e certo errato, limitare all’apprezzamento di un parlante nativo l’importanza della sua poesia. Come scrive Giovanni Tesio nella sua introduzione alle Nìvole, Bertolino, più di ogni altro poeta, riesce “oggi ad allineare la poesia in piemontese ai risultati della più provveduta (e pur nei suoi limiti, più nota) poesia in lingua”.
E Tesio se ne intende. Le cinque sezioni che costituiscono questo libro raggruppano una trentina di composizioni, ammesso di contare come un testo solo i 16 di Quasi haiku e considerare come 8 poesie separate quello che in realtà è un poemetto, la sezione di apertura Sné e silensi / Cenere e silenzi. Il mondo di riferimento della poesia di Bertolino è un mondo che, come la sua lingua, quasi non c’è più. Se sopravvive, è spesso nel ricordo, proprio come il figlio morto, forse partigiano per amore di una donna, a cui si rivolge la voce che parla nel poemetto di apertura. La cenere è quella nel focolare di una casa di campagna immersa nel silenzio e abitata da un vecchio solo, il cui tempo sta per scadere, che altro non vuole che raggiungere il figlio: “Àora mia lun-a a cala. / Spòrzme la man / da la lòbia dël cel / land lusa – mèora – / la lujenga dël stèile. // Ora la mia luna cala. / Allungami la mano / dal ballatoio del cielo / dove splende – matura – / la luglienga delle stelle” .
Chi torna a ripopolare quelle campagne semi-abbandonate ai limiti dei boschi, o a portare animali al pascolo sugli stessi prati di montagna del pastore protagonista della seconda sezione, intitolata appunto Pastre, assai probabilmente non parla piemontese. La cultura contadina che si esprimeva in quella lingua fornirà pure materia prima importante e riciclabile al mondo di Slow food, ma già stiamo traducendo in un idioma globale. Il giovane “pastre” della seconda sezione parla ovviamente al presente, mentre sale in montagna con le pecore “ën procession longh ij sënté / ch’i j’han pilon ëd ròche vive // in processione lungo i sentieri / che hanno i piloni di roccia viva” dove “disa j’orassion / ël vent dla seira, / n’àmen ën ginojon, / prima dë scrolé la sapinéra // dice le orazioni / il vento della sera, / un attimo in ginocchio / prima di scuotere l’abetaia” (40/41), ma è una voce del passato che Bertolino, come un medium, rievoca da un altro mondo. Attenzione, però, non è mai la nostalgia, che sarebbe, io credo, un limite per chi scrive in “dialetto”, il sentimento che domina anche in questo libro. Uno dei grandi pregi della poesia di Bertolino sta proprio nel presentare luoghi, ambienti e personaggi conosciuti e frequentati in prima persona lasciando emergere la loro naturale malinconia, come quando descrive il padre “ëmbrassà a la cadrega, / soa sposa ëd bòsch, / ël cotin ëd paja // abbracciato alla sedia, / la sua sposa di legno, / la gonna di paglia” .
E ha sempre ragione Tesio a indicare la metafora in Bertolino “come anima del tutto” (8). Forse non può essere altrimenti, e non solo per chi scrive in piemontese. In effetti solo il traslato ha senso per chi ammette “son restà ënt j’agn / a graté sël cantin dla poesia / ringret e carvaveje, / a sërché ël pin / drinta greuje véde / ëd ricòrd // sono rimasto negli anni / a pizzicare sul cantino della poesia / rimpianti e illusioni, / a cercare il pieno / dentro gusci vuoti / di ricordi” .
Da "Italica. Journal of the American Association of Teacher of Italian" nota critica di ANTONELLO BORRA (University f Vermont)







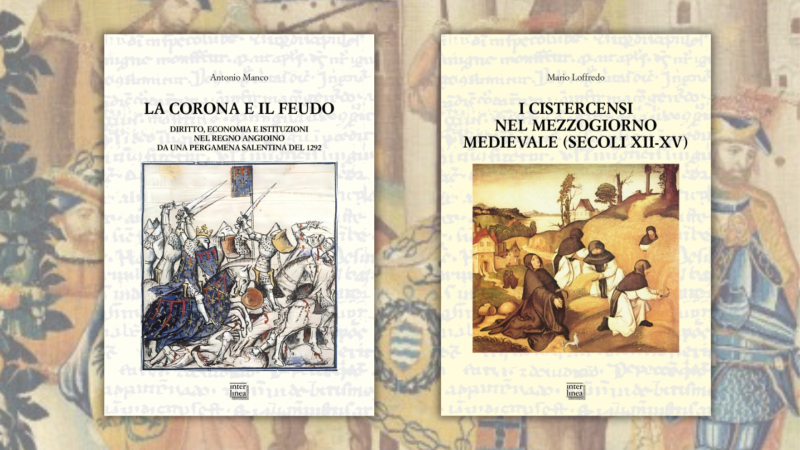
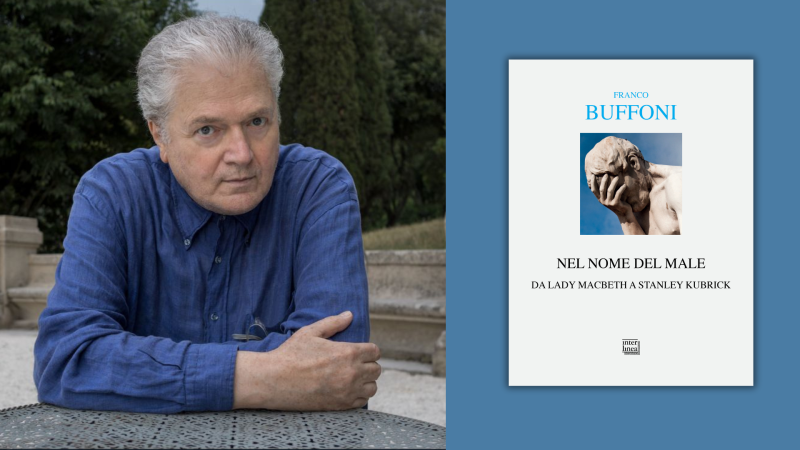
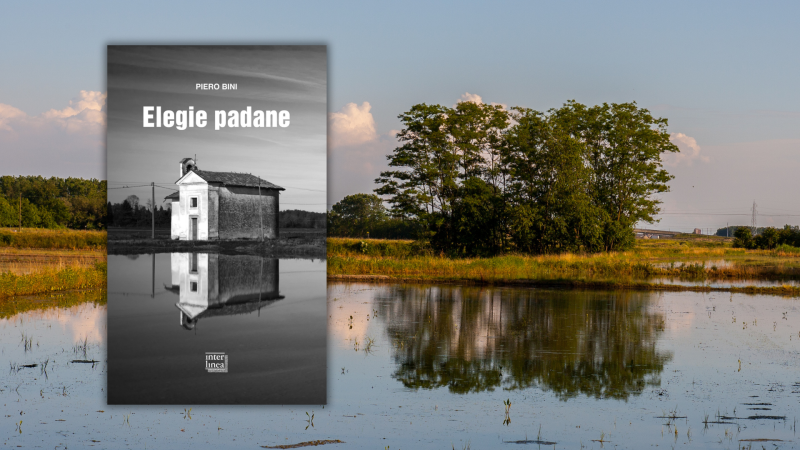



Inserisci un commento