Isole da costa
Incrostate interpretazioni in un armadio di mineralogia
a raffigurare sogni per un’alba di sentinelle
affiancati dai turni rami di sangue a guisa di remi
un’infinità di voci emerse saldamente bianche
per incredibili rive inclinazione d’isole
vulcaniche scintille fioriscono l’identico colore
succedersi da quelle alture detriti rapaci
come parole di ferro con pazienza decifrate
preparano mutazioni, qualcosa di deciso già rabbrividente
perché i tonfi rispondono allo scorrere dei chiavistelli.
*Giannino di Lieto Opere (Interlinea 2010)
La poesia di Giannino di Lieto ha una stagione quarantennale, considerando che il suo esordio risale al 1969 con il libro Poesie, presentato da Salvatore Valitutti e pubblicato da Bino Rebellato nella sua allora prestigiosa collana (la stessa in cui erano usciti Diego Valeri, Lalla Romano, Biagio Marin, Andrea Zanzotto), e che gli ultimi scritti, Poesie e Racconti, sono del 2006. Una stagione intensa e di autentica ricerca che è passata negli anni attraverso altri sette volumi: Indecifrabile perché del 1970, Punto di inquieto arancione del 1972, introdotto da un illuminante saggio critico di Giorgio Barberi Squarotti, Nascita della serra del 1975, Racconto delle figurine & Croce di Cambio del 1980, L’abbonato impassibile – Le facce limitrofe del 1983, Le cose che sono del 2000 e Breviario inutile del 2003.
È una poesia, quella di Giannino di Lieto, che vive nell’ottica della rassegna dei molti dati autobiografici, del loro incrocio e delle loro combinazioni: una sorta di quaderno degli appunti, delle notazioni maggiori e marginali, degli umori e dei malumori, dei frammenti di ricordo, degli stati rimossi e delle sensazioni, del gioco e del divertissement, delle provocazioni e dell’affondo di pensiero. Una poesia che ricompone nella sua analisi programmatica il senso di una vita che ci trascina a mete non desiderate, fuori da ogni possibile piano di organizzazione e di sistemazione (“disancorato vivere in deriva”, “un filo ci trascina…”), eppure dietro a un impulso superiore riconducibile a quello che chiamiamo libero arbitrio, sia pure di fronte all’indecifrabile perché, come recita il titolo della raccolta del 1970. E, sul nastro a scorrere delle immagini, continuamente esercita interferenza l’occhio vigile di un testimone del nostro tempo, attento a cogliere comunque e a registrare sulla cartina di tornasole perfino le vibrazioni di una vicenda comune e generale. Come appare in modo evidente nel volume complessivo Opere (Interlinea 2010) che potrebbe portare il titolo subito esemplare di uno degli inediti finali “Diario di un giorno assolato” (non perché “diaristica” sia la modalità poetica, ma nel senso etimologico della “razione di un giorno” di diario, verificabile anche nella scelta del termine “breviario” (etimologicamente “breve catalogo”, sommario cioè di ogni giorno) per l’ultima raccolta: razione quotidianamente attraversata in cerca del suo senso, sempre in un eccesso di luminosità che crea abbaglio e che, incontrando ostacoli, diffonde un proliferare delle ombre riflesse intorno).
Parlando della dimensione esistenziale di Giannino di Lieto, a maggior ragione va definita la sua come una poesia del “testimone”: tra adesioni e ripulse, accensioni e ricadute, da parte di chi comunque sa che bisogna andare avanti. Il poeta, per di Lieto, è il testimone in viaggio, anche se il viaggio è un pretesto a posteriori e le sue tappe confinano, dentro il paesaggio assolato appunto, con le contrade oscure delle tenebre e con la morte (“Ho la morte / davanti agli occhi”, “Un giorno / il mio corpo / stanco / riposerà / lassù fra i dolci ulivi”). È termine ineludibile, la morte, tuttavia fissato con lucidità e perfino con autoironia, attraverso una parola che deve alla sua divina ambiguità la sua capacità espressiva (“Scrittura, vibrazione tecnica fra luce e / oggetto, la parola adombra il significato, / ombra è il suo sofisma”) e dunque le sue potenzialità decifratorie.
Il “libro” che la poesia di Giannino di Lieto disegna è il percorso dal sensibile all’io meditante: “scienza mentale”, come la chiama l’autore stesso. E lo è in una chiave morale, che impegna totalmente e costantemente l’essere, ma secondo una prospettiva e un metodo, in questo rapporto dell’autore con la realtà, che implicano soprattutto l’uso della ragione, sia pure accettandone i limiti di salti e di svagatezze. E dunque su una linea di logos meditato e sofferto, che non si risparmia la denuncia dei ripensamenti e delle contraddizioni. Un logos capace, intanto, di non escludere affatto la voce interiore più immediata e di aderire fino in fondo alla misteriosa esperienza del vivere senza rinunciare alle memorie, ma attraverso l’obiettivo intelligentemente perseguito del “falò di se stesso” come forma di depurazione e di messa a fuoco più obiettiva.
Dal confronto con la realtà e dalla sua esperienza di vita, comprese le delusioni e le sconfitte, di Lieto esce con la volontà di dare testimonianza delle aporie del mondo attraverso la poesia (Poesis: “Universo di cose intuite, ‘reminiscenze’ o profezie, dimensione ctonia, nuvola di luce che si rompe, Verità subito riconosciute, segni-suono come scintille…”). Una poesia che è volta ad opporre la voce dell’intuizione e della ragione non solo e non tanto alla crudeltà degli uomini e delle loro azioni, ma alla sordità indifferente e alla miopia egoista. Al di là delle apparenze, non è poesia engagée alla maniera, che so, del così detto neorealismo. Se mai, si dovrebbe parlare piuttosto di poesia civile, cioè di un discorso che contempla e comprende la denuncia di un processo di contaminazione, di inquinamento, peggio di decomposizione, della natura e dell’uomo.
Col tempo, la vena illuministica di Giannino di Lieto si è andata evidenziando, con un progressivo spazio conquistato dalle idee come dinamica stessa della poesia. Così, sullo specchio delle personali reazioni e inclinazioni, si disegna anche la radiografia dell’altro da sé, al passo di una matrice della letteratura come parola dell’uomo. In questo senso, definito appunto illuministico, la poesia di Giannino di Lieto ha accentuato la sua portata in qualche modo “filosofica” a partire da un certo momento in poi, organizzandosi anche in forma esteriore come possibile “contenitore scientifico” volto a indagare per curiosità e per dubbi la realtà della vita e del mondo, oltre e dentro il grande silenzio che ci assedia (“questo silenzio concluso dal nulla”), nello sforzo di fare “meno buio” dentro la realtà che ci riguarda. Una realtà che, magari indefinibile nella sua essenza ultima e decisiva, comunque appare indagata per spicchi e settori dietro al bisogno di conoscenza che assilla e trascina l’uomo e dietro anche ai segnali che partono dalle cose stesse.
La vena illuministica si è sposata, da un certo momento in poi (abbandonando l’iniziale scansione verbale di specie ungarettiana), alla scelta formale di un continuum ritmico-sintattico che allenta i nessi logico-discorsivi facendo ricorso all’accumulo, senza rinunciare al passo lirico e con un piglio visionario e quasi oracolare di “babelicità” (secondo la definizione dello stesso di Lieto), come bene appare da un esempio anche sostanzialmente paradigmatico tipo quello di Realtà di un dialogo: “Sebbene il rischio onori ogni atto da isole di spazio / non altro naviga bifronte scaturire è dato un enigma / lo spinge da grembo un raggio caldo e la sua carne è l’albero di miele / forse questo tempo lontano dagli occhi nemico del tempo / compie il futuro avvolgendo l’identica tenebra fra le torri e la meraviglia…”.
La chiave di lettura è quella di un pessimismo dell’intelligenza di fronte all’evidenza della realtà e della resistenza della volontà che oppone, alla negazione, almeno la fermezza della dignità. Con l’occhio (“l’occhio è un lampo della notte”, in Teorema) capace di cogliere le forze in campo e di valutarne, altrettanto bene, gli aloni e i negativi. E con la bravura delle sottolineature nell’ampia gamma delle sfumature dell’ironia, dalla coloritura umoristica all’irrisione al sarcasmo, e nell’incrocio dei diversi modi e generi, alla ricerca di inedite possibilità per la poesia (si veda, ad esempio, la trafila mobilissima di L’abbonato impassibile – Le facce limitrofe). In una poesia in grado, per la legge dell’inversamente proporzionale, di ottenere con gli inserti visivi sviluppi aperti ed ulteriori e con le tonalità più leggere gli effetti più pungenti e mordaci. In una poesia che, senza rinunciare alle complessità delle possibili interpretazioni del reale e pur attraverso innovative sperimentazioni linguistiche, è comunque tale da essere “intesa”, compresa anche dagli umili e dai semplici, quelli che l’autore non ha mai smesso di considerare i destinatari dei suoi versi.
Di Lieto, ben consapevole della particolare condizione di chi vuol farsi poeta, portatore cioè di parole e di messaggi, non sente affatto esauste le risorse comunicative dell’uomo contemporaneo. Perciò è naturalmente portato a dilatare il suo discorso, ben inteso dentro un orizzonte ben preciso dei limiti umani, fino ai campi generali e agli universali cognitivi come quelli della “storia” o del “tempo”. E lo fa in una chiave appunto illuministica, in cui l’intelligenza è costantemente l’altra faccia della sensibilità e la scrittura, precisa e minuta, il complemento di una disposizione all’immaginazione.
Proprio la capacità immaginativa è il motore della poesia più stimolante di Giannino di Lieto: un’energia intellettuale, continuamente in movimento e tale da trasfigurare da immagine a immagine, in un vorticoso bestiario di esempi quotidiani e personali, di memorie e di ricordi (le presenze vive del padre e della madre ne sono al massimo grado l’esempio potente), in ogni caso decisivi nel disegnare un insieme dentro al quale passo dopo passo si evidenzia la riconoscibilità generale, attraverso una scrittura “per linee logiche, drammatiche o figurative”, senza per altro mai assurgere a nessun tipo di presunzione filosofica e restando anzi al contrario con i piedi ben piantati per terra dentro il nostro ordinario mondo quotidiano eppure nella consapevolezza frantumata di tutto quello che lo trascende.
Del resto, al centro della poesia di Giannino di Lieto, si è sempre posta la mitologia del quotidiano, còlta nel suo paesaggio privilegiato, quello di Minori, in particolare, e della costiera amalfitana: con i suoi interni ed esterni, case, strade, figure, oggetti, e nella globalità degli aspetti positivi e negativi, compresa la realtà del degrado e dell’inquinamento. Si tratta, è evidente, di una mitologia polemica nel segno delle felici sorti progressive di leopardiana memoria, a partire da quella spontanea vena speculativa dell’autore iscritta in una quotidianità che si serve di tutto e di tutti, che sa recuperare e spremere a suo vantaggio qualsiasi prassi e fantasia.
Elementi di paesaggio e di stagione compaiono nelle poesie, legati sempre ad una interiorizzazione che li depista rispetto al puro e semplice naturalismo (“Occhio della notte / che l’ostro annuvola / in falce d’ore / un fiume la raggela: / è l’alba chiusa nelle occhiaie / come la pioggia scava / disancorato vivere in deriva”, L’ombra intorno). La vita del mondo, riassunta e rispecchiata in quella dell’ora e della stagione o in quella degli agenti atmosferici, contro ogni apparenza contraria, è il polo dell’attenzione massima, per l’autore: il luogo poetico o l’area per eccellenza dell’innesco delle sue capacità decifratorie e rappresentative, insomma il nucleo più genuino della sua vocazione. Ciò che gli consente quell’intensità lirica che caratterizza le pagine dei suoi libri e quella particolarissima musica che replica in ogni singolo componimento di ognuna delle sue raccolte.
Ma va sottolineato ancora una volta che il discorso illuministico di Giannino di Lieto, sempre legato all’ottimismo della volontà contro il pessimismo dell’intelligenza, si risolve in chiave di “comunità”, nella sottolineatura di come determinanti e salvifici siano i rapporti tra gli individui: rapporti che possono ribaltare in qualsiasi momento e contro ogni apparenza la situazione con la forza rigeneratrice della loro umanità. Si tratta di farsi giusti interpreti di quella “infinità di voci” che si intrecciano sul palcoscenico della vita. E, per riuscirci, occorre disporsi all’ascolto con una sensibilità sempre nuova che cambia, sul piano comunicativo, con il mutare continuo della lingua.
C’è una misura partecipativa, nella poesia di Giannino di Lieto, un proiettarsi sempre oltre la barriera della propria vicenda e della propria storia, in una sorta di interrogativo aperto, che è la scelta del futuro o, se si vuole, la scommessa con la vita dietro alla meta irrinunciabile della dignità del vivere. Dentro questa misura di coinvolgimento di sé con gli altri, si dispone tutta la fitta trama dei percorsi interiori, dei rapporti interpersonali, degli incontri e delle relazioni, del quotidiano mettersi (o rimettersi) in equilibrio, tra l’ossessiva deiezione del tempo, sentita a fior di pelle, e il necessario umanissimo recupero di sé tra gli altri.
PAOLO RUFFILLI







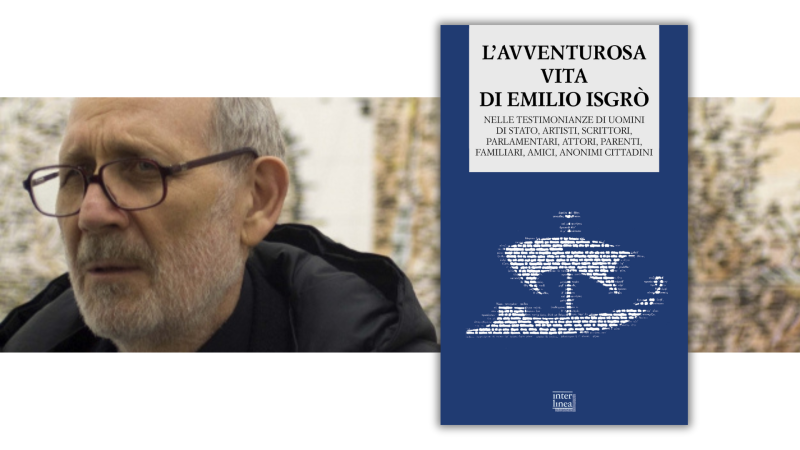

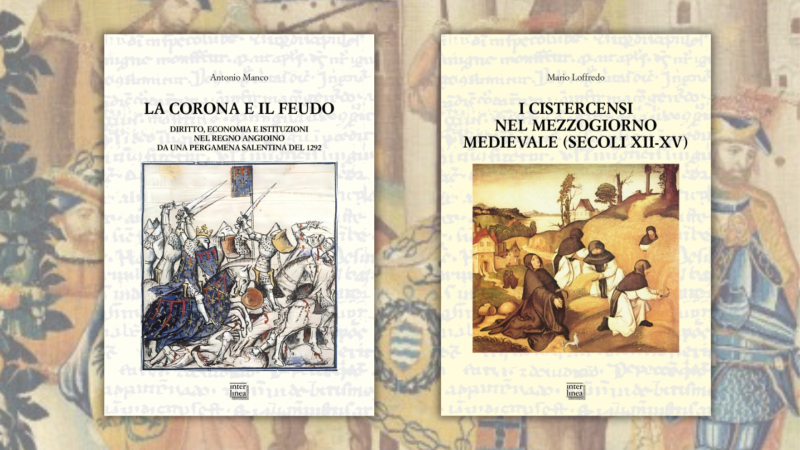
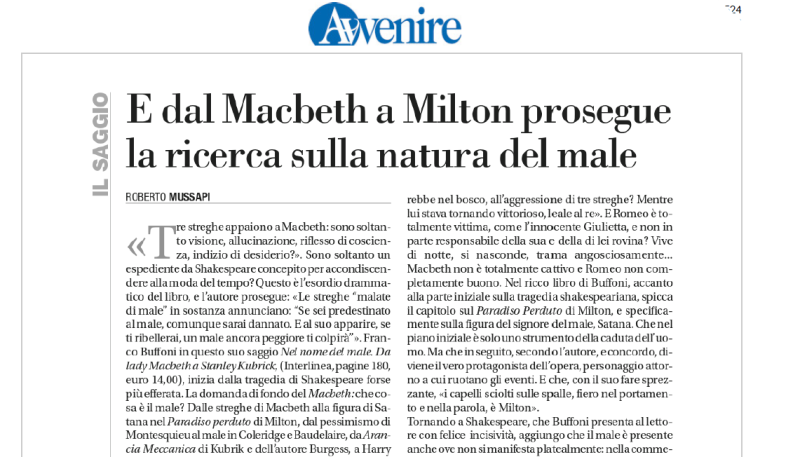


Inserisci un commento