La casa editrice Interlinea annuncia per il mese di marzo due novità, entrambe pubblicate nella collana “Passio” e legate alla crisi dell’uomo contemporaneo, di grande attualità in epoca di Coronavirus e all’avvicinarsi della Pasqua: Nosgnor. Lamenti, preghiere e poesie in cerca di un Dio vicino e lontano di Giovanni Tesio e e L’altra passione. Giuda: tradimento necessario? di Eugenio De Signoribus con una nota di Stefano Verdino.
Come scrive sant’Agostino, si prega «meglio coi gemiti che con le parole, più con le lacrime che con i discorsi». È allora possibile invocare un Dio di cui si sospetta l’assenza ma da cui si attende ostinatamente un segnale? Affidarsi a una disperata profezia d’esistenza che dissolva la propria voce in un silenzio assoluto? È la tensione di Giovanni Tesio che accoglie in questo suo diario letterario la quotidianità più arida e disarmata convertendo l’assenza-presenza spirituale in una oralità povera, di antica e per questo dialettale, ma sempre nuova, risonanza: «qui c’è non altro che parole: parole che tentano se mai di dire un pianto».
In anteprima un estratto dal libro:
« Al Dio che mi sfugge. Premessa
Questi sonetti appartengono a una mia necessità. Vorrebbero essere la denuncia di una personale inettitudine, ma nello stesso tempo la speranza di una conciliazione. Forse questi sonetti sono il frutto di una contraddizione e persino di una negazione, se è vero – come scrive sant’Agostino – che la preghiera si adempie «meglio coi gemiti che con le parole, più con le lacrime che con i discorsi». Qui, infatti, non altro che parole, parole che in questi miei versi tentano se mai di dire un pianto. Sono – se così mi posso dire – un alunno di una teologia negativa (penso poeticamente, e per estremi, a Caproni) ma nei miei sonetti cerco forse di esprimere un rimpianto, forse una nostalgia, forse un desiderio di grazia, di abbraccio, forse la dichiarazione di un avvento che finalmente si compia, ma di cui resto contraddittoriamente in sospetto. Lasciando andare le considerazioni che si potrebbero fare sul senso di una preghiera forse poco teologica, o magari poco “cristiana”, in ogni caso poco affidata, che contiene tuttavia il desiderio dell’affidamento, sono due, in breve, le considerazioni che intendo sottolineare. La prima riguarda proprio la fede, di cui la preghiera è in qualche modo lo specchio, e che in me è così claudicante da meritare il diniego (va da sé che questi sonetti sono il frutto di un “io” che rivela il suo sentimento di Dio, e che è dunque lirica volontà di confessione). Voglio dire che questi sonetti – da un punto di vista cristiano – altro non sono che preliminari di una vera e propria appartenenza, una sorta di propedeutica a un’ammissione che resta confinata in una soglia. E che dunque – su questo piano – non rappresentano una preghiera (che dovrebbe essere prima di tutto un tentativo di ascolto), ma un’ammissione di debolezza. Parlo, insomma, a un Dio che mi sfugge e che si sottrae, ben comprendendo che sono io a sottrarmi a lui, e che una specie di lotta ne viene, da cui dovrebbe scaturire la onsapevolezza di una “conversione”, che forse non verrà; di un ritorno, che forse non ci sarà. Prego un Dio di cui sospetto l’inesistenza ma da cui mi attendo ostinatamente un segnale. Mi affido a una disperata profezia d’esistenza che dissolva la propria voce in un silenzio estatico, assoluto. Ma tutto questo cerco di fare accogliendo la quotidianità più arida e disarmata; convertendo l’assenza-presenza in una oralità povera, di antica (sempre nuova) dialettale risonanza. Ed è questa, giustappunto, la seconda considerazione che intendo sottolineare: l’adozione del dialetto. Poiché non parlo di Dio, ma parlo a Dio (così distinguendo, Raffaello Baldini assegnava un senso e una direzione all’uso poetico dei dialetti), il mio dialetto può ben essere rappresentato nel comune concerto. Poiché a me pare che ci sia una ragione espressiva tanto più – in poesia – decisiva: la concretezza del dettato, l’energia dei suoni, il rustico e a volte ruvido nitore delle immagini, se è vero che, ad esempio, parlare di lucertole e di lamprede non mi riuscirebbe (o non mi riuscirebbe così) in un verseggiare in lingua. In altre parole, resto legato – anche in questi colloqui con i miei lacerti di Bibbia e con i miei intendimenti di Dio – al necessitante orizzonte di un’attesa che coltivo, e che qui risiede – sperando di non sbagliare – nell’indissolubile legame di parola che a quest’attesa dà (o cerca di dare) non so se buona voce. G.T.»
L’«altra passione» al centro di questo libro è quella di Giuda, l’apostolo che tradisce perché si possa compiere il sacrificio dell’amico e maestro Gesù. Il testo di De Signoribus cerca di comprendere le ragioni che portano all’atto suicida finale: il sentimento di colpa e l’impossibilità di pentimento. Al tempo stesso il poeta si chiede se il suo tradimento sia davvero necessario. La vicenda diventa così emblema dell’uomo contemporaneo alla continua ricerca di verità e di pace: «una sorta di monologo interiore che attraversa la storia con lo stigma della pietà e dell’interrogazione».
In anteprima un estratto dal libro:
«Postilla. (Immaginazione-conclusione)
Non volevo entrare nell’agone della Bibbia, non essendone che un improvvido lettore. Mi ci ha portato, in un percorso parziale (come accennato), il “discorso” su Gesù e Giuda, e quindi sulla violenza del contesto, e del testo, prima dei Vangeli.
Immaginavo da ragazzo, occhieggiando qua e là, col timore del sacro, che le vicende dell’Antico Testamento avessero una qualche familiarità coi poemi omerici: con la sostituzione però delle lotte tra gli dei, con la lotta di Dio con se stesso e con le sue creature; e dove gli esseri umani subivano la mutevolezza dei loro creatori, per le disobbedienze e volontà di conquiste, per i tradimenti e le punizioni… Gli scenari dei poemi li vedevo a colori, variamente aperti a figure di fantasia e a dolori umani reali, quelli degli sconfitti e quelli dei vincitori, tutti in qualche modo puniti, per i quali si era convocati alla disputa, al parteggiare, al dare forma sia alle figure femminili che a quelle maschili, eroiche o ridicole…
Questa “immaginazione” dell’età si era nutrita d’un breve inganno ottico, dovuto a un passo iniziale della Genesi (6, 4) in cui è scritto: «C’erano sulla terra i giganti a quei tempi – e anche dopo – quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli: sono questi gli eroi dell’antichità, uomini famosi». Un lampo. Tale da sembrare inopportuno, se non un errore. Dopo non si fa più cenno a questi eroi famosi, né vengono nominati. E si passa subito al racconto della malvagità degli uomini, alla determinazione di Dio di sterminarli radicalmente. Nell’Antico Testamento ci sono i bagliori della creazione e le prime figure umane, nude nella breve permanenza nell’Eden, l’apparizione dei giganti e, poi, il Cantico dei cantici e i detti del saggio Qoelet (Tutto è vanità in questo mondo, 1), le figure femminili di pace e le preghiere di invocazione e di ringraziamento diffuse nei Salmi (quelli privi di riferimenti alla violenza e alla vendetta contro i nemici e la loro prole – un libro così, davvero a parte, davvero “fondamento “ di consolazione e di preghiera, di Liturgia nella Chiesa a venire)…
Ciò nonostante, dato anche il mio stato d’animo incline a patire le esagerazioni, le diffidenze, le prove di forza e le cadute, inorridito dal sangue ed esasperato dall’immagine della morte (massificata, gratuita, senza un cenno di pietà), la vicenda biblica prendeva una strada più limitante e cupa: dalla vergognosa cacciata dal paradiso terrestre al fratricidio di Caino, dai continui ammonimenti di Dio al diluvio universale… Un enorme magma, pieno di crepe e voragini, nuove alleanze e nuovi tradimenti, promesse di castighi e castighi attuati, di guerre e stermini di nemici… Mi sembrava un’ossessiva cavalcata purgatoriale, continuamente minacciata, sferzata, senza possibilità di godimento d’altra luce, se non quella dell’eternità, premio per gli obbedienti alla legge divina, ai totalmente affidati alla sua guida. Mi sembrava inoltre che la messa in scena della drammatica prova di fedeltà (Abramo col figlio Isacco, ad esempio), la mancata comprensione dell’animo di Caino (e della sua mortificazione) e certe punizioni (quali, ad esempio, la distruzione della torre di Babele e la confusione delle lingue), non fossero segni di onniscienza, ma di mosse miranti al controllo assoluto, collettivo e individuale, della scacchiera umana, da lui stesso creata… Entrai dunque nella Bibbia col sacro timore di Dio. Ne uscii col timore di Dio, di un Dio dimezzato, in difficoltà con le sue creature, difficilmente addomesticabili, in difficoltà col popolo eletto, spesso disobbediente e insoddisfatto… E dunque un Dio terribile con gli insorgenti e i traditori, secondo una giustizia severa, senza appello, senza sconti per nessuno (o quasi) ».





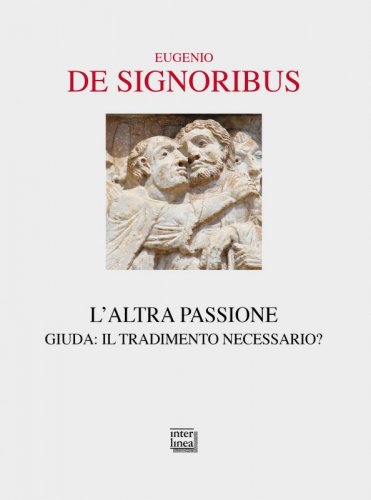








Inserisci un commento