L'Inferno di Dante riscritto in milanese di Carlo Porta
La Milano infernale nella satira di un grande poeta: per la prima volta raccolta in un'edizione a tiratura limitata le traduzioni in dialetto milanese dell'Inferno dantesco ad opera di Carlo Porta, tra emulazione e parodia, con introduzione di Pietro Gibellini
 La prima traduzione del poema di Dante in un dialetto italiano si deve a Carlo Porta. L’Inferno in versi milanesi, seppur frammentario, rappresenta il vero inizio della poesia portiana. Sospesa com’è tra emulazione e parodia, tra slancio verso il sublime e controcanto comico-realistico, la ricreazione dialettale produce un testo originale e assai godibile. Dispersi qua e là nelle edizioni delle poesie portiane, i frammenti dell’Inferno milanese sono qui riuniti, ordinati e riprodotti a fronte dell’originale dantesco. Il libro è introdotto da un ampio saggio di Pietro Gibellini e reca le retroversioni in italiano approntate da Massimo Migliorati.
La prima traduzione del poema di Dante in un dialetto italiano si deve a Carlo Porta. L’Inferno in versi milanesi, seppur frammentario, rappresenta il vero inizio della poesia portiana. Sospesa com’è tra emulazione e parodia, tra slancio verso il sublime e controcanto comico-realistico, la ricreazione dialettale produce un testo originale e assai godibile. Dispersi qua e là nelle edizioni delle poesie portiane, i frammenti dell’Inferno milanese sono qui riuniti, ordinati e riprodotti a fronte dell’originale dantesco. Il libro è introdotto da un ampio saggio di Pietro Gibellini e reca le retroversioni in italiano approntate da Massimo Migliorati.
«A mitaa strada de quell gran viacc
che femm a vun la voeulta al mond da là
me sont trovaa in d’on bosch scur scur affacc,
senza on sentee da podè seguità»
ACQUISTA SUBITO LA TUA COPIA
Vergine madre. Voce di donna nella Commedia di Dante, di Lucilla Giagnoni
Fino al 25 marzo 2021 disponibile in offerta a 10 euro
Lucilla Giagnoni è nata a Firenze nel 1964. Dopo la formazione alla Bottega teatrale di Vittorio Gassman, dal 1984 lavora come attrice ed entra a far parte della compagnia Laboratorio teatro Settimo partecipando agli spettacoli più significativi del gruppo tra i quali La Storia di Romeo e Giulietta (1990). Ha lavorato inoltre con Paola Borboni, Luigi Squarzina e con Alessandro Baricco e Gabriele Vacis ha realizzato nel 1998 Totem. È autrice di trasmissioni radiofoniche e dal 1996 scrive testi teatrali che interpreta sola in scena nel segno del teatro di narrazione: In risaia (1996), Atlante (2000), Chimera (2003).
ACQUISTA VERGINE MADRE
L'avevo chiesto io di farlo tirare su, quel muro. Certo, mi avevano detto, non si vedrà più il mare, ma sono stata accontentata. Un muro alto di pietre che si incastrano una sull'altra. Senza cemento. È che non volevo vedere niente, non volevo vedere nient'altro. C'è troppo mondo là fuori. Stanotte allungo una mano verso la lucciola, ma non arrivo a toccarla...
Ma forse, prima, devo affrontare un viaggio. A te, a me, convien tenere altro viaggio. Un viaggio. La Divina commedia è il viaggio: il viaggio di un uomo nel mezzo del cammin di sua vita che sta in una selva molto oscura.
In questo viaggio Dante segue il consiglio della Bibbia «Guai a chi è solo, perché quando cade non ha nessuno che lo rialzi!», perciò si fa accompagnare da Virgilio e poi da Beatrice. Io vorrei farmi accompagnare da Dante, oggi, stanotte, nel mezzo del cammino dela mia vita. Devo scendere anch'io prima di poter salire..."
Un brano dal libro:
I «sospesi»
Il racconto di Virgilio suona e si rivela come un’attenzione tutta interiore che l’antico poeta pone al dischiudersi, dentro di lui, di un nuovo mondo: l’apparizione di Beatrice ha naturalmente la vaghezza e il trasporto d’una delle apparizioni della Vita Nuova: la cui poetica ritorna qui attiva, stupendamente integrata da ogni altro acquisto; ma non vorremmo leggerla, questa volta, pensando al poi, collocandoci nel Nobile Castello, o guardando passare, fra la curiosità degl’infanti, delle femmine e dei viri, l’apparizione: vero che Beatrice nella seconda parte dell’incontro è richiesta di una nozione precisa: «la cagion che non ti guardi / dallo scender quaggiuso in questo centro»; ma la sua risposta, il canto della beatitudine che trasvola fra le miserie intatta, pur soccorrendo pietosa,
Io son fatta da Dio, sua mercé, tale
che la vostra miseria non mi tange,
né fiamma d’esto incendio non m’assale,
è tale che s’accorda con il primo senso dell’episodio, con l’incantesimo di un’apparizione interiore: l’inferno è vinto da quella luce. Conviene meditare un’altra parola su cui cade l’accento (e occorrerà ripetere che leggendo stiamo investigando di una sintassi d’immagini e di parole, non di periodi logicamente organizzati?):
Io era tra color che son sospesi,
e donna mi chiamò beata…
«Sospesi» significa l’anime del Limbo, nel loro destino fra la dannazione e la salvezza (nota che tutto è «sospeso» in questi tre prologhi dei primi tre canti: dal viaggio di Dante, incerto fra l’ombra della Selva e la luce del Colle, mentre cammina sulla piaggia, alla sorte già infera, ma non colma, degli sciagurati che mai non fur vivi: certo non adesso, morsi dai morsi della seconda morte). «Sospesi» significa, ancora, l’attesa di quel giudizio che, come risulta da molte allusioni, indirà la salvezza per talune delle anime del Limbo, disposte alla sorte di Catone, la cui veste sarà sì chiara al gran giorno, o di Virgilio, di cui Beatrice si loderà al cospetto dell’Onnipotente: quando il tempo sarà consumato, nella seconda parusia del Cristo Pantocratore e Giudice, avranno forse la sorte che le anime fedeli dei credenti in Cristo venturo ebbero alla prima parusia, guidate al cielo dal Possente «con segno di vittoria coronato»:10 quelle anime degne che vissero in terra disponendo i tempi alla divina giustizia, fondando nella giustizia uno degli elementi del regno «giustissimo e pio» del cielo Empireo, operosi in un disegno divino che la Provvidenza venne svolgendo nel tempo. Sospesi significa (ed è il senso che meglio s’attaglia qui a Virgilio) assorti nella maraviglia dell’apparizione beata. D’un tratto, e senza che nulla dei versi precedenti nel canto primo e secondo ce lo lasciasse prevedere, i modi poetici si rifanno alla lirica giovanile: solo circostanziata qui con nuova fermezza:
Lucevan li occhi suoi più che la stella
e cominciommi a dir soave e piana,
con angelica voce…
Petrarca si ricorderà di questa apparizione: «un’angelica forma, un vivo sole fu quel ch’io vidi» e appunto nel sonetto di una terrena volontà di eternarsi… E la favella che parla Beatrice non è un linguaggio di Paradiso, una convenzione linguistica stretta fra i Beati, ma il prolungarsi in una sfera ampia e sonora della sua voce, il volo della sua parola, l’acquisto, pur qui, di una eternità beata, traverso l’opera e la parola terrene. Quando nel primo canto Virgilio si presentava a Dante, la sua storia era circoscritta nel tempo e nello spazio; ma qui la menzione stessa delle origini dell’anima cortese «mantovana» è rapita per entro l’infinità del moto, risollevata quasi nell’altissimo cielo, l’ampio cerchio dove Beatrice arde di tornare.




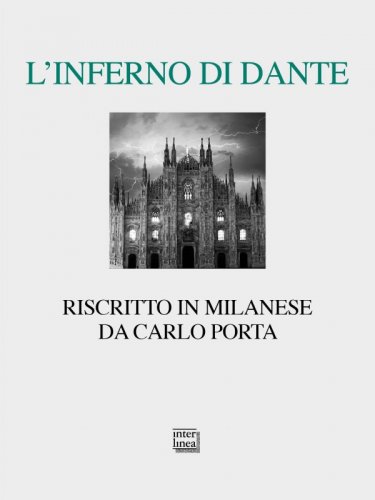





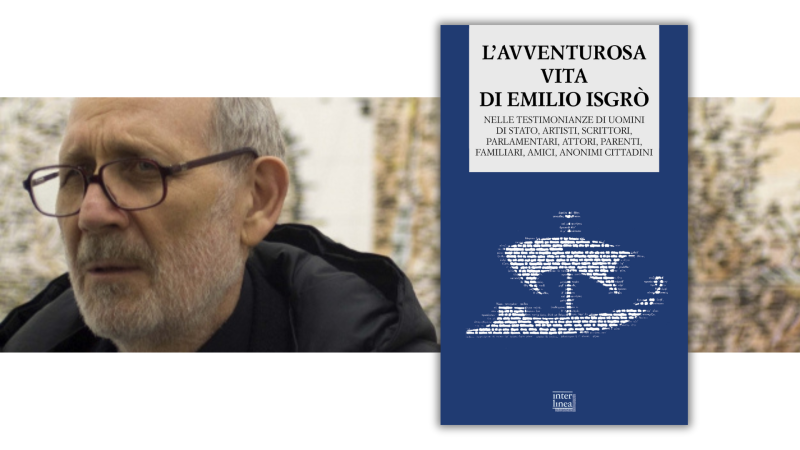

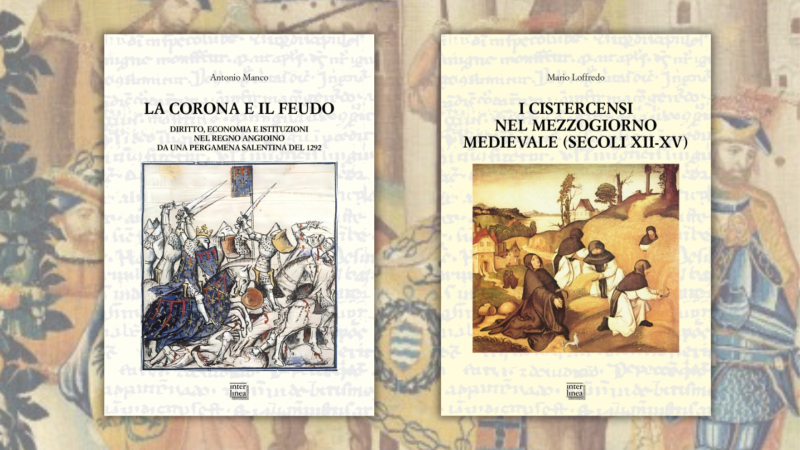
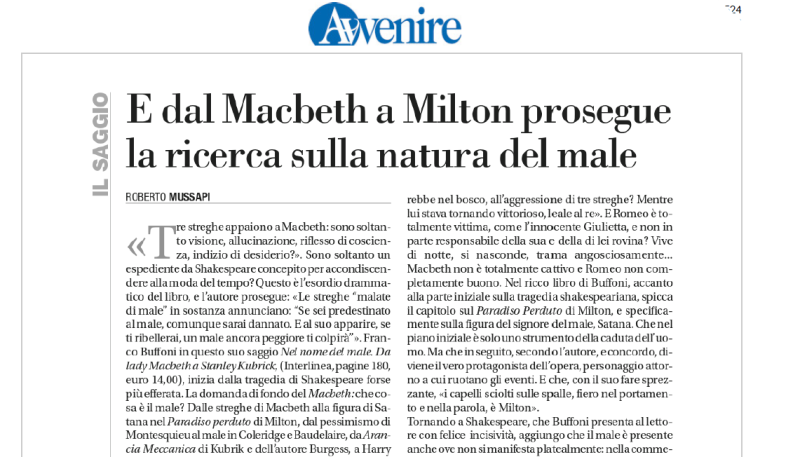


Inserisci un commento