«Fai attenzione alle piccole cose, perché un giorno ti volterai e capirai che erano grandi» quanto ha detto Jim Morrison sembra valere ancora di più dopo il periodo dell’emergenza sanitaria. Francesca Rigotti, che vive e insegna tra la Germania e l’Italia, con la sua Nuova filosofia delle piccole cose ci aiuta a imparare nuovamente a «guardare, toccare, ascoltare intensamente gli oggetti che ci stanno intorno e le attività che svolgiamo quotidianamente, anche se considerate ripetitive, minori, piccole». È la valorizzazione delle “piccole cose” di tutti i giorni: il sapone, la tazza di caffè, la scopa, le forbici, ma anche lo smartphone o i cosmetici... Una filosofia nuova con molti aspetti al femminile, ma per tutti coloro che vogliono far qualcosa – come recitava un vecchio slogan pubblicitario – contro il logorio della vita moderna. Un podcast di Roberto Cicala.
L'autrice
Il libro
«Piccole cose che insegnano a pensare» (“Il Sole 24 Ore”), «libriccino che ci aiuta a reimparare l’esercizio smarrito di riconoscere il significato delle cose che la cultura egemone ha decretato insignificanti» (“Corriere della Sera”). Di un libro di culto per lettori esigenti ecco una nuova edizione aggiornata con molte “piccole cose” attuali per imparare a «guardare, toccare, ascoltare intensamente gli oggetti che ci stanno intorno e le attività che svolgiamo quotidianamente, anche se considerate ripetitive, minori, piccole». È la valorizzazione delle “piccole cose” di tutti i giorni: il sapone, la tazza di caffè, la scopa, le forbici, ma anche lo smartphone o i cosmetici... Una filosofia nuova con molti aspetti al femminile, ma per tutti coloro che vogliono far qualcosa – come recitava un vecchio slogan pubblicitario – contro il logorio della vita moderna.
Di seguito potete leggere un estatto dal libro:
Il sapone
Nell’Olanda del secolo XVII , l’epoca in cui l’ammiraglio Trump issava la sua scopa sul pennone della nave, un ruolo emblematico interessante lo giocava anche il sapone. Nella letteratura popolare edificante esso veniva associato al sale, non solo perché iniziano con la stessa lettera (che in olandese è la z: zout en zeep, “sale e sapone”), ma perché rappresentano aspetti gemelli della condizione umana. Il sale sta per l’umano intelletto, ingrediente senza il quale l’esperienza sarebbe insipida e poco edificante. Il sapone invece sta per la virtù che lava, pulisce e purifica ogni cosa.
Quello della pulizia morale è un vecchio topos metaforico che ci proviene sia dalla tradizione ebraico-cristiana sia da quella della Grecia classica: «Lavami, mondami», chiede al Signore il pentito sincero del Salmo 51, «lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato». Fa eco a questa invocazione un passo della Lettera I, 21 di Giacomo: «Deponete ogni immondezza e ogni cattiveria».
Già sappiamo che ciò che è pulito è anche piccolo, bello, netto e ordinato. Potremmo cercarne conferma nel sostantivo italiano “mondo”; esso designa il globo terrestre ma anche, per estensione, l’universo, perché lo si pensava pulito, ordinato (e forse lo era; adesso un po’ meno), e magari anche decorato e truccato come il cosmos greco. Il quale, prima di essere mondo, universo, ordine mondiale, è ornamento e abbellimento. Come dire che è dai cosmetici che deriva il cosmo, e non viceversa. E questo (e molto altro) nonostante Platone, che demonizzava la cosmetica considerandola frivola e ingannatoria, e poi era il primo a definire il procedimento diacritico, cioè della separazione di ciò che era congiunto – da far precedere al momento dell’unione e della strutturazione del molteplice dalla prospettiva dell’unità – come katharmós, “purificazione”.
In senso morale, in conclusione, la persona è integra e virtuosa se la sua anima è lavata dalla sporcizia. E che cosa la pulisce a fondo, oltre naturalmente all’acqua, da sempre presente nei riti di purificazione e iniziazione? Il sapone!
Si potrebbe parlare a lungo del sapone: il sapone è morbido, fa la schiuma, fa le bolle, scivola e scompare nella vasca, si consuma tra le mani fino all’esaurimento totale, fino a che proprio non c’è più. Un inizio soave e schiumoso, e poi un finale netto, totale, definitivo.
È questo che piace del sapone a Francis Ponge, tanto da portarlo a variare sul tema per ben venticinque anni, dal 1942 al 1967, data di pubblicazione dell’opera dedicata a questo materiale e che porta il titolo omonimo: Le savon
Le savon a beaucoup à dire. Qu’il le dise avec volubilité, enthousiasme. Quand il a fini de le dire, il n’existe plus.
Per sgrassarsi e pulirsi bene l’acqua pura non basta, ci vuole anche il sapone, sostiene Ponge; e come la toeletta del corpo ha bisogno del sapone, così ne ha bisogno anche la toeletta intellettuale. Per questa non bastano le parole, neanche in forma di preghiera, e nemmeno il silenzio: occorre mettersi in mano – continua Ponge – o in bocca (in bocca?), qualcosa di più materiale, qualcosa che somigli di più alla parola... insomma: un pezzetto di sapone.
Ponge ama il pulito. Amerebbe anche i filosofi puliti, se ci fossero. Ma non ce ne sono, perché i filosofi sono sporchi. A questa affermazione Derrida, nel suo commento a Ponge, ribatte con una domanda semplice ma pertinente:
Pourquoi les philosophes seraient-ils, sans compter toutes leurs autres insuffisances, sales?
La domanda se l’era posta anche Sartre, che vi aveva dedicato persino un dramma, Les mains sales. Ma lì si trattava delle mani del politico, immerse fino ai gomiti nella merda, nel sangue e nel fango della corruzione, delle scorrettezze, dei tradimenti, della protezione degli interessi personali.
Qui si tratta invece proprio delle mani del filosofo. Hegel, per esempio, scrive Derrida scrivendo di Ponge,
n’est pas très propre, et il faut, après l’avoir lu, se laver, on dirait même, s’en laver les mains.
Einfatti a Hegel e Schopenhauer Ponge preferisce senza dubbio La Fontaine, perché è meno stancante e più divertente e perché più pulito. Chissà che cosa avrebbe pensato Ponge di Kant, se avesse saputo che il filosofo prussiano disprezzava La Fontaine, ritenendo i suoi racconti di fate «le fole più miserabili [...] inventate dalla follia francese», fole ancora peggiori – sentenziava Kant - delle Metamorfosi di Ovidio e delle poesie di Anacreonte, degne al più di rientrare nella categoria del bello, non certo del sublime!
Perché Ponge riteneva La Fontaine pulito? Pulito? Forse sarebbe meglio andare a rileggere la descrizione del sapone, dove il poeta dice e ripete che la sua caratteristica quintessenziale è che gira e gira tra le mani, parla parla fino a esaurimento completo. Ci avviciniamo alla spiegazione: i filosofi sono sporchi e persino un po’ disgustosi perché non sono capaci di fermarsi, di tagliare, di farla breve e infine di mettere una firma a conclusione delle loro elucubrazioni, La Fontaine invece sì.
In effetti, «pour signer il faut arrêter son texte» mettendoci la firma, e nessun filosofo concluderà e firmerà il suo testo perché il filosofo nega l’idioma del suo nome e della sua lingua e parla per concetti e generalità necessariamente impropri (esclusivi, caratteristici), nel doppio senso del francese propre: pertinente e pulito.
Ponge invece, conclude Derrida, ha il nome giusto per mettere fine e cancellare le tracce delle parole scritte col gesso sulla tavola o sulla lavagna (Ponge suona quasi come éponge, “spugna”). Ponge ama il pulito perché gli basta poco per passare un colpo di spugna e mettere la parola fine.







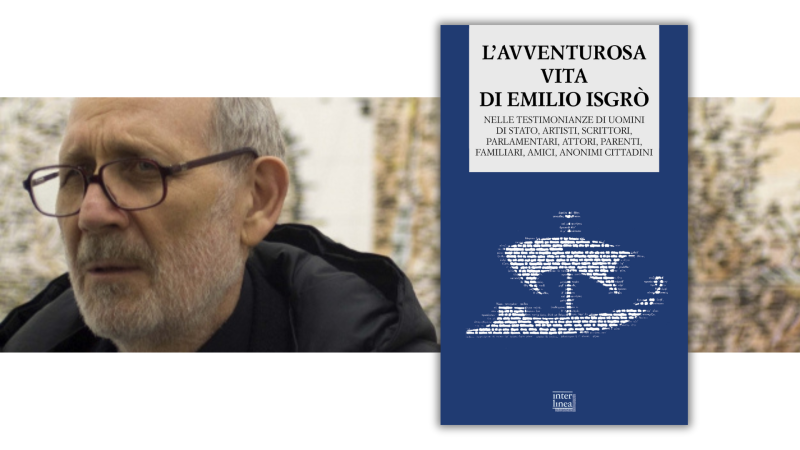

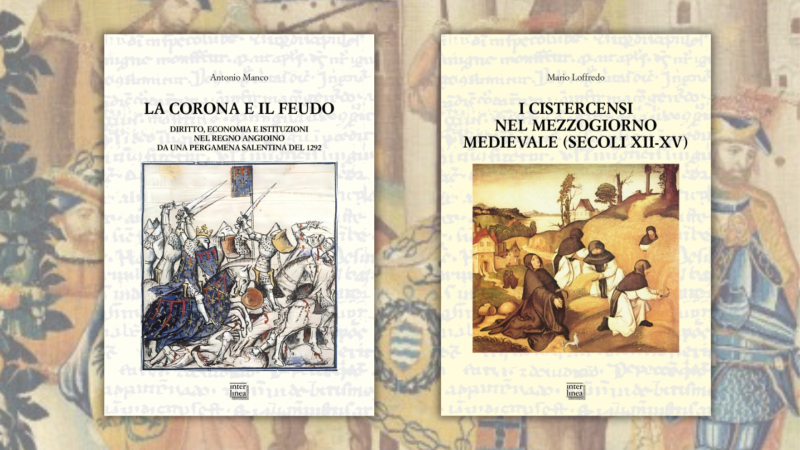
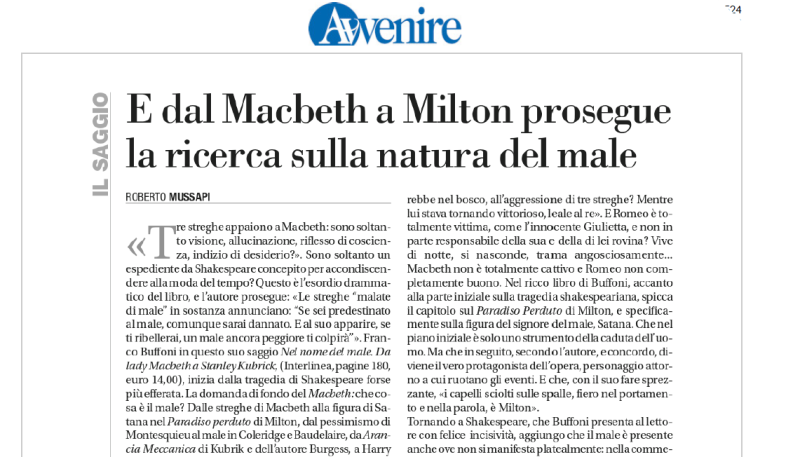


Inserisci un commento