Dopo l'antologia di voci poetiche Nell'abisso del lager una nuova raccolta di testi di narrativa completa la ricerca del professor Giovanni Tesio sulle possibilità di scrivere e raccontare nel e dopo il lager: Nel buco nero di Auschwitz. Voci narrative sulla Shoah racconta la tragedia dell'Olocausto attraverso le parole di grandi autori come Primo Levi, Anne Frank, Etty Hillesum, Jean Améry, Peter Weiss, Friedrich Dürrenmatt e David Grossman
«Si è testimoniata l'esistenza di un universo plurimo, l'esistenza di un caos quasi primigenio che questa antologia vuole in qualche modo manifestare. Voci naturalmente diverse, che cercano di dare l'idea di quello che Auschwitz emblematicamente è stato, di cio che la nostra memoria dovrebbe conservare per essere cittadini più provi e civili» (Giovanni Tesio)
«Che romanzi volete che ci siano, dopo Auschwitz e Buchenwald?» scriveva Carlo Levi, riflettendo sulle possibilità letterarie del “dopo”. Eppure molti hanno scritto, in tempi e modi diversi, rispondendo a un bisogno e anche a un dovere, a una necessità morale. Alcuni di essi, tra i più significativi, sono raccolti in questa antologia, da Primo Levi ad Anne Frank, da Etty Hillesum a Jean Améry, da Peter Weiss a Friedrich Dürrenmatt e David Grossman, presentando insieme – seppur separati – sia chi, avendo vissuto l’esperienza del lager, ne ha dato testimonianza sia chi, invece, non avendola vissuta personalmente, ne ha però fatto oggetto di elaborazione letteraria. Nel buco nero di Auschwitz è un’antologia che «nel nome dei senza voce, dice quanto può attraverso la voce di chi è sopravvissuto e di chi su quelle voci ha costruito il racconto infinito dell’offesa che non deve sottomettersi a nessuna vergogna» (Giovanni Tesio).
Leggi gli estratti:
Luglio torrido, afoso, vestiti che appiccicano. Cerchiamo di riprendere fiato. Mai stati qui prima d’ora. Sulla panchina sotto i salici, lungo le sponde dell’Odra [Oder]. Quasi sopra di noi, un ponte ferroviario sul quale passa sferragliando un interminabile treno carboniero in direzione di Breslavia. Questa è la tratta di collegamento con il bacino carbonifero. Dunque anche con Auschwitz. Coloro che vent’anni fa passarono sferragliando sul ponte e che forse sbirciarono dalle fenditure dei carri bestiame in cui erano stati ammassati e riuscirono a riconoscere questi prati e questo fiume, due ore più tardi non erano che fumo che saliva dai camini di Birkenau, rendendo impercettibilmente più caliginoso il cielo sempre grigio dell’Alta Slesia. Ciò che passava sul ponte era fumo, fumo nella forma transeunte di uomini, donne e bambini.
Sì, anche lei viaggiò in uno di questi treni che sono passati sferragliando sul ponte. Non le servì a nulla aver educato le sue allieve della Westfalia alla letteratura tedesca. A nulla aver piantato in asso a ventiquattro anni, durante la prima guerra mondiale, il suo Husserl per adempiere il suo dovere patriottico curando i soldati tedeschi in un lazzaretto; e a nulla essere ritornata nel 1919 a Lublinitz con tutta la sua numerosa famiglia per partecipare a ogni costo alle elezioni, nel momento in cui era in gioco il riconoscimento della germanicità di quei territori. (Verosimilmente questo viaggio collettivo dovette assomigliare a «una famiglia in fuga nel 1939»
o a una sua prova generale, ma chi avrebbe potuto prevedere allora una simile analogia?) No, nulla di tutto questo è servito, nulla di tutto questo è stato utile, in quanto l’essere apprezzati o inceneriti non dipende da noi, e nemmeno dal fatto che ci percepiamo come appartenenti – che cosa significa «percepire» – e nemmeno dal fatto che diamo prova della nostra appartenenza sacrificandoci – chi, il giorno dopo, ricorda ancora il sacrificio compiuto, con il sacrificio proprio no, nel modo più assoluto. Dipende invece esclusivamente da coloro dei quali desideriamo fare parte e da ciò che tramano e dall’uso che possono fare del nostro esserci o del nostro non-esserci. [...]
Non potremo mai sapere nulla di ciò che accadde, come potrebbero esserci infatti nel mondo dei vivi dei testimoni ancora in grado di raccontare qualcosa? Credo tuttavia che sia senz’altro ipotizzabile, possiamo dire addirittura probabile, che l’infelice abbia dovuto pagare un prezzo terribilmente alto: che lei non sia stata cioè insultata e umiliata come gli altri solo dagli assassini, ma anche da coloro con i quali fu costretta a condividere il viaggio. Avrebbero dovuto essere degli angeli per non vedere in lei l’apostata o la rinnegata, e non trattarla come tale! Solo chi è senza peccato scagli la prima pietra.
Günther Anders, Discesa all’Ade. Auschwitz e Breslavia, 1966, Bollati Boringhieri, Torino 2008
*
DAVID GROSSMAN*
E bisogna dire che il nome vero e completo di Momik è Shlomo Efraim Neuman. Chiamato così col nome di e col nome di. Se fosse stato possibile, gli avrebbero affibbiato cento nomi. Nonna Heni lo faceva sempre. Lo chiamava Mordechai Leibele e Shepsele e Mendel e Anshel e Sholem e Homek, e Shlomo-Haim, e Momik aveva imparato così a conoscerli tutti tutti. Mendel che era andato in Russia a fare il comunista, nebech, ed era scomparso lì, e Sholem l’yiddishista, che era partito col piroscafo per l’America e il piroscafo era affondato, e Isser che suonava il violino ed era morto dai nazisti che Dio li stermini e li stramaledica, e Leibele e Shepsele che erano piccolini, che per loro non c’era più posto a tavola, la famiglia allora era così grande, e il babbo di nonna Reni diceva a tutti che mangiassero come si mangia dai signori, e loro mangiavano per terra, sotto la tavola, buoni buoni, e Shlomo-Haim che era diventato uno sportivo campione, e Anshel-Efraim che scriveva poesie così belle e così tristi e poi era andato a vivere a Varsavia e lì era diventato, nebech, uno scrittore ebreo, e tutti tutti quanti se n’erano andati coi nazisti che Dio li stermini e li stramaledica, un bel giorno erano piombati sul borgo, e avevano preso tutti quelli che erano lì e li avevano portati in un cortile vicino al fiume e-ahiii, e Leibele e Shepsele resteranno per sempre piccolini a ridere lì sotto la tavola, e Shlomo-Haim, che era mezzo paralizzato ed era guarito per miracolo, ed era diventato proprio un eroe Sansone, resterà sempre a muscoli gonfi lì nell’olimpiade delle borgate ebraiche sullo sfondo del fiume Prut, e il piccolo Anshel, che era sempre stato il più debolino di tutti, e avevano sempre paura che non passasse l’inverno, e gli mettevano mattoni caldi sotto il letto perché non gelasse, eccolo qui seduto calmo calmo col vestito alla marinara, con una buffa scriminatura in mezzo al capo, e dei grandi occhialoni sugli occhi seri, così Iddio non mi conceda vita, e la nonna batteva le mani, se non è vero che tu gli assomigli tanto. La nonna gli raccontava storie di loro, un monte d’anni fa, quando lei aveva ancora la memoria sana, e quando tutti credevano che lui non fosse ancora arrivato all’età in cui si comincia a capire, ma quando la mamma gli aveva visto negli occhi che lui non guardava quelle fotografie solo così per fare, subito aveva detto alla nonna di smetterla, e aveva perfino nascosto l’album con quelle belle fotografie (pareva che l’avesse dato alla zia Itka). Ora Momik cerca con tutte le forze di rammentare cosa precisamente ci fosse in quelle fotografie e in quei racconti. Ogni cosa nuova di cui si rammenta subito l’annota. Perfino piccolezze che gli sembrano senza importanza. Perché questa è una guerra, e in guerra si deve far tesoro di quel che c’è. Così fa anche lo Stato d’Israele che è in guerra con gli arabi psiakrew. È vero che Bella a volte l’aiuta, ma non tanto volentieri, e la parte più grossa lui la deve fare da sé. Momik non ce l’ha con Bella, niente affatto è chiaro lampante che chi era stato in Quel Paese non avrebbe potuto dargli delle indicazioni vere e proprie, e nemmeno lui avrebbe potuto chiedere a uno di loro aiuto in maniera semplice e diretta. Si vede che loro avevano un mucchio di leggi fatte così con l’obbligo di serbare il segreto, lì in quel regno.
David Grossman (1954), Vedi alla voce: amore, Einaudi, Torino 1999, traduzione di Gaio Sciloni.



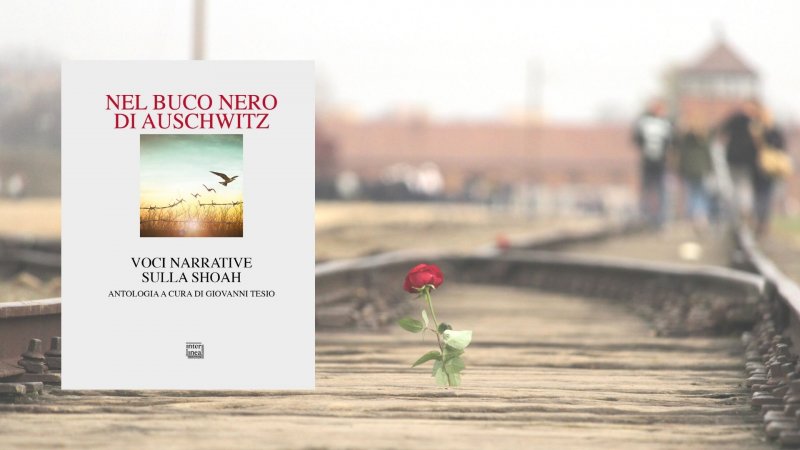
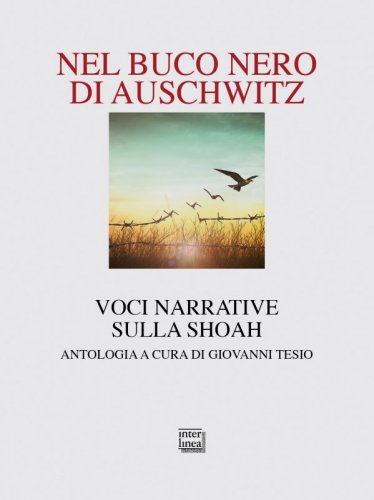



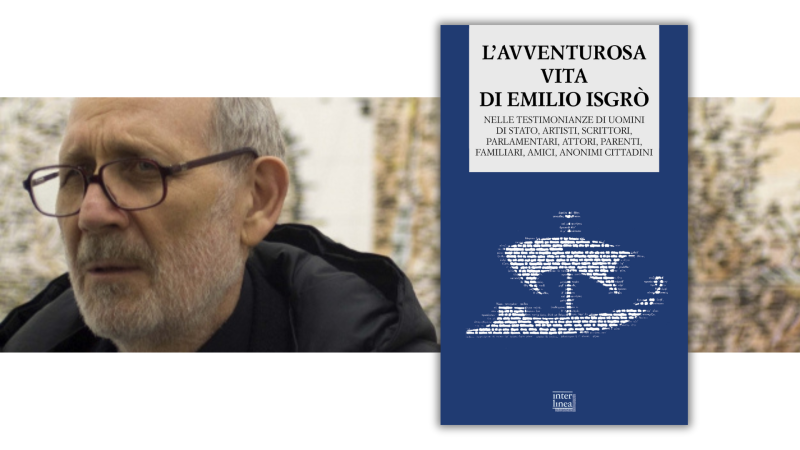

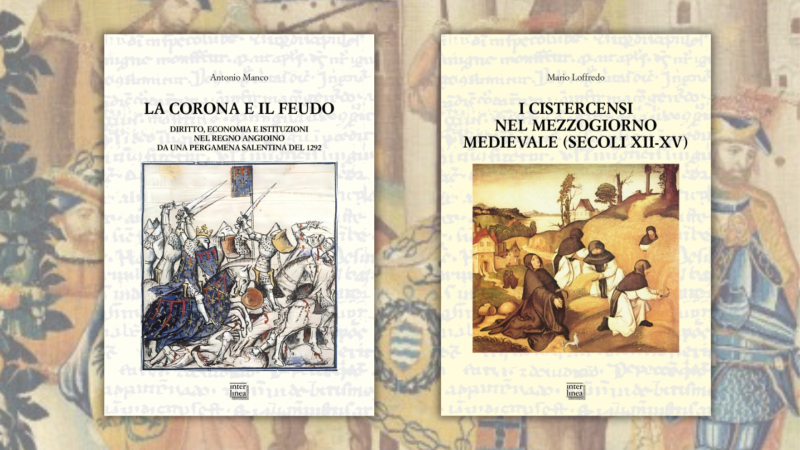
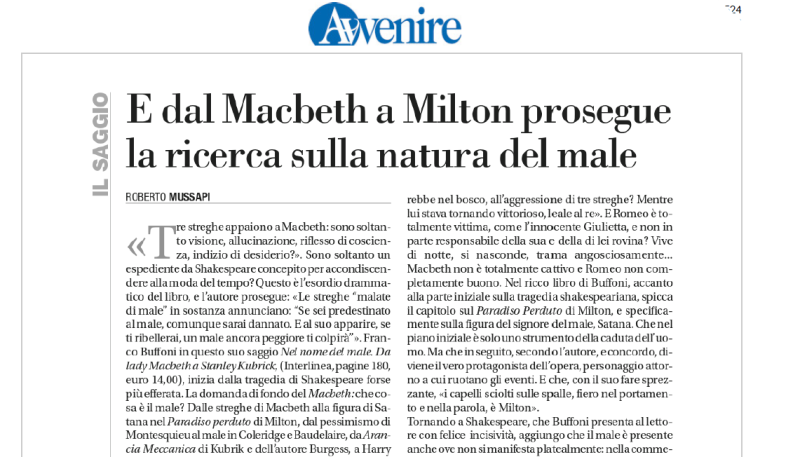


Inserisci un commento