Il 18 settembre 1922 nasceva il poeta e traduttore Luciano Erba. L’editore Roberto Cicala ricorda l’amico, consulente di Interlinea ed autore di vari titoli nonché curatore di un’antologia di successo, Natale in poesia nel centenario della nascita.
«Irruzioni d’azzurro» nella nebbia padana: ricordi di Erba «tranviere metafisico»
«Sui prati rimane un po’ di nebbia» fin dagli anni cinquanta nel paesaggio poetico lombardo più caro a Luciano Erba ed è fittissima la nebbia di una sera d’autunno di trent’anni dopo, ormai trent’anni fa, alla ricerca di un ristorante nel «nulla indistinto» della pianura. Rivedo il poeta con il volto incollato al parabrezza della Due cavalli bianca intento a scorgere segnali stradali e trovare aggettivi in più lingue per tale nebbia, dopo la rappresentazione teatrale organizzata con amici in una chiesa sconsacrata di Novara sul suo Tranviere metafisico da poco pubblicato. Proprio l’innamoramento per quel volumetto azzurro, arrivato per posta nel pacco riservato agli Amici del Libro Scheiwiller, senza averlo richiesto espressamente e perciò scoperta ancora più gradita, segna l’inizio di un rapporto divenuto, nel tempo, amicizia.
Quella sera, con la moglie e le figlie, è presente l’amico editore Vanni, di cui è sodale fin dai tempi del Blu Bar di via Meda frequentato il sabato pomeriggio con Piero Chiara e Bartolo Cattafi tra vecchi e giovani della letteratura italiana di Milano, compresi Vittorio Sereni e Maria Corti. Invece nel ristorante novarese, davanti a una paniscia contadina e a un Ghemme d’annata, quella sera si parla più di letteratura che di editoria, perché ci vorranno ancora alcuni anni per il passaggio di testimone, in formati sempre piccoli e di poesia, dei testi del mistico Clemente Rebora e dello stesso «tranviere metafisico» Erba tra il maestro milanese dei Pesci d’Oro e il discepolo novarese nel segno di Interlinea, alla ricerca di domande più che di risposte.
«Ed io ospite di quale sera?» è una dei molti interrogativi a bruciapelo con cui il poeta incontra i lettori ai crocevia dei suoi testi invitandoli in itinerari esistenziali che spesso, per gli amici, fanno tappa sul terrazzo fiorito di via Giason del Maino («abito a trenta metri dal suolo / questo era cielo, mi dico»): qui sono legati molti ricordi e, con un bicchiere sempre fresco, confidenze di attese e delusioni di un uomo riservato e curioso attento a rifuggire per abito morale il «povero monologo / di domande e risposte fatte in casa».
Non di sole letture si discute (ma in poesia mette sempre sul piedistallo A Silvia di Leopardi), mentre si avvicina l’amato gatto (un’antologia sui felini in poesia resta tra i progetti non andati in stampa) o passa una delle figlie (di cui lascia scritti tre versi di grande affetto: «come è possibile / che tutto un mondo si colori di mattino / se vi tengo per mano»). Una volta, con un bianco francese per aperitivo, ripensa ai luoghi di nascita delle sue ragazze che riflettono la personale vocazione comparatistica nella letteratura e nella vita: Lucia è venuta alla luce a Parigi, prima del trasferimento negli Stati Uniti, dove è nata Francesca dalla «bella scrittura un po’ tonda», mentre Caterina è nata a Lugano, dopo che il visiting professor torna in Italia per essere vicino al padre ammalato. Da uno dei suoi viaggi conserva il ricordo della citazione preferita, entrata in un testo lirico: «Questo epitaffio / sta scritto nell’Abbazia di Westminster / dice perplexus vixi incertior moriar / potrebbe essere il mio, più l’incertezza di là a venire / dunque poscritto / ma la speranza è l’ultima a morire».
Una sera scherza in terrazza sul suo essere poeticamente «stitico», aggettivo usato dalla moglie Mimia, e ci sono cari amici che sorridono, come Silvio Ramat e Umberto Eco, il quale propone a noi commensali più vicini di scambiare i bicchieri per confondere sua moglie e non farle notare che sta bevendo whisky. Sulla vocazione del poeta a scrivere in modo parco e in levare restano frammenti di memoria in qualche lettera: una volta l’editore del Pesce d’Oro gli manda in anticipo gli auguri di compleanno, il 15 settembre del 1965, «anche se avrei preferito farteli, gli auguri, con una tua plaquette di poesie», aggiungendo: «quando potrò leggere le poche cose nuove?» In verità i punti interrogativi della lettera manoscritta sono due, a marcare maggiormente l’auspicio. Sulla parsimonia testuale (con cui la qualità ha la meglio sulla quantità) è chiara anche una lettera riferita alla plaquette allestita per uno degli ultimi riconoscimenti ricevuti, il premio alla carriera del festival internazionale di poesia civile di Vercelli: «le poesie sono solo 10 ma diventeranno 12 se non viene meno la tua buona volontà» mi scrive il 21 luglio 2005 preparando Un po’ di Repubblica.
Quando Milano è immersa nella nebbia e il ghiaccio fa luccicare i binari degli amati tram preferisce parlare con gli ospiti rintanandosi nello studio, tappezzato di libri su quattro lati («la mia schiena si è incurvata sui libri» ammette in un’intervista). Progetta edizioni, senza mai fretta: per esempio è ricorrente l’idea di una nuova raccolta di versioni di Cendrars, rinviata anche per ragioni di diritti, prospettando una «rilegatura inconsueta» ad album «per i versi lunghi». Da traduttore predilige gli autori francesi e se prende in mano Cyrano de Bergerac lo soppesa in aria come fa con pochi altri tomi: va fiero del lavoro fatto su tale capolavoro secentesco.
Capita che apra cassetti della scrivania o cartellette dietro di lui che contengono appunti o fogli che chiama «antichi» e una volta svela un quaderno nero di scuola con poesie di gioventù, di cui ne salva non più di tre rileggendo a voce alta, con timbro ironico, di «rotaie tra file di case» che «conducono / al sole grande e rosso all’orizzonte». Cercando sue carte per un’autoantologia, quasi si scusa se preferisce scrivere a mano, come fa in un brogliaccio scrigno per ispirazioni successive, quando poi ricopia i testi composti con la sua Olivetti, come quella che inaugura nel marzo del ’47 scrivendo a Gianfranco Contini, maestro a Friburgo dopo la fuga per non aderire alla Repubblica di Salò, prima di fare il correttore al “Corriere” e il corrispondente di un’agenzia americana. Quella volta al filologo domese scrive «con la morte nel cuore» per aver mancato un incontro con lui alla stazione Centrale per colpa di una ragazza. Si sente artigiano della parola e al massimo spedisce i suoi messaggi manoscritti via fax su quella carta chimica che purtroppo si scolora con il passare degli anni fino a far svanire del tutto traccia delle parole.
È un vero appassionato del tempo natalizio– Natale in poesia da lui antologizzato e prefato resta un long seller nella collana “Nativitas” e di quanti presepi su tela va alla ricerca una volta che visitiamo gli Uffizi – e infatti nel periodo delle feste di dicembre con chi viene a fargli gli auguri di persona ama chiacchierare sul divanetto davanti al presepe, che Mimia prepara con devozione e creatività. È l’occasione di qualche ricordo d’infanzia o di accenni alla fede, per lui un tutt’uno con la cultura, fin dagli anni dell’Università Cattolica, luogo di formazione tanto ricevuta quanto praticata in decenni di insegnamento. Più di una volta la commozione lo prende se ricorda David Maria Turoldo e Camillo De Piaz, insieme con lui allievi di Mario Apollonio, nome che accosta a Giuseppe Lazzati che assisteva nella redazione dell’“Italia giovane” (con lui rammenta anche una gran sciata in Alto Adige) con lo stesso entusiasmo di quando, nella maturità piena, scriverà:«Interroghi l’alfabeto delle cose / ma al tuo non capire niente di ogni sera / sai la risposta di un mazzo di rose?» Degli anni di studente universitario ricorda pure le visite al filosofo monsignor Olgiati nello studio in Arcivescovado, «circondato dai suoi numerosi gatti e da infiniti libri»come può dirsi anche della casa del poeta. Ma la sua lirica domestica è capace, come i suoi gatti, di graffiare, come in questo caso riferito a un tuttologo in tv: «Di profilo ha la faccia da fesso / di faccia il profilo è lo stesso».
Da sempre condivide il «cerco e non trovo» del rosminiano Rebora e fin dalla morte di questi s’impegna su “Vita e Pensiero” a non far spezzare in due la produzione letteraria dell’autore dei Frammenti lirici al quale deve molto e resta per sempre legato, anche promuovendo sulla figura del poeta vociano la prima edizione di un premio di saggistica alla Sacra di San Michele. Lo ribadisce quando torna tra i chiostri milanesi di largo Gemelli per la festa degli ottant’anni in università il 12 settembre 2003 con un libro-sorpresa di inediti di ottanta poeti amici, molti dei quali presenti a leggere suoi testi: ci sono Alda Merini, Giovanni Raboni, Patrizia Valduga e Cesare Viviani tra gli altri, presentati criticamente da Giuseppe Langella e Giovanni Tesio. In quell’occasione rilegge versi in cui confessa di scoprire che «il binario da prendere era un altro»,trovando poche ma esatte parole capaci di farci sentire partecipi del suo sentimento del tempo: «oggi sono tornato / sono tornato lontano troppo lontano».
Quando in una delle ultime visite gli acciacchi di udito e dei postumi di un’anestesia rallentano le sue reazioni verso il mondo, scherza sul fatto che la nebbia è entrata in casa, nelle orecchie, nella testa, quella fitta nebbia autunnale d’un tempo, ed è ora di preparare il viaggio verso «eterni invisibilia»: «si passano le stagioni / a scavare il tronco di un albero / per preparare la piroga / su cui c’imbarcheremo in autunno» è tra le ultime poesie.Eppure ci lascia in agosto. Senza aspettare l’autunno nebbioso, ma neppure il suo ottantantottesimo compleanno di fine estate, arriva il tempo annunciato delle sue «irruzioni d’azzurro nelle tenebre».
Roberto Cicala
(«Irruzioni d’azzurro» nella nebbia padana: ricordi di erba «tranviere metafisico», in “Autografo”, 50 (2016), pp. 87-90)
Luciano Erba con l’editore Roberto Cicala in Università Cattolica a Milano per gli 80 anni del poeta con letture da “80 poeti contemporanei” (2002).
Opere di Luciano erba nel catalogo Interlinea
Luciano Erba durante una lettura di Clemente Rebora:




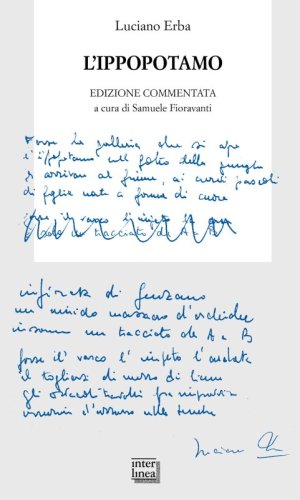


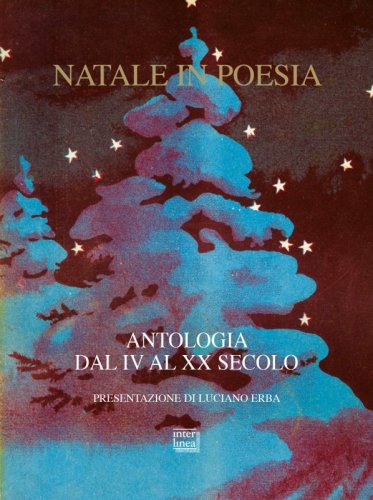


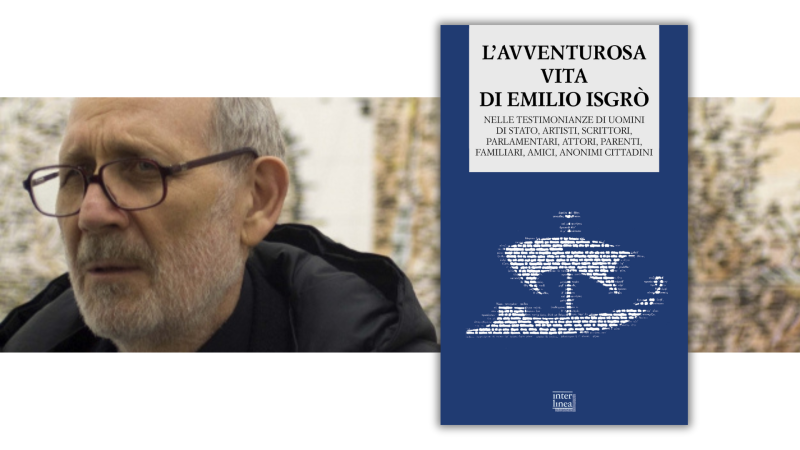

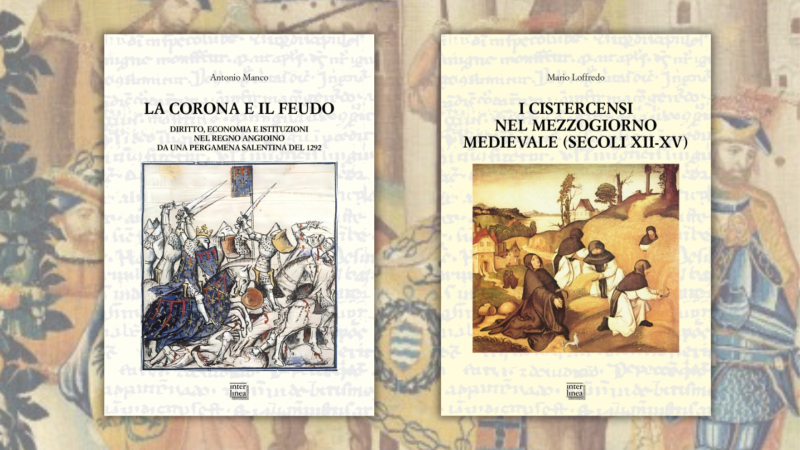
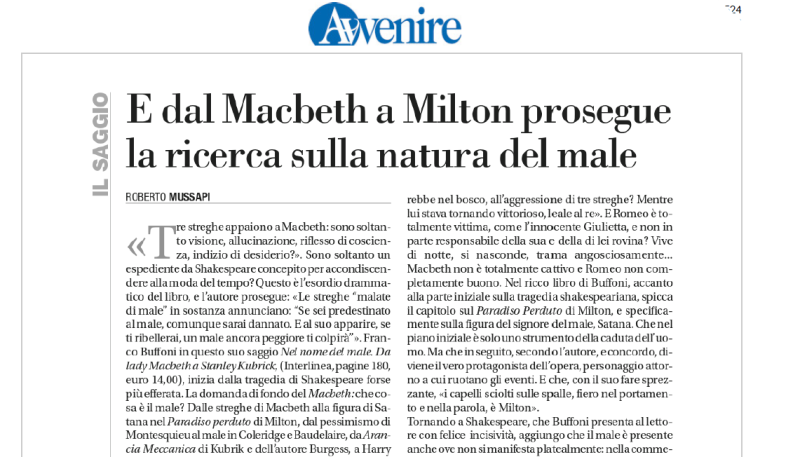


Inserisci un commento