Giannino Piana recensisce L’eccesso del desiderio. Tra vendetta e misericordia di Antonella Doninelli, un saggio sulla complessa dinamica del desiderio tra eccesso e umiltà.
Il desiderio è un fattore costitutivo dell’umano, una componente essenziale da cui non è possibile prescindere. L’uomo è un “animale desiderante” o – secondo la definizione di Lacan – è un “soggetto del desiderio” in incessante tensione. La dinamica del desiderio è complessa e non univoca: esso è infatti contrassegnato da una connaturale ambivalenza. Da un lato, è all’origine dell’apertura all’altro che viene dalla consapevolezza del proprio limite, apertura che sospinge l’uomo fino alla ricerca dell’infinito; dall’altro, riveste i tratti di una energia travolgente che, se non viene debitamente controllata, diventa sorgente di destrutturazione e di alienazione.
Il volume di Antonella Doninelli, che intreccia i risultati di riflessioni filosofiche, psicologiche e teologiche, affronta questa non facile tematica, partendo dal risvolto negativo, quello dell’”eccesso” – come recita il titolo dell’opera – per approdare tuttavia al perseguimento di orientamenti positivi di alto significato umano e spirituale. L’antropologia, che costituisce lo scenario sul quale si sviluppa la ricerca fa riferimento a una visione integrale dell’umano. Un’antropologia per la quale l’uomo non è riducibile alla sua dimensione razionale, per quanto importante; è la risultante di una serie di fattori costitutivi: dagli istinti ai sentimenti, dalle emozioni fino all’inconscio. Il testo si compone di tre capitoli: il primo e il secondo mettono a fuoco il lato oscuro del desiderio; il terzo evidenzia la possibilità del suo riscatto attraverso il ricorso alle virtù dell’umiltà e della misericordia.
Nel primo capitolo dal titolo L’eccesso come hybris l’autrice risale alle origini della cultura occidentale, in particolare al pensiero greco, per cogliere le radici della sua valenza negativa, che lo identifica con una forma di narcisismo autoreferenziale. L’eccesso attinge la propria linfa vitale dalla hybris, che Platone nel Sofista identifica con una “malattia dell’anima”. Essa è infatti un’energia dirompente che conduce al superamento delle regole sia nello sviluppo delle relazioni con gli altri che con la divinità o – come osserva Aristotele nell’Etica Nicomachea – di “una certa specie di ingiustizia”, che ha effetti negativi anche sulla vita della polis. Una violazione dunque della misura, provocata – come è testimoniato dalla due figure mitologiche di Prometeo e di Icaro – dal mancato rispetto dei propri limiti e dei limiti imposti dalla legge, fino ad assecondare la tendenza a farsi prossimo agli dei, suscitando la loro gelosia e scatenando la loro vendetta (nemesis).
Le dinamiche del desiderio, che sono alla radice della hybris e che costituiscono l’oggetto del secondo capitolo (La hybris come lato oscuro del desiderio), conducono Antonella Doninelli a confrontarsi con miti e fiabe, simboli che rinviano al mondo psichico e nei quali, secondo Freud, è possibile rintracciare contenuti rimossi che hanno la loro sede nell’inconscio. Analoghe riflessioni si riscontrano in Jung e Lacan, pur con approcci diversi derivanti dalla diversità delle loro teorie psicologiche. Mentre infatti Jung, partendo dalla considerazione dell’esistenza di un “inconscio collettivo” riconduce ad esso le costanti antropologiche dei miti fondatori, Lacan riconosce una medesima struttura all’inconscio individuale. In ambedue i casi ad emergere è la dimensione strutturale del desiderio e la sua distinzione dal bisogno: quest’ultimo infatti è oggettivabile e circoscritto, il desiderio, è invece permanentemente aperto, caratterizzato dalla tendenza dell’uomo a trascendersi in forza di un dinamismo interiore.
Ulteriori approfondimenti di questa visione vengono forniti da Silvano Petrosino e Massimo Recalcati. Il primo – Petrosino – sottolineando che il desiderio è “precondizione” del rapportarsi del soggetto con ciò che lo circonda (relazioni interumane e con le cose) mette in evidenza come l’esperienza della mancanza che non può essere colmata spinge a convertire la logica del desiderio in quella del bisogno, dando così luogo all’eccesso. Il secondo – Recalcati – rifacendosi al pensiero di Lacan che considera il limite umano come “mancanza di essere” pone l’accento sul fatto che il desiderio, che è desiderio dell’Altro, lasciato a sé stesso, è destinato a diventare preda della hybris, trasformandosi in godimento passionale con il conseguente affermarsi di spinte distruttive.
Infine il terzo capitolo (Eccesso e misericordia, il riscatto del desiderio), offre alcune importanti piste finalizzate a restituire al desiderio il suo vero significato umano, la sua capacità di sviluppare le vere potenzialità della persona. Indicazioni preziose in questo senso sono già presenti nei primi due capitoli. Il mondo greco non manca di sottolineare la necessità di trovare un rimedio all’eccesso mediante lo sforzo razionale di far prevalere misura e ordine attraverso il ricorso alla saggezza (phronesis) e alla prudenza. Per la psicanalisi, a sua volta, l’antidoto alla hybris è la Legge, che, lungi dall’essere concepita in antitesi al desiderio o come una spinta repressiva di fronte alla trasgressione, deve essere pensata – come afferma Lacan – “nel segno di porre il desiderio stesso come Legge”.
A queste significative prospettive valutative si connettono le riflessioni spirituali (teologiche) che vengono sviluppate in quest’ultima parte del volume. Il modello è costituito dalla risposta di Cristo alla gestione del proprio desiderio, quella che Recalcati definisce “conversione dal fantasma sacrificale” consistente nel rifiuto del binomio colpa-vendetta (nemesis). Gesù – è Recalcati ad affermarlo con forza – rompe il circolo vizioso del sacrificio, che ha da sempre connotato la relazione con il divino nel segno della logica dello scambio: il suo sacrificio segna la fine dei sacrifici. L’assunzione da parte di Dio dei limiti propri della condizione umana nell’incarnazione e il suo radicale svuotamento nella kenosis (cfr. Fil 2, 6-11), in cui si manifesta il mistero dell’amore di Dio, segna il percorso contrario a quello della hybris. Il limite del desiderio che non può essere oltrepassato diventa occasione per creare spazi generativi che rendono possibile una autentica relazione all’Altro.
Seguendo Gesù come modello, l’autosufficienza, l’orgoglio e la caparbietà che nascono dalla presunzione dell’onnipotenza lasciano il posto all’umiltà. La vendetta è allora vinta dall’amore kenotico, che scaturisce dall’esperienza di essere oggetto dell’amore divino: essere amati ci costituisce debitori di amore. Un amore che trova la sua più significativa incarnazione nella compassione e nella misericordia, le quali rendono trasparente la qualifica più alta dell’umano, il suo essere imago Dei che ha nell’umanità del Figlio di Dio la sua massima espressione. Il paradigma divino personificato da Gesù ci fa così uscire dal duplice rischio: sacrificare l’Altro al proprio desiderio o, inversamente, sacrificare il proprio desiderio sottomettendolo alla dipendenza del potere altrui. Aderendo a questa visione è infatti possibile dare la giusta misura al desiderio, mettendosi nella condizione di incontrare l’Altro in profondità e di crescere insieme.
Il libro di Antonella Doninelli è un chiaro esempio della complessità della questione del desiderio, della sua imprescindibilità ma nel contempo anche della sua ambiguità. Ma è soprattutto un esempio prezioso di come affrontarlo per fare di esso una forma fondamentale di arricchimento dell’umano sia nella sua dimensione personale che sociale. Il percorso interdisciplinare e il rigore metodologico offrono con questo saggio un importante contributo a chi intende accostarsi ad un tema di grande interesse e di viva attualità.
Il desiderio è un fattore costitutivo dell’umano, una componente essenziale da cui non è possibile prescindere. L’uomo è un “animale desiderante” o – secondo la definizione di Lacan – è un “soggetto del desiderio” in incessante tensione. La dinamica del desiderio è complessa e non univoca: esso è infatti contrassegnato da una connaturale ambivalenza. Da un lato, è all’origine dell’apertura all’altro che viene dalla consapevolezza del proprio limite, apertura che sospinge l’uomo fino alla ricerca dell’infinito; dall’altro, riveste i tratti di una energia travolgente che, se non viene debitamente controllata, diventa sorgente di destrutturazione e di alienazione.
Il volume di Antonella Doninelli, che intreccia i risultati di riflessioni filosofiche, psicologiche e teologiche, affronta questa non facile tematica, partendo dal risvolto negativo, quello dell’”eccesso” – come recita il titolo dell’opera – per approdare tuttavia al perseguimento di orientamenti positivi di alto significato umano e spirituale. L’antropologia, che costituisce lo scenario sul quale si sviluppa la ricerca fa riferimento a una visione integrale dell’umano. Un’antropologia per la quale l’uomo non è riducibile alla sua dimensione razionale, per quanto importante; è la risultante di una serie di fattori costitutivi: dagli istinti ai sentimenti, dalle emozioni fino all’inconscio. Il testo si compone di tre capitoli: il primo e il secondo mettono a fuoco il lato oscuro del desiderio; il terzo evidenzia la possibilità del suo riscatto attraverso il ricorso alle virtù dell’umiltà e della misericordia.
Nel primo capitolo dal titolo L’eccesso come hybris l’autrice risale alle origini della cultura occidentale, in particolare al pensiero greco, per cogliere le radici della sua valenza negativa, che lo identifica con una forma di narcisismo autoreferenziale. L’eccesso attinge la propria linfa vitale dalla hybris, che Platone nel Sofista identifica con una “malattia dell’anima”. Essa è infatti un’energia dirompente che conduce al superamento delle regole sia nello sviluppo delle relazioni con gli altri che con la divinità o – come osserva Aristotele nell’Etica Nicomachea – di “una certa specie di ingiustizia”, che ha effetti negativi anche sulla vita della polis. Una violazione dunque della misura, provocata – come è testimoniato dalla due figure mitologiche di Prometeo e di Icaro – dal mancato rispetto dei propri limiti e dei limiti imposti dalla legge, fino ad assecondare la tendenza a farsi prossimo agli dei, suscitando la loro gelosia e scatenando la loro vendetta (nemesis).
Le dinamiche del desiderio, che sono alla radice della hybris e che costituiscono l’oggetto del secondo capitolo (La hybris come lato oscuro del desiderio), conducono Antonella Doninelli a confrontarsi con miti e fiabe, simboli che rinviano al mondo psichico e nei quali, secondo Freud, è possibile rintracciare contenuti rimossi che hanno la loro sede nell’inconscio. Analoghe riflessioni si riscontrano in Jung e Lacan, pur con approcci diversi derivanti dalla diversità delle loro teorie psicologiche. Mentre infatti Jung, partendo dalla considerazione dell’esistenza di un “inconscio collettivo” riconduce ad esso le costanti antropologiche dei miti fondatori, Lacan riconosce una medesima struttura all’inconscio individuale. In ambedue i casi ad emergere è la dimensione strutturale del desiderio e la sua distinzione dal bisogno: quest’ultimo infatti è oggettivabile e circoscritto, il desiderio, è invece permanentemente aperto, caratterizzato dalla tendenza dell’uomo a trascendersi in forza di un dinamismo interiore.
Ulteriori approfondimenti di questa visione vengono forniti da Silvano Petrosino e Massimo Recalcati. Il primo – Petrosino – sottolineando che il desiderio è “precondizione” del rapportarsi del soggetto con ciò che lo circonda (relazioni interumane e con le cose) mette in evidenza come l’esperienza della mancanza che non può essere colmata spinge a convertire la logica del desiderio in quella del bisogno, dando così luogo all’eccesso. Il secondo – Recalcati – rifacendosi al pensiero di Lacan che considera il limite umano come “mancanza di essere” pone l’accento sul fatto che il desiderio, che è desiderio dell’Altro, lasciato a sé stesso, è destinato a diventare preda della hybris, trasformandosi in godimento passionale con il conseguente affermarsi di spinte distruttive.
Infine il terzo capitolo (Eccesso e misericordia, il riscatto del desiderio), offre alcune importanti piste finalizzate a restituire al desiderio il suo vero significato umano, la sua capacità di sviluppare le vere potenzialità della persona. Indicazioni preziose in questo senso sono già presenti nei primi due capitoli. Il mondo greco non manca di sottolineare la necessità di trovare un rimedio all’eccesso mediante lo sforzo razionale di far prevalere misura e ordine attraverso il ricorso alla saggezza (phronesis) e alla prudenza. Per la psicanalisi, a sua volta, l’antidoto alla hybris è la Legge, che, lungi dall’essere concepita in antitesi al desiderio o come una spinta repressiva di fronte alla trasgressione, deve essere pensata – come afferma Lacan – “nel segno di porre il desiderio stesso come Legge”.
A queste significative prospettive valutative si connettono le riflessioni spirituali (teologiche) che vengono sviluppate in quest’ultima parte del volume. Il modello è costituito dalla risposta di Cristo alla gestione del proprio desiderio, quella che Recalcati definisce “conversione dal fantasma sacrificale” consistente nel rifiuto del binomio colpa-vendetta (nemesis). Gesù – è Recalcati ad affermarlo con forza – rompe il circolo vizioso del sacrificio, che ha da sempre connotato la relazione con il divino nel segno della logica dello scambio: il suo sacrificio segna la fine dei sacrifici. L’assunzione da parte di Dio dei limiti propri della condizione umana nell’incarnazione e il suo radicale svuotamento nella kenosis (cfr. Fil 2, 6-11), in cui si manifesta il mistero dell’amore di Dio, segna il percorso contrario a quello della hybris. Il limite del desiderio che non può essere oltrepassato diventa occasione per creare spazi generativi che rendono possibile una autentica relazione all’Altro.
Seguendo Gesù come modello, l’autosufficienza, l’orgoglio e la caparbietà che nascono dalla presunzione dell’onnipotenza lasciano il posto all’umiltà. La vendetta è allora vinta dall’amore kenotico, che scaturisce dall’esperienza di essere oggetto dell’amore divino: essere amati ci costituisce debitori di amore. Un amore che trova la sua più significativa incarnazione nella compassione e nella misericordia, le quali rendono trasparente la qualifica più alta dell’umano, il suo essere imago Dei che ha nell’umanità del Figlio di Dio la sua massima espressione. Il paradigma divino personificato da Gesù ci fa così uscire dal duplice rischio: sacrificare l’Altro al proprio desiderio o, inversamente, sacrificare il proprio desiderio sottomettendolo alla dipendenza del potere altrui. Aderendo a questa visione è infatti possibile dare la giusta misura al desiderio, mettendosi nella condizione di incontrare l’Altro in profondità e di crescere insieme.
Il libro di Antonella Doninelli è un chiaro esempio della complessità della questione del desiderio, della sua imprescindibilità ma nel contempo anche della sua ambiguità. Ma è soprattutto un esempio prezioso di come affrontarlo per fare di esso una forma fondamentale di arricchimento dell’umano sia nella sua dimensione personale che sociale. Il percorso interdisciplinare e il rigore metodologico offrono con questo saggio un importante contributo a chi intende accostarsi ad un tema di grande interesse e di viva attualità.
Giannino Piana




 Già docente di Etica cristiana all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino e di Etica ed economia alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino, collaboratore di diverse riviste, ha presieduto l’Atism (Associazione Teologica Italiana per lo studio della Morale) e diretto il Corso di Morale in 6 voll. (2 ed., 1989-1995), il Nuovo Dizionario di teologia Morale (1990), le collane “Cronache Teologiche” (Marietti) e “Morale” (SEI). Dirige attualmente “Questioni di etica teologica” e “L’etica e i giorni” (Cittadella Ed.).
Già docente di Etica cristiana all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino e di Etica ed economia alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino, collaboratore di diverse riviste, ha presieduto l’Atism (Associazione Teologica Italiana per lo studio della Morale) e diretto il Corso di Morale in 6 voll. (2 ed., 1989-1995), il Nuovo Dizionario di teologia Morale (1990), le collane “Cronache Teologiche” (Marietti) e “Morale” (SEI). Dirige attualmente “Questioni di etica teologica” e “L’etica e i giorni” (Cittadella Ed.). 


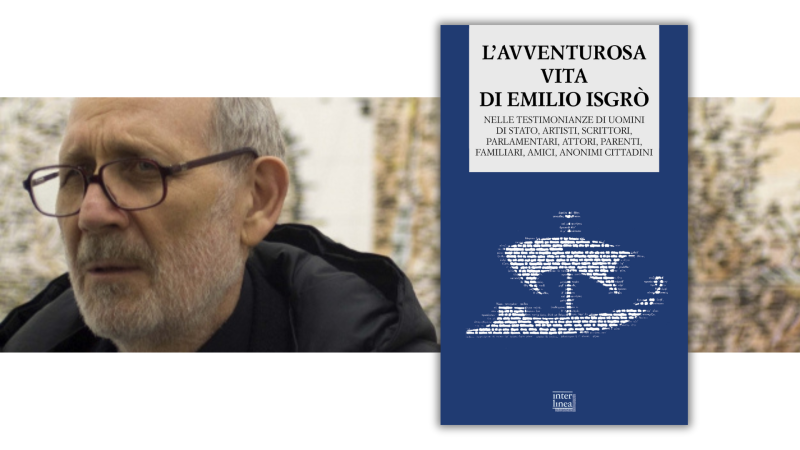

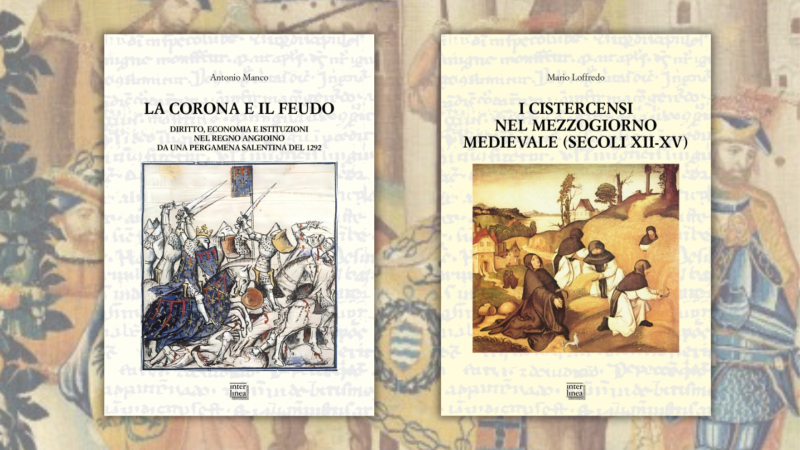
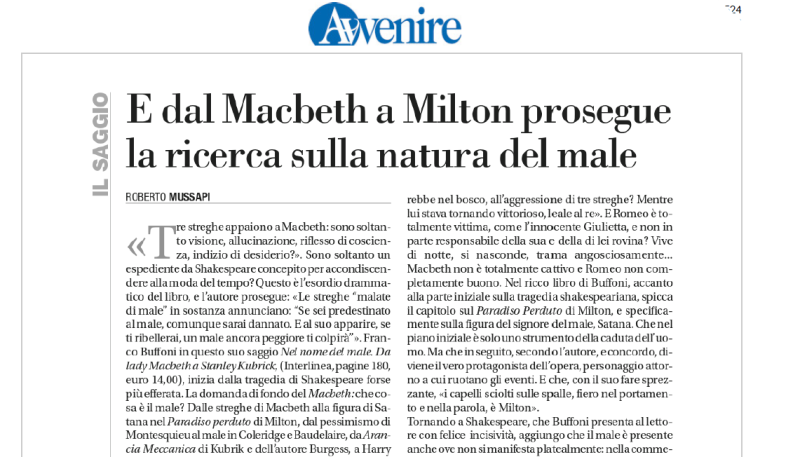


Inserisci un commento