Qui il video della premiazione di Piumini.
Felici per questa bella notizia, pubblichiamo qui un intervento di Piumini che racconta proprio come nacque questo testo, illustrato da Antonio Ferrara:
Nota dell’autore (ovvero: come è nato questo testo)
Come può mettersi in rapporto lo scrittore con il lettore, o con la comunità dei lettori, del pubblico, oltre che nel modo misterioso e intimo della scrittura-lettura? Ammesso che esista l’opportunità, la tradizione, o la moda, che uno scrittore incontri il pubblico, in che maniera può farlo, e in che modo sarebbe meglio lo facesse?
Il modo più sperimentato è il tipico incontro in libreria, in cui l’autore, di solito patrocinato da terzi, svolge considerazioni autobiografiche, o letterarie, e risponde alle domande. Tipo di incontro che ha una ritualità, e una drammaturgia, talvolta comica, sulla quale non mi dilungo. Dal punto di vista del rapporto, in questi incontri non si aggiunge nulla rispetto all’esperienza di lettura: spesso il conto va anzi a favore di una comunicazione estrinseca sia da parte dell’autore che del pubblico, quando addirittura non si risolvano in esercizi di curiosità mondana o giornalistica, esibizione e sfogo (sia dell’autore che del pubblico).
Il rischio di questi incontri è evidente, e spesso non evitato: da un lato il discorso si svolge o atteggia su un piano di critica o interpretazione, dall’altro spinge l’autore a un ruolo di analista di se stesso, di auto-meta-poeta, che certo non gli compete e non gli conviene. Questi incontri, se fanno parte di un “gioco” ammesso o promosso, non sembrano avere insomma, oltre alla funzione promozionale e socializzante, nessun vantaggio particolare, né aggiungono qualcosa di significativo, come si diceva, all’esperienza del rapporto lettura-scrittura.
Meno rischioso e gratuito può essere il reading, in cui l’autore è chiamato semplicemente a una pratica di oralità: ad aggiungere al dono già depositato nel testo il gesto presente, e in qualche modo attualizzante, della lettura vocale. Questo in teoria: spesso, soprattutto in una tradizione letterario-comunicativa come la nostra, con autori lontani da ogni abitudine e capacità “orale”, i readings sono esperienze di appiattimento, o addirittura di mortificazione della parola. Anche questi incontri sono in ogni caso subalterni al “prima” del testo, sia che si rivolgano a un pubblico che già lo conosce (in tale caso costituiscono una specie di “rumore” rispetto alla percezione e ricreazione propria, in qualche modo già “orale” della lettura) sia che non lo conosce, e in tale caso è fin troppo dipendente dalla qualità comunicativa, “teatrale” della lettura. In questi incontri ciò che avviene di attuale è la performance più o meno efficace dell’autore-lettore, e la percezione che ne ha il pubblico. L’evento comunicativo resta ancora sbilanciato all’indietro, verso un “prima”, un già dato, un già avvenuto.
Un terzo tipo di incontro, assai raro nella nostra tradizione culturale, è di tipo radicalmente diverso. Qui lo scrittore si mette di fronte a persone (gruppo limitato, non platea) non come autore di un testo già dato, ma come autore di un testo da fare. Qui lo scrittore entra, insieme a un gruppo, in una “situazione” produttiva, mettendo a disposizione la sua “tecnica”, la sua capacità espressiva formale. Qui c’è uno scambio, che può essere realizzato in moltissimi modi. In uno dei possibili, un gruppo di persone (bambini, ragazzi, adulti) fornisce allo scrittore una serie di dati: vissuti, notizie, esperienze, percezioni, immagini pittoriche o fotografiche, mappe, oggetti significanti, reperti sonori, documenti, materiali narrativi eccetera. Lo scrittore accoglie questi elementi, guarda, seleziona, organizza e scrive poi un testo (narrativo, poetico, teatrale) in cui coniuga liberamente il suo immaginario ai dati ricevuti (che possono a loro volta, d’altronde, essere immaginari): un testo in cui, nel codice alto e complesso della scrittura di valore estetico, sono presenti e resi uniti elementi della sua e dell’altrui esperienza. Lo scrittore, con la sua parola “specialistica” fa da sintetizzatore e intensificatore espressivo del gruppo, da narratore-rappresentatore, testimone complesso di dati e vissuti comuni a un gruppo.
Questa “situazione” comunicativa e produttiva cambia radicalmente lo statuto degli incontri tradizionali fra autore e persone. Qui l’esperienza importante non è “avvenuta” ma avviene in una “durata comunicativa”, un gioco-scambio di grande intensità e progressività. Prima c’è la raccolta-scelta-organizzazione dei dati, in funzione di una “scrittura” futura, poi l’autore è lettore dei dati materiali ed espressivi che riceve, poi il gruppo si fa lettore di un testo in cui esplicitamente o implicitamente (nell’implicitezza arricchente della scrittura espressiva) sono compresi suoi vissuti. Il tessuto testuale non solo incrocia i fili dell’immaginario personale e del codice linguistico dell’autore, ma anche quelli degli immaginari e dei codici delle persone che hanno raccolto-espresso i materiali. Non si tratta della scrittura di un testo collettivo: restano separate la funzione della “memoria” da quella della “scrittura”, però nel modo corretto, e reciprocamente gratificante, in cui il testo letterario raccoglie e racconta, in un tempo di presenza e di testimonianza, le immagini e la tensione espressiva del gruppo.
Come accade alle buone esperienze, questa “collaborazione”, questo scambio non solo aggiunge un modo meno regressivo al repertorio degli incontri tra autori e pubblico: in questi incontri d’opera il pubblico lascia il posto alle persone, senza trasformarle magicamente, ed equivocamente, in “artisti”. In una prospettiva non solo di “sociologia della letteratura”, ma di “sociologia della cultura”, esperienze come questa possono contribuire a ridurre la distanza tra pubblico ed espressione (letteraria, artistica), a produrre esperienze e integrazioni fra linguaggi sociali e linguaggi esteticamente intenzionati, fra vissuto individuale-sociale ed espressività d’arte.
Per realizzarle occorrono autori disponibili a “giocarsi” all’interno di situazioni segniche ed esistenziali altrui, a prendere, come si sarebbe detto una volta, l’“ispirazione” non solo dalla sua privata zona immaginaria ed emotiva, ma anche da quella di gruppi e ambienti diversi. Occorrono, poi, realtà sociali che vedano in questo “gioco” un’occasione di espressività e qualificazione, di testimonianza e di comunicazione, un arricchimento e una maturazione, un gesto di nuova e autentica “tradizione”. Occorrono poi, se il gruppo è di bambini e ragazzi, o forse in ogni caso, operatori-mediatori che pensino, progettino, sappiano far vivere, mediare e organizzare le fasi di scambio, promuovere la lettura, il godimento e il farsi proprio del testo che ne nasce.
Roberto Piumini

Caterina, Caterina,Caterina di Massiola,
ahi, la tua capra sola!
La bella capra salata
dalle corna gentili,
dalla barbetta trepida,
la capra brava, la crava
che quieta brucava
e fresca belava,la fervida e umida
coraggiosa e timida
la capra frugalee balzana
che calma frugava
sul quieto crinale!
Caterina di Massiola
pastora spaventatama la tua capra sola
che erba e sale cercava?
La capra, dov’è andata?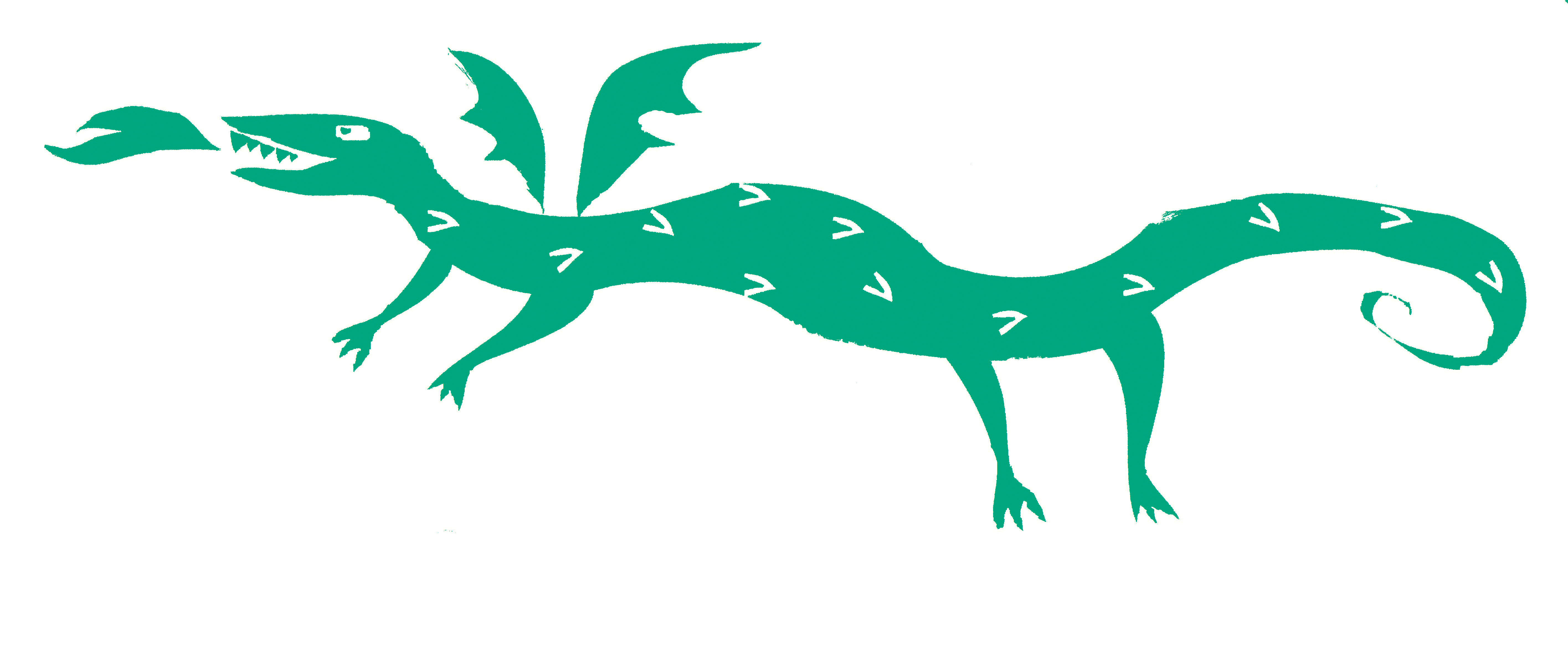 Chi l’ha vista? Dov’è sparita
Chi l’ha vista? Dov’è sparita
con le zampe pungenti
nella terra smagrita
giù per i prati o su per la salita?
Dove lo porta, il latte?Dove batte gli zoccoli duri
lei che non sa i confini?


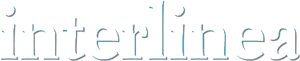










Inserisci un commento