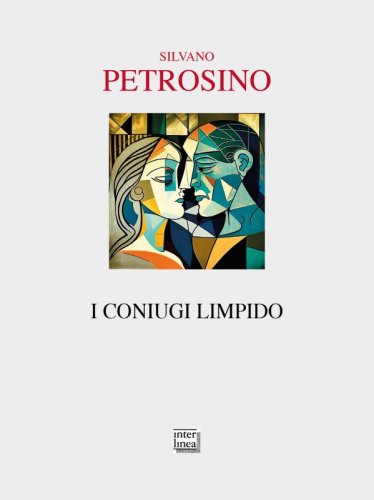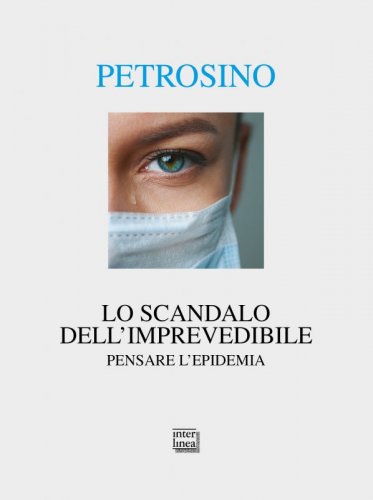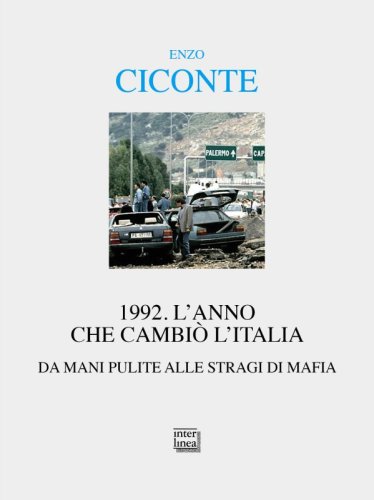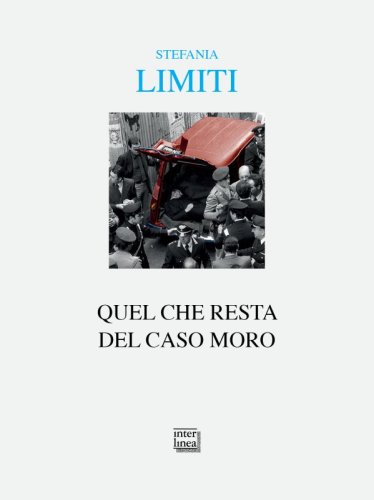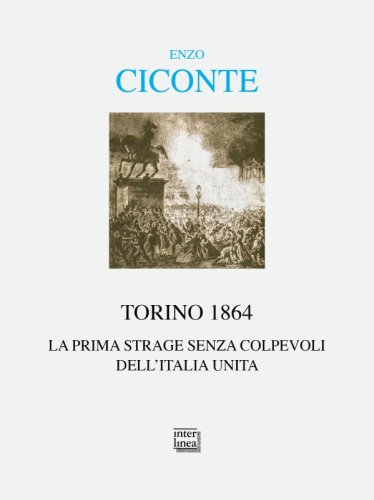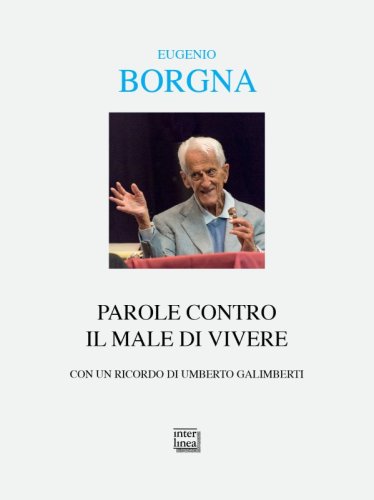Biografia dell'autore
Silvano Petrosino

Internazionalmente noto per i suoi studi sul pensiero di E. Lévinas e J. Derrida, è uno dei più apprezzati filosofi italiani. Insegna Teorie della Comunicazione e Antropologia religiosa e media presso l’Università Cattolica di Milano. Tra le sue opere ricordiamo: Lo stupore (Novara 1997, Madrid 2001); Jacques Derrida e la legge del possibile. Un’introduzione (2a ed., Milano 1997, Paris 1994); Il sacrificio sospeso (Milano 2000, Paris 2008); Il dono (in collaborazione con P. Gilbert, Genova 2002, Bruxelles 2007, Belo Horizonte 2008); Babele. Architettura, filosofia e linguaggio di un delirio (Genova 2003, Paris 2010); Piccola metafisica della luce (Milano 2004); La scena umana. Grazie a Derrida e Lévinas (Milano 2010); L’eros della distruzione. Seminario sul male (in collaborazione con S. Ubbiali, Genova 2010); Visione e Desiderio. Sull’essenza dell’invidia (2a ed., Milano 2010); Capovolgimenti. La casa non è una tana, l’economia non è il business (2a ed., Milano 2011); Abitare l’arte. Heidegger, la Bibbia, Rothko (Novara 2011). Tra le opere più recenti: Contro il post-umano. Ripensare l’uomo, ripensare l’animale (con M. Iofrida, Bologna 2017); Emmanuel Lévinas. Le due sapienze (Milano 2017); La verità nomade. Introduzione a Emmanuel Lévinas (Milano 1980; 2a ed. 2018); La donna nel giardino. Che cosa Eva avrebbe potuto rispondere al serpente (Bologna 2019); Il desiderio. Non siamo figli delle stelle (Milano 2019); Il miraggio dei social. Euforia digitale e comunicazione responsabile (Novara 2019), Dove abita l’infinito. Trascendenza, potere e giustizia (Milano 2020), Morte e immortalità tra rimozione ed esibizione (Milano 2023).