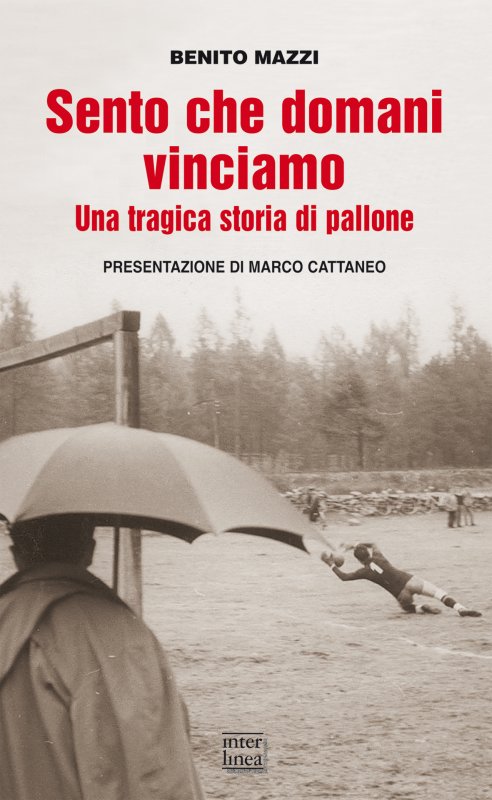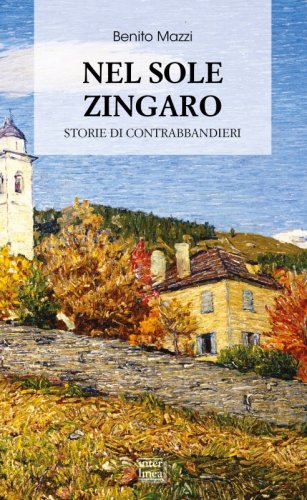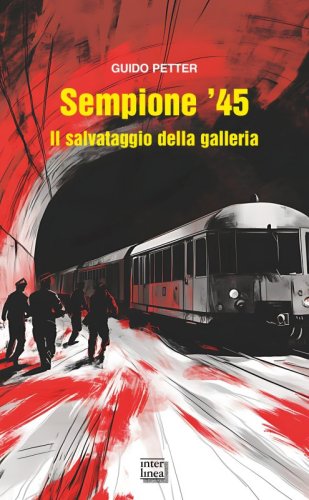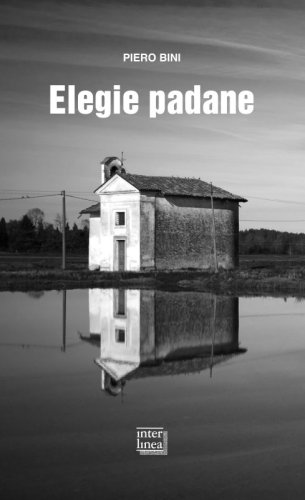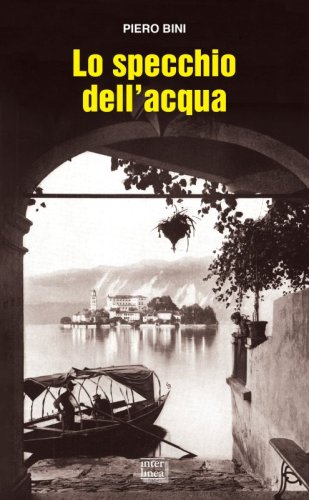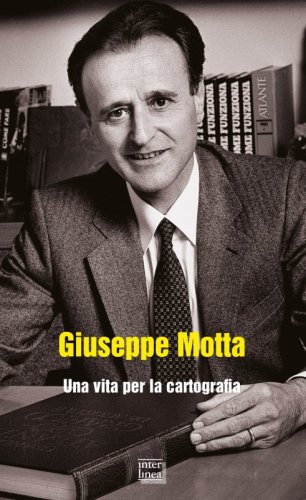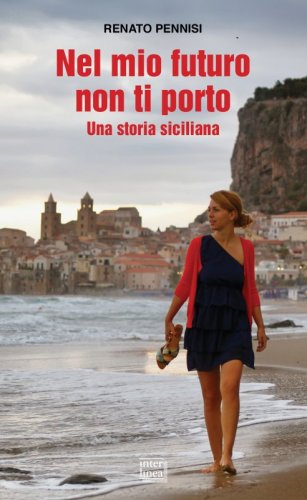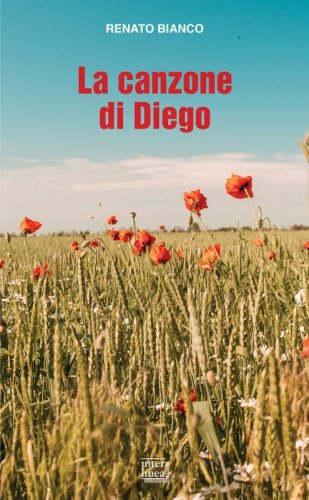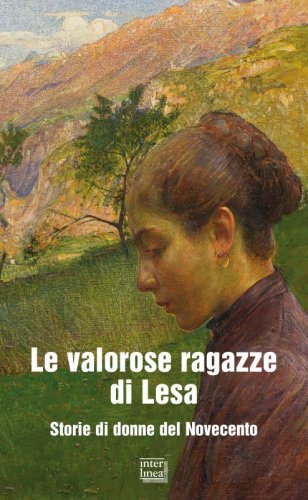Biografia dell'autore
Benito Mazzi

Benito Mazzi, giornalista, scrittore e studioso di tradizioni alpine, negli ultimi anni anche libraio a Santa Maria Maggiore, da sempre vive nell’ossolana valle Vigezzo, dove ha ambientato quasi tutti i suoi libri, pubblicati con molte case editrici (tra cui Rizzoli per Almeno questanno fammi promosso e Priuli & Verlucca per Fam, füm, frecc. Il grande libro degli spazzacamini e altri) e spesso tradotti all’estero. Tra i volumi di narrativa editi da Interlinea ricordiamo Nel Sole zingaro. Storie di contrabbandieri (prima edizione 1997, Selezione Premio Strega), Quando abbaiava la volpe, Un uomo che conta (Selezione Premio Bancarella Sport), L’aquila di Tappia al Giro d’Italia (con Marco Della Vedova), Gli invincibili della neve e, per i bambini, la storia di Natale Il sogno di Gibo. Più di recente, La ragazza che aveva paura del temporale, con presentazione di Giuliana Sgrena, Sento che domani vinciamo. Una tragica storia di pallone (presentazione di Marco Cattaneo) e Il falsario sognatore. Un bohémien di provincia. È mancato nell’aprile 2022 all’età di 83 anni.
Un brano del libro
Il cappello alpino calato sugli occhi, i baffetti elettrici, l’immancabile stuzzicadenti incollato alle labbra, la fedele verga di nocciolo in una mano e la palla sequestrata nell’altra, l’Alfredo s’avviò caracollando alla casa comunale. La partitella serale dei “vandali” era finita prima ancora di incominciare.
Fu lo stesso camparo, che era un falso burbero, a riconsegnare la sera dopo la palla ai ragazzi, riuniti sui gradini del tabaccaio: «Eccolo qua, il vostro stramaledetto ordigno» disse serio. «Tenetevelo. Ma è l’ultima volta. Non voglio più vedervi dare calci a quest’aggeggio infernale in mezzo alla piazza. Intesi?»
«Ma signor Alfredo, suggerisca lei a quelli del Comune di assegnarci un pezzo di prato su cui giocare» disse Vitto, il più grande della compagnia.
«Un prato per giocare? Ma dove siamo…» ribatté la guardia campestre. «Il Comune ha altro a cui pensare che queste scemenze da città. Andate a lavorare, altro che giocare».
«Non ci basta sgobbare tutto il giorno…» mugugnò Vitto mentre l’altro s’allontanava. Pino, un muratore sui vent’anni che aveva assistito alla scena, s’intromise rincarando la dose: «Capirai… il Comune dovrebbe sottrarre al pascolo un pezzo di terreno per darlo a quattro mammalucchi che corrono dietro a una palla».
«Hai mai sentito parlare del gioco del calcio?» intervenne Beni che teneva al Torino e ogni domenica, insieme a Vitto, seguiva alla radio della scuola, dove insegnava sua madre, il secondo tempo di una partita del campionato di serie A.
«E te, lifròk, non hai mai sentito parlare di calci nel culo?» rispose il muratore cercando di allungargli una pedata.
Passò il Pipìn del Cienti, un contadino che per una zolla di terreno avrebbe barattato l’anima: «Non so dove finiremo di questo passo» ringhiò. «Il prato sotto la ferrovia me l’hanno ridotto a un campo di battaglia, ’sti balabiotti. E io alla vacca cosa ci do quest’inverno da mangiare, la vostra bala? Ripresentatevi e vi tzonco via la testa. Con la falce. O con questo». Ed estrasse dalla tasca un Marietti dalla lama lunga una spanna.
La terra, il campo, i prati erano il pane del paese. Il giorno che un sacerdote di passaggio organizzò una corsa a piedi per i ragazzi, mettendo in palio 100 lire, i tapini, per non calpestare la campagna, furono costretti a cimentarsi sulla strada della stazione, non asfaltata e ricoperta di ghiaia fresca. Naturalmente a piedi nudi, com’era d’uso a quei tempi, ché le calzature si indossavano solo a scuola, in chiesa e con la neve. Per la cronaca, le 100 lire i ragazzi se le divisero tra loro in parti uguali, indipendentemente dai piazzamenti ottenuti.
«Ai nostri tempi lo sport era un sacrilegio» dichiara a un giornalista Mario Bonzani, classe 1938, di Folsogno. «Per fare una nuotata dovevamo saltare di nascosto dalle rocce del Rialùn, dopo essere scappati di casa; guai se i nostri ci avessero sorpresi. Non parliamo poi dello sci. Ci arrangiavamo, sempre di nascosto come i ladri, con delle tappe sbozzate da noi e fissate agli zoccoli con fili di ferro».
Era questa, in buona sostanza, la considerazione in cui erano tenuti lo sport e lo svago giovanile a Re, il paese dei “vandali”, e in genere nell’intera valle Vigezzo nei primi anni del secondo dopoguerra. Il gioco del pallone, in particolare, non era che una novità da sfaticati, «importata dagli sfollati e dai villeggianti giusto per sfasciare scarpe e rovinare le coltivazioni».
Non esisteva ovviamente il turismo di massa, i “villeggianti” di Re e Folsogno erano perlopiù operai e contadini del Novarese e del Varesotto i quali, non potendo permettersi gli alberghi signorili dell’alta valle, si accontentavano di sistemazioni alla buona all’ospizio delle suore o presso famiglie che li ospitavano per un mese o due in modeste camerette in cambio di quattro soldi o, a volte, di un paio di lenzuola. Si trattava di adulti con problemi di salute e di bambini esangui, col colorito da rifare.
Tornando allo sport, una certa tolleranza era riservata unicamente al ciclismo fangoso del tempo, forse per rispetto alla fatica, che il montanaro conosceva bene. Anche se si contavano sulle dita di una mano gli uomini che seguivano alla radio della scuola le epiche imprese di Coppi e Bartali.