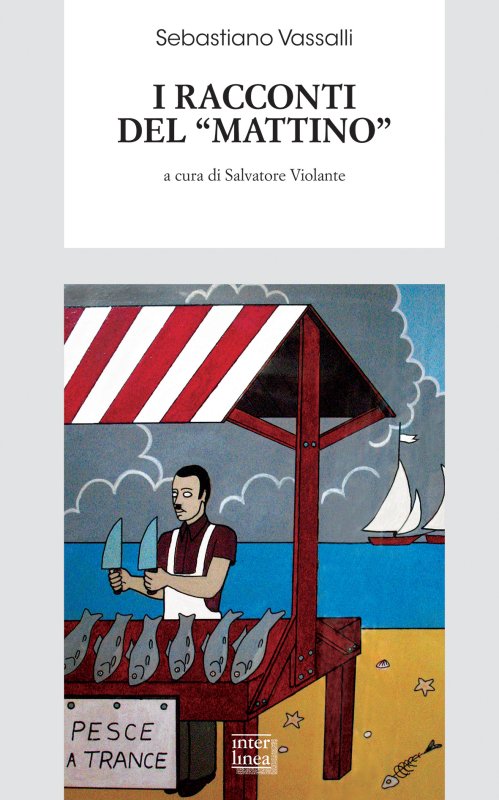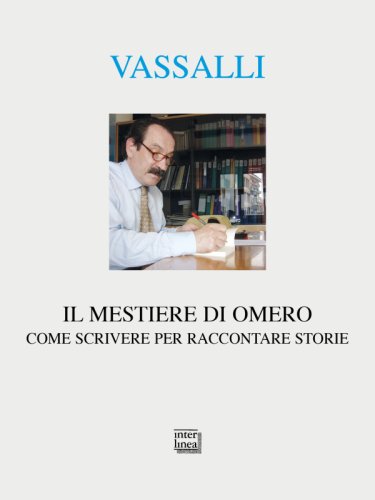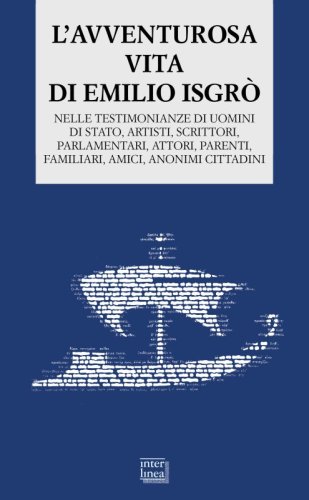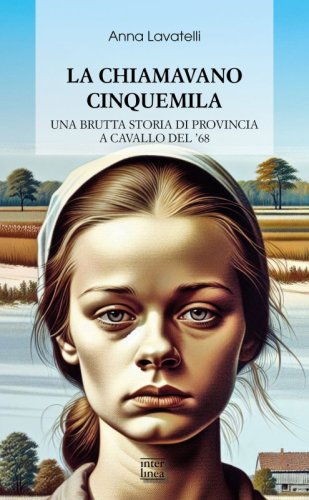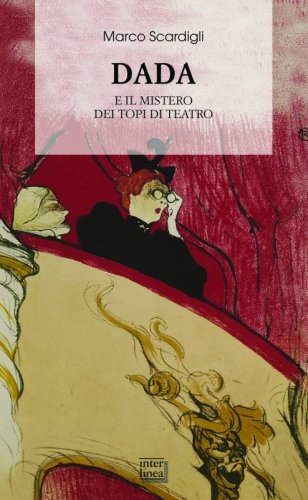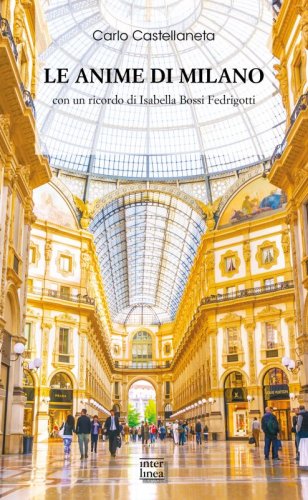Biografia dell'autore
Sebastiano Vassalli

Esordisce con testi poetici affermandosi con alcune prose sperimentali (Narcisso è del 1968, cui seguono Tempo di màssacro e L’arrivo della lozione, sempre da Einaudi, presso cui pubblica anche il poemetto Il millennio che muore); nella pagina travasa, attraverso un furore linguistico e una satira culturale, le inquietudini politiche e sociali di quegli anni. Rispetto a queste esperienze giovanili Abitare il vento del 1980 segna il primo tentativo di distacco e svolta. Il protagonista, come nel successivo Mareblù, si sente incapace di cambiare il mondo con metodi trasgressivi e rivoluzionari (chiedendosi alla fine: contro chi?).
Vassalli cerca quindi nuovi personaggi o, meglio, una letteratura pura. E in questo senso è per lui emblematico il poeta Dino Campana, la cui vicenda è ripercorsa nella Notte della cometa, la prima opera della stagione narrativa matura. La sua indagine approda a una dimensione esistenziale anch’essa pura, come la fanciullezza, al centro della ricerca delle origini della società odierna italiana nel romanzo L’oro del mondo, ambientato nel dopoguerra. Intanto Vassalli non smette di indagare il mondo con eclettismo intellettuale (si pensi a Sangue e suolo e Il neoitaliano).
L’investigazione letteraria delle radici e dei segni di un passato che illumini l’inquietudine del presente e ricostruisca il carattere nazionale degli italiani approda al Seicento con La chimera, un successo editoriale del 1990 (premio Strega), poi al Settecento di Marco e Mattio, uscito l’anno dopo, quindi all’Ottocento e agli inizi del Novecento con Il Cigno nel 1993.
Dopo la parentesi quasi fantascientifica, inquietante e satirica, di 3012 e il viaggio al tempo di Virgilio e Augusto di Un infinito numero, in Cuore di pietra ricrea un’epopea della storia democratica dell’unità d’Italia simbolizzata da un grande edificio di Novara, Casa Bossi dell’architetto Antonelli. Nei libri a cavallo del Duemila lo scrittore si avvicina al presente riscoprendo anche il genere del racconto, soprattutto con La morte di Marx e altri racconti del 2006 e L’italiano dell’anno successivo, prima del ritorno al romanzo fondato sulla storia: la prima guerra mondiale in Le due chiese, del 2010, e gli antichi romani in Terre selvagge, che segna nel 2014 il passaggio dall’editore di quasi cinquant’anni di libri, Einaudi, a Rizzoli, dove appare nello stesso anno una nuova edizione della Chimera.
Con Interlinea Vassalli pubblica Il mio Piemonte, la raccolta illustrata Terra d’acque e, tra gli altri titoli (oltre a Natale a Marradi e Il robot di Natale nella collana “Nativitas”), l’autobiografia Un nulla pieno di storie. Ricordi e considerazioni di un viaggiatore nel tempo (con Giovanni Tesio in forma di intervista con documenti e immagini) e Maestri e no. Dodici incontri tra vita e letteratura, e, postumo, I racconti del “Mattino”.
Tra gli studi sullo scrittore novarese si segnala il numero di “Microprovincia” 49 (2011) La parola e le storie in Sebastiano Vassalli, oltre a La chimera. Storia e fortuna del romanzo di Sebastiano Vassalli, a cura di Roberto Cicala e Giovanni Tesio (Interlinea, Novara 2003).
Alcune mostre hanno illuminato aspetti della sua produzione: La nascita di uno scrittore. Vassalli prima della Chimera: 1965-1989 (con catalogo a cura di Roberto Cicala e Linda Poncetta, presentazione di Giovanni Tesio, Educatt, Milano 2011), Il romanzo di una valle. Il caso editoriale di Marco e Mattio di Vassalli tra le Dolomiti di Zoldo e Venezia (con catalogo a cura di Roberto Cicala e Valentina Giusti, Educatt, Milano 2019), La strega e lo scrittore. A 30 anni dalla Chimera di Sebastiano Vassalli (a cura di Roberto Cicala, con mostra virtuale su “YouTube”, 2020:
Una curiosità: allo scrittore è dedicata la prima guida italiana di itinerari letterari cicloturistici: Nella pianura delle storie di Sebastiano Vassalli, in italiano e inglese (Interlinea-ATL, Novara 2013). Vassalli ha pubblicato anche interventi militanti su quotidiani: dopo la collaborazione a “la Repubblica” e “La Stampa”, è opinionista del “Corriere della Sera” (i suoi Improvvisi. 1998-2015 sono raccolti dalla Fondazione Corriere della Sera nel 2016). Muore improvvisamente nel luglio 2015 e nello stesso anno esce postumo da Rizzoli Io, Partenope, seguito da riedizioni e antologie.
Il catalogo di Interlinea continua a rendere viva la memoria dello scrittore e ha pubblicato postumi, nella collana “Alia”, Il mestiere di Omero. Come scrivere per raccontare storie, Affaire Tortora. Un caso italiano di ingiustizia e odio, oltre alla nuova edizione di Il millennio che muore. Un elogio del libro e della parola.
Per aggiornamenti si rinvia al sito www.letteratura.it/vassalli.
Un brano del libro
Invece il mio esame è stato una cosa stupidissima, col prof. Tupino di matematica che essendo balbuziente ha cominciato a dire fammi questa equa a-zione. Scri-ivi. Dunque lui balbettando a tutta forza m’ha dettato la sua equa azione ma io le eque azioni non le so fare, non mi interessano e alla fine gliel’ho anche detto cioè ho detto: «Rifiuto questo esame nozionistico». «A cosa servono le equazioni?» «Voglio dimostrare la mia maturità reale» mentre il Tupino insisteva: «Se-sei ma-maaturo fai l’equa a-zione». Alla fine è intervenuto il presidente cioè il preside della commissione esaminatrice per chiedermi: «Ma lei è proprio convinto di essere maturo?» Sì. Mi sono alzato in piedi. Ho risposto: «Signor preside della commissione». (L’ho chiamato signor preside della commissione per fargli capire che riconoscevo le gerarchie, rispetto le istituzioni eccetera. Che non sono un sovversivo, io). «La ringrazio per questa domanda che mi dà modo di chiarire la mia posizione nei confronti della matematica e degli esami» e intanto che parlavo pensavo, qual è la mia posizione nei confronti della matematica e degli esami? Ah, ecco; «Noi stiamo qui a fare le equazioni e ogni anno nel mondo milioni di persone muoiono di fame», bum. La vita è dura, ragazzi. E l’esperienza insegna che gli esami si possono anche sbarcare citando i morti di fame oppure i drogati, i disoccupati, i terremotati, i carcerati, i falliti. (Perché i prof. generalmente sono dei poveretti che se gli parli di cose grosse si spaventano). Dunque io per essere più sicuro li ho citati tutti e poi ho citato me stesso cioè il mio componimento di italiano dove già avevo sviscerato le problematiche dei disgraziati in genere e specificamente quelle degli handicappati perché l’anno scorso era l’anno mondiale dell’handicappato ma la prof. di italiano s’è messa a starnazzare che ero andato fuori tema, che dovevo parlare del Foscolo oppure di Manzoni, ah sì? Ho risposto «Tanto peggio per il tema» e il preside mi ha dato sulla voce: «Come si permette». «Stia zitto».
(Dal racconto "Maturità")