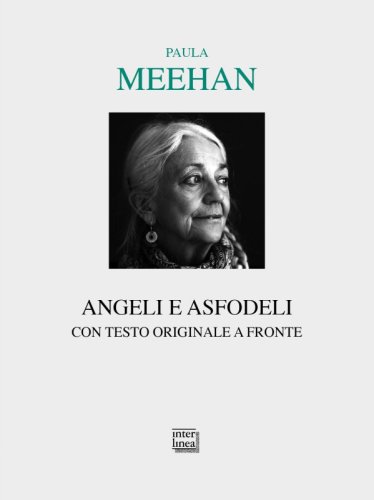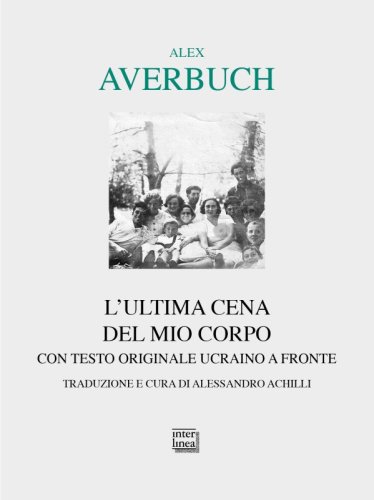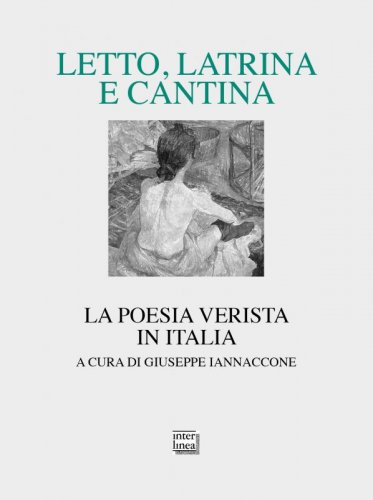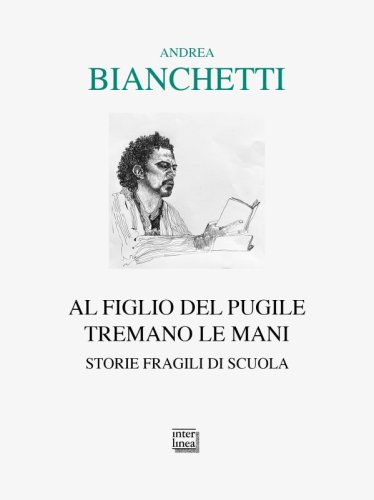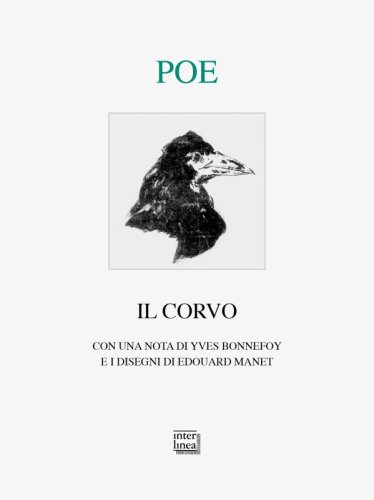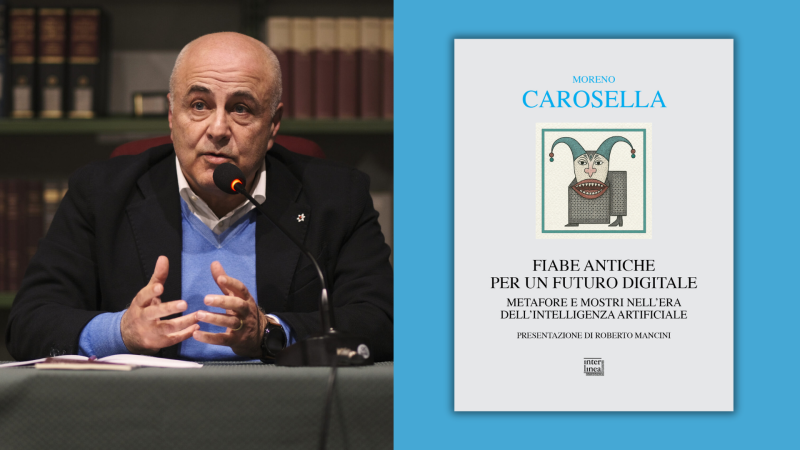Dei molti pregiudizi che la Germania s’è vista riversare addosso negli ultimi mesi, almeno uno le è stato risparmiato: non si può dire che sia stata noiosa. I suoi osservatori, spesso cittadini dell’Europa Unita costretti a riconoscersi come suoi riluttanti sudditi, sono passati in poco tempo dal vederla schiacciare la Grecia con un’esibizione di potere talmente ottusa da non renderla più credibile nel ruolo di custode delle regole comuni, al trovarsi la sorpresa del nuovo colpo di mano con cui apriva le porte ai profughi siriani. Se questo poteva essere ricondotto ai conflitti che interessano le alte sfere della politica, col dissidio incarnato dalla cancelliera sempre diplomatica e dal suo “falco” ministro delle finanze dottor Stranamore, il mistero più grande rimanevano i tedeschi. Come era possibile che quegli stessi cittadini che – come rileva Franco Buffoni – avrebbero votato all’80 per cento contro un’estensione del debito greco in un referendum analogo a quello indetto da Alexis Tsipras, pur sapendo del disastro sociale che si era creato in Grecia, sarebbero poi accorsi alle stazioni e negli stadi con cartelli e striscioni Refugees Welcome! ma anche coperte, letti da campeggio, viveri medicinali giocattoli e tutto quanto potesse dare concretezza al loro benvenuto? E questo mentre in Italia persino la stampa più moderata avallava la visione di un’indistinta “invasione di migranti”, per non parlare della presenza quasi ubiqua di Matteo Salvini nei talk-show televisivi? Come si spiegava quel voltafaccia che ad un tratto rendeva i tedeschi molto più simpatici, però in fondo non meno unheimlich, perturbanti nella loro diversità?
Credo che tra questi due aspetti non ci sia una contraddizione inconciliabile. I tedeschi si mostravano accoglienti con i rifugiati perché erano scampati a condizioni terrificanti che rendevano doveroso aiutarli, mentre i greci erano stati dipinti in maniera martellante come il cugino dalle mani bucate, quasi affetto da un vizio incurabile come il gioco d’azzardo, e per quanto malridotto uno così cercherà sempre di sfruttarti e fregarti. Nessuno, naturalmente, aveva loro spiegato che il paragone tra la brava casalinga sveva e il truffaldino fannullone mediterraneo non era soltanto estratto dal vecchio baule dei trucchi nazionalistici, ma era anche scorrettissimo sotto un profilo meno vistoso: non si può far finta che le relazioni tra due entità statali, pur descrivibili con precisione aritmetica nei termini del rapporto debitore-creditore, siano assimilabili a quelli che intercorrono tra due persone singole e private. Una volta accettato che quella semplificazione populistica è ormai passata nelle menti, la tipicità tedesca rimane iscritta in una minor disposizione a passar sopra alle altrui scorrettezze, vere o presunte: sì, saranno più rigidi, cocciutamente convinti di essere nel giusto, dunque meno capaci di godersi la vita come viene ecc., ma sentirsi il pollo da spennare non garba molto a nessuno.
L’aspetto centrale che Buffoni mette a fuoco con il suo sguardo di poeta-citoyen, qui soprattutto cittadino di un’Europa di cui non ha amato solo l’idea ma anche diversi uomini in carne e ossa (il che non nuoce mai all’idealismo), è che la Germania e i suoi abitanti si trovino oggi ad affrontare un inedito passaggio d’identità e di ruolo. Non sono più i tedeschi di una volta, i fanatici conquistatori e aguzzini, ma non sono nemmeno più coloro che vissero nella consapevolezza storica della colpa collettiva per il nazismo. Questi tedeschi odierni pensano di aver espiato il loro debito morale, e quindi si sentono sin troppo a proprio agio come creditore che non deve più far sconti a nessuno. Questi tedeschi che hanno riscoperto l’orgoglio nazionale vedendosi come primi della classe, sono però gli stessi che con spontaneità sincera hanno trovato intollerabile che degli esseri umani fuggiti dalla guerra potessero naufragare in mare o, peggio, ammassarsi dietro al filo spinato: anche questo è espressione di un sentimento nazionale positivo, non più imbrigliato dal senso di colpa. I volti dei tedeschi fotografati lo dicono con l’evidenza d’un dato di fatto, una naturalezza gioiosa e serena: benvenuti da noi che non siamo più uguali ai nostri nonni.
Purtroppo le immagini rincuoranti dallo Hauptbahnhof di Monaco non costituiscono il finale del dramma europeo e tedesco a cui stiamo assistendo. I confini sono stati chiusi dalla signora Merkel con una decisione altrettanto non concordata con i partner europei come era stata quella di aprirli. Una parte del merito di quella svolta è stata rivendicata dal premier bavarese – nonché alleato dell’Unione cristiano-democratica al governo – il quale apertis verbis ha detto che la valanga di profughi concentrata nella capitale bavarese avrebbe danneggiato lo svolgimento tranquillo e proficuo dell’Oktoberfest. Il coro di critiche che ha scatenato è sintetizzato in un hashtag, #Oktoberfestung, conio capace di riassumere la trasformazione di una città – e quindi di una nazione e infine di un intero continente – in una fortezza arroccata a difesa di interessi gretti e miopi. Sembra aver prevalso quest’Europa che per regola intende qualcosa che non oltrepassa l’orizzonte di un ragioniere, per cui gli esseri umani vanno considerati alla stregua delle quote latte o dell’omologazione dei Tetrapak. Eppure la crisi dei profughi ha mostrato che persino in Germania, dove Angela Merkel viene un giorno raffigurata come un redivivo Cancelliere di Ferro, un altro come novella Madre Teresa, esiste ormai una scollatura ragguardevole tra rappresentanza politica e cittadini: in questo caso a favore della generosa capacità d’azione dei numerosissimi tedeschi improvvisatisi soccorritori volontari.
Chissà sino a che punto quel rapporto già non così armonioso tra il paese e la politica ha subito il contraccolpo del più recente scandalo, la truffa gigantesca della Volkswagen? Noi europei di serie B, che lo abbiamo accolto con malcelata Schadenfreude, non ci rendiamo ancora conto della dimensione del disastro. Il governo tedesco ha dichiarato di esserne stato all’oscuro e di essersi sempre impegnato molto per la difesa dell’ambiente, mancando prima di tutto di parola nei confronti dei propri cittadini intossicati dai motori diesel. In più, la Germania ha elevato a modello l’eccellenza della sua produzione industriale, fondando la legittimità a esercitare un ruolo egemone in Europa sulla sua meritata supremazia come grande nazione esportatrice. Con la Volkswagen è crollato un mito: quello di un modello dove tutti lavorano con onestà ed efficienza, producono cose solide e utili, all’avanguardia sotto il profilo ecologico e tecnologico, e non l’immorale ricchezza delle transazioni finanziarie svolte in un universo parallelo, smaterializzato, autoreferenziale e per questo quasi incontrollabile. Forse la prima profetica avvisaglia di tale crollo può essere ravvisata nel disastro dell’aereo Germanwings guidato da Andreas Lubitz, la cui sinistra figura è convocata anche nelle pagine di questo libro.
«Già hai dato il meglio, non strafare», chiede Buffoni nel verso finale di Oggi che la Germania, poesia in cui «la meticolosità nell’efficienza» rima con «nevrosi da obbedienza». Qualcosa che andava oltre la nevrosi affliggeva anche il pilota suicida, qualcosa d’inconciliabile con l’efficienza intesa come norma e valore sommo al quale uniformarsi. è in questo che ha strafatto la Germania, finendo in una compulsione a primeggiare e nella fiducia accanita di farcela sempre. Non avrà causato la deriva estrema di Andreas Lubitz, ma forse ha favorito il ricorso all’inganno per fingersi conformi a quegli standard. Vale per gli individui, come per le imprese, e in qualche modo per la Germania stessa, la condizione riassunta in una parola intraducibile che definisce chi non riesce a essere all’altezza di una richiesta perentoria: überfordert.
Guidata dalla figlia di un pastore luterano cresciuta nella DDR, la Germania ha creduto di poter interpretare il liberismo trionfante del dopo-muro in una versione neo-weberiana dove, rigettato tutto ciò che sapeva di socialista e persino di troppo socialdemocratico, bastavano a temperare lo spirito rapace del capitalismo l’etica protestante secolarizzata e l’altrettanto tradizionale senso dello Stato. Eppure il potere sul mercato globale dei grandi attori economici è diventato così grande che quello politico stenta a esercitare la sua funzione di contenimento salvaguardando quanto basta la propria costituiva indipendenza. E questo avviene in Germania sia perseguendo – sino al rischio di destabilizzare l’intera Europa – la tutela delle proprie banche, sia rimanendo forse l’ultima nazione a non introdurre il limite di velocità generalizzato sulle proprie autostrade, anomalia paradossale per la nazione “verde” su cui pesano l’influenza e il prestigio del settore auto. Il problema tocca la Germania per l’effetto mistificatorio della propria autorappresentazione come modello equilibrato di competitività e rispetto delle regole, ma lo trascende nella sostanza; potrebbe insegnarcelo proprio lo scandalo della multinazionale con sede a Wolfsburg, che di tedesco ha soprattutto l’abuso di fiducia richiesta in nome dell’affidabilità teutonica.
Così è curioso rendersi conto come la questione profughi e il caso Volkswagen in fondo ci ricordino entrambi che siamo sulla stessa barca. E se non vogliamo allargare la prospettiva al mondo interno, come in fondo dovremmo fare, sarebbe il caso di riconoscere il tratto accomunante almeno per l’Europa. Quell’Europa sempre più irta di frontiere alzate tra i paesi membri, quell’Europa guidata da una Germania überfordert su un diesel taroccato, di cui però, negato ogni altro mezzo di trasporto, gli stranieri in marcia sui propri miseri veicoli da bipedi hanno sventolato la bandiera scandendo «Deutschland, Deutschland»: il nome di quella che nel corso delle loro fughe si sono figurati come la terra promessa.
Helena Janeczek